David Bowie- Fantastic voyage – Francesco Donadio
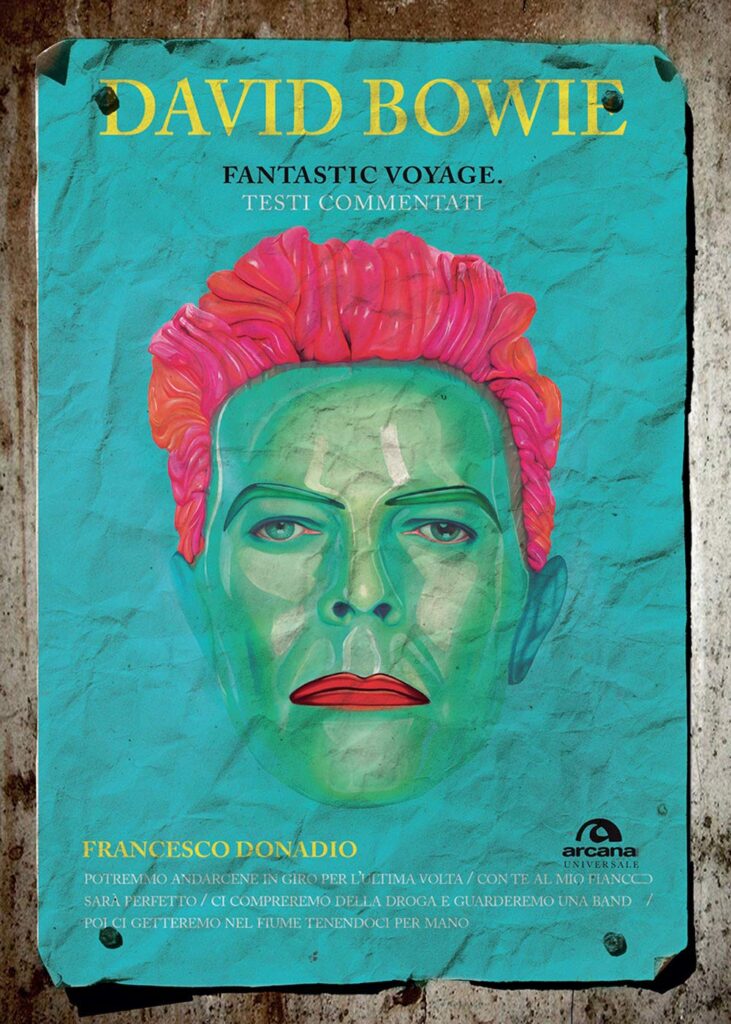
SINTESI DEL LIBRO:
All’inizio non avevo idea di come si scrivesse una canzone
e non ero neanche particolarmente bravo a farlo.
Mi sono imposto di diventare un buon autore di canzoni
e alla fine ci sono riuscito, ma non avevo qualsivoglia talento
naturale:
ho dovuto lavorare sodo per diventare bravo.
E l’unica maniera che avevo per imparare era vedere
come facevano gli altri. Non ero uno di quei tipi
che sono usciti dall’utero fatti e finiti come Marc [Bolan]”.
David Bowie a Paul Du Noyer di «Mojo» nel 2002
Non è per niente banale diventare David Bowie, rockstar
internazionale androgina, se ti chiami David Robert Jones e provieni
dalla grigia periferia di Bromley nei dintorni di Londra. Anche perché
all’inizio David non possedeva altro che una sfrenata ambizione, la
voglia di emulare le gesta di Elvis Presley e Little Richard e, non
ultima, una impellente necessità di tagliare i ponti con un ambiente
familiare mediocre e alienante. Le esibizioni con il suo primo gruppo,
il
complessino locale dei Konrads, gli servirono come primo utile
apprendistato. Ma nel 1964, a diciassette anni, David è già a Londra,
in teoria per lavorare come junior visualizer all’agenzia di pubblicità
Nevin D. Hirst, ma poi principalmente per immergersi nella scena
mod della capitale del Regno che, in preda al boom economico e
all’esplosione dei Beatles, era diventata “swinging” e piena di
opportunità per teenager irrequieti e ambiziosi come lui.
Sono due anni, quelli tra il ’64 e il ’66, in cui David (che si
autoribattezza Bowie per non essere confuso con l’omonimo
membro dei Monkees) si dà assai da fare, sostenuto da un’energia e
da una spregiudicatezza che hanno pochi pari. Dà vita a gruppi, di
cui è leader, uno dopo l’altro (i King Bees, i Manish Boys, i Lower
Third, The Buzz), scrive le prime canzoni, tiene concerti, fa qualche
comparsata in tv e incide vari 45 giri (sei in tutto, per un totale di 12
facciate). Tutto inutile, però. Bowie non sfonda e resta al palo, uno
sconosciuto tra tanti in una Londra che brulica di talenti e di aspiranti
star. Conta, certamente, che non abbia ancora un manager di serie
A, ma anche il fatto che le canzoni che ha composto finora non siano
particolarmente buone né originali. Bowie non ha ancora maturato
un proprio stile e per il momento si limita a copiare. Il primo brano a
sua firma mai apparso su vinile, Take My Tip (lato B di IPity The Fool
con i Manish Boys, marzo 1965) imita lo stile pop-swing di Mose
Allison, anche se la lirica, il consiglio di un leader mod, ovvero di un
“face”, a uno dei suoi seguaci, ossia un “number”, su come
conquistare una ragazza (“Devi comportarti da fico, pensa in grande
se vuoi lasciare il segno su di lei. Devi giocare d’anticipo, rimedia
una macchina e dei vestiti eleganti, altrimenti lei ti scaricherà”) già
prefigura una tendenza a gettare fumo negli occhi interpretando una
parte a seconda delle circostanze.
Da buon mod, Bowie copia soprattutto dagli Small Faces, dagli
Who, dai Kinks e dal suono Motown, come risulta chiaro ascoltando
brani come You’ve Got A Habit Of Leaving, Baby Loves That Way,
Can’t Help Thinking About Me, And I Say To Myself, Do Anything
You Say, Good Morning Girl, I Dig Everything e I’m Not Losing
Sleep. Can’t Help Thinking About Me, pubblicata nel gennaio ’66 con
i
Lower Third, è la più interessante del mazzo, sia musicalmente
(Little Steven, quello della E Street Band, la considera uno dei
migliori brani “garage” del periodo e la trasmette spesso al suo
programma radiofonico) che a livello testuale, un inno
all’egocentrismo dove Bowie lascia intravedere quali e quanti
problemi gli creasse vivere nella provinciale Bromley insieme a
mamma e papà: “Sembra che io abbia macchiato il nome della mia
famiglia” (forse a causa delle sue ambizioni bohémien o al fatto di
portare i capelli lunghi fino alle spalle). “Mia madre dice che non ce
la fa a sopportare le chiacchiere dei vicini. Devo fare le valigie,
abbandonare questa casa, yeah…”. La riproporrà al programma
televisivo MTV Storytellers del 1999, non prima però di avere
candidamente confessato di vergognarsi a morte di due versi del
brano ritenuti tra i più orridi e banali della sua carriera: “La mia
ragazza mi chiama: ciao Dave, fai un salto, ci vediamo in giro, torna
da me se ripassi di qua”. In realtà avrebbe scritto cose di gran lunga
peggiori negli anni Ottanta. Glass Spider, ovviamente. Ma non solo.
Difficile quindi, sulla base di queste prime prove giovanili, attribuire
a Bowie un talento singolare e fuori dalla media. È necessario perciò
rendere il giusto merito a Kenneth Pitt, il già affermato manager che
quando lo vide per la prima volta nel ’66 al Marquee Club di Londra
ne scorse subito le potenzialità e che per i successivi quattro anni ne
seguì e pilotò la carriera. Pitt assecondò la già latente passione di
Bowie per il teatro e per il cabaret, “dirottandolo” dal rhythm’n’blues e
dal rock’n’-roll, ma in realtà ampliandogli gli orizzonti, in una modalità
alla Pigmalione. Nel mentre, gli trovò anche un contratto discografico
con l’etichetta Deram, sussidiaria della potente Decca, comprensivo
dell’accordo per l’uscita di un intero Lp in cui Bowie avrebbe potuto
dimostrare tutta la sua natura di eclettico.
E nel frattempo, dopo tanto provare e riprovare (e imitare), Bowie
era riuscito a scrivere una canzone di livello, London Boys: il primo
brano che per qualità e personalità può essere considerato degno di
rientrare a pieno titolo nel più vasto canone bowiano. Una prima
versione di London Boys era stata incisa nel novembre 1965 con i
Lower Third, ma la Pye, loro etichetta dell’epoca, l’aveva riposta nel
cassetto, ritenendo che alcuni versi riferiti all’assunzione di
anfetamine fossero inopportuni e inadatti a passare per radio. Il 18
ottobre del ’66, facendo fronte all’esigenza di realizzare un provino
per la Deram, Bowie reincise il brano, stavolta con l’assistenza di
Dek Fearnley della sua ultima band, The Buzz, che si occupò di
curare gli arrangiamenti orchestrali. La versione incisa quel giorno
agli RG Jones Studios di Londra, e che fu pubblicata tale e quale
come lato B del suo primo singolo per la Deram, è un gioiellino di
cantautorato orchestrale, raffinato e intenso, anche per via
dell’interpretazione vocale, per la prima volta riconoscibile, seppure
in nuce, come alla Bowie.
Su London Boys, utilizza con successo uno stile di storytelling
lineare alla Ray Davies dei Kinks – una tecnica che di lì a un paio
d’anni abbandonerà quasi del tutto – raccontando la vicenda assai
autobiografica di un ragazzo di diciassette anni che ha abbandonato
i
genitori e la vita dei sobborghi tentato dalle luci della metropoli
(Bright Lights Big City è il titolo del classico R&B di Jimmy Reed che
Bowie certamente conosceva, quantomeno nella versione degli
Animals). Vive in uno squallido bedsit, gli fanno male gli arti
(presumibilmente per il freddo) e non può neanche prepararsi la
colazione perché gli hanno tagliato il gas, ma all’inizio il gioco pare
valere la candela.
Bright lights, Soho, Wardour Street You hope you make friends
With the guys that you meet Somebody shows you round Now
you’ve met the London boys Things seem good again,
Someone cares about you Luci brillanti, Soho, Wardour Street
Speri di farti degli amici
Con i tipi che incontri
Qualcuno ti accompagna a fare un giro Ora hai incontrato i
ragazzi di Londra Sembra che le cose vadano di nuovo bene
Qualcuno tiene a te
L’ambito è quello dei mod, la sottocultura inglese degli anni
Sessanta alla quale Bowie aderiva convintamente, anche a giudicare
dalle sue foto di quel periodo in cui per taglio di capelli e abiti non
aveva nulla da invidiare ai vari Pete Townshend e Steve Marriott,
leader riconosciuti della scena. I ragazzi Mods avevano fatto
dell’edonismo uno stile di vita e passavano il tempo nei locali in cui si
suonava dal vivo il loro amato R&B, come il Marquee di Wardour
Street, ovvero agli allnighters, serate dove si poteva ballare tutta la
notte sotto l’effetto di pasticche di anfetamina.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :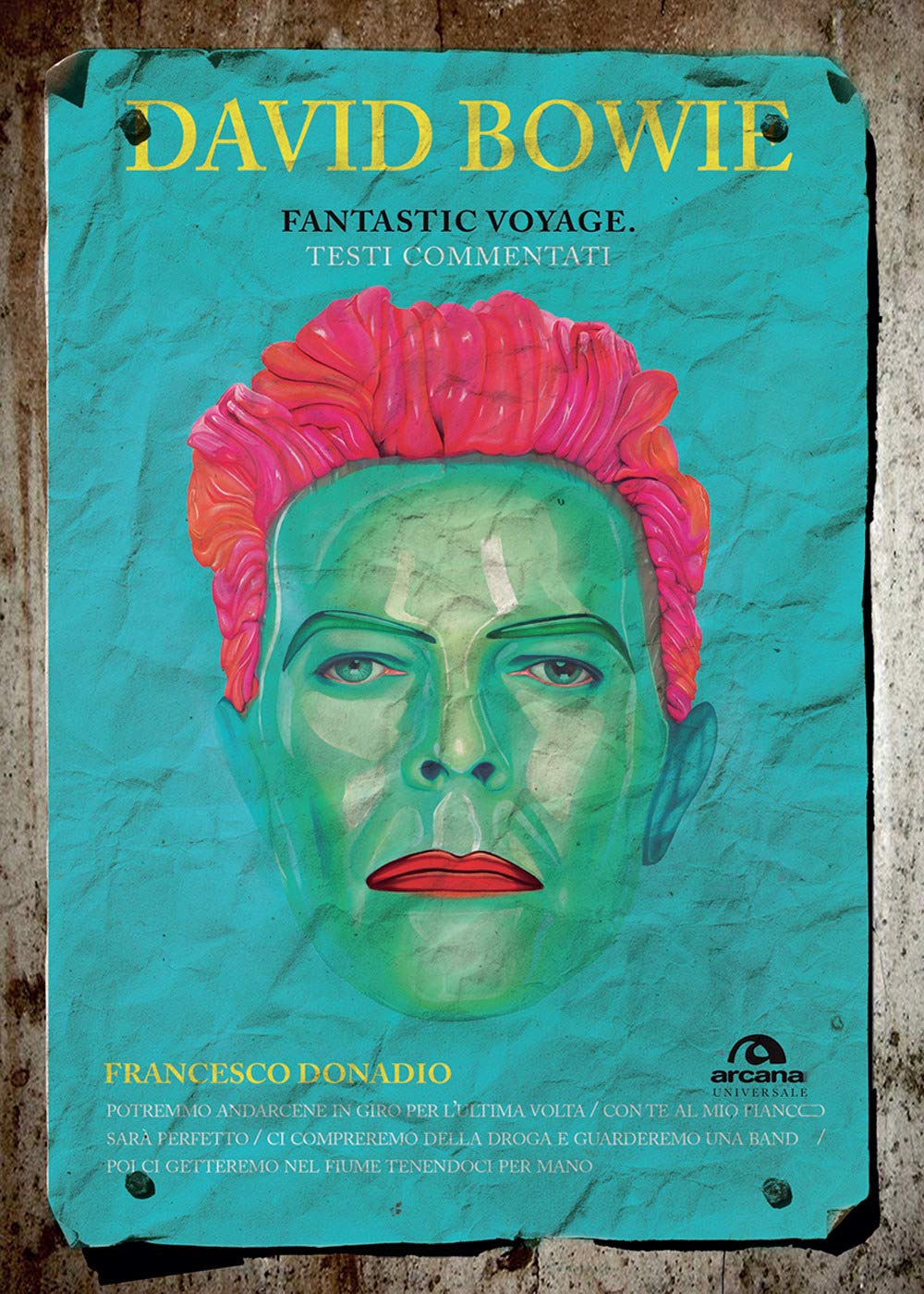





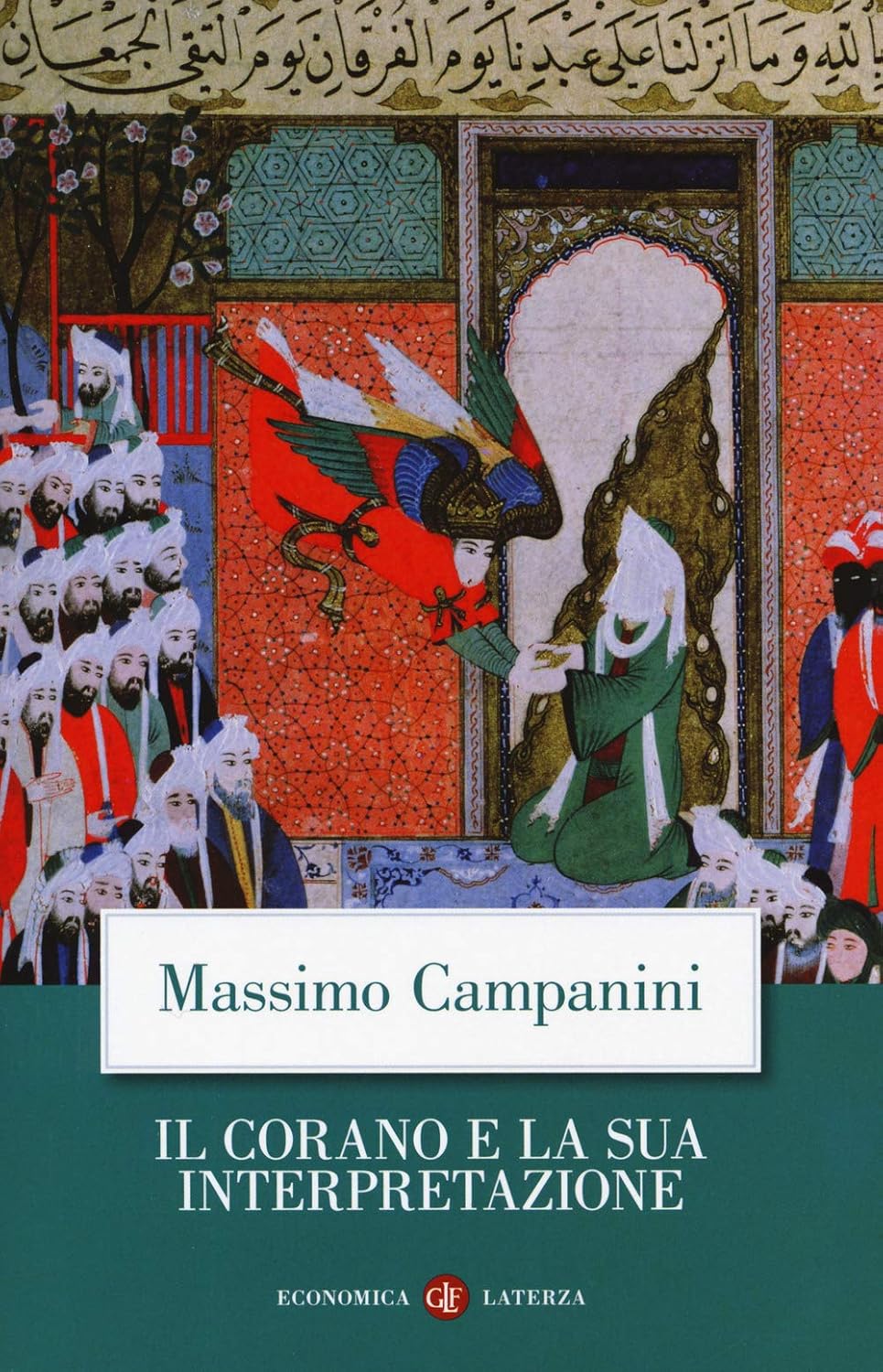
Commento all'articolo