Sulle rotte di Ulisse – Lorenzo Braccesi
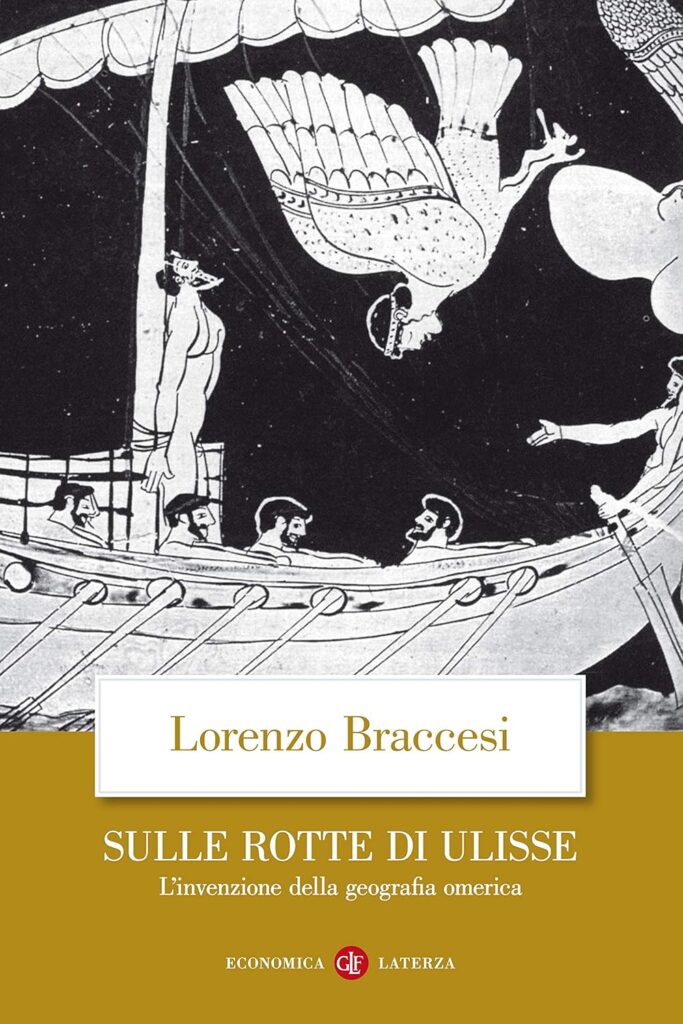
SINTESI DEL LIBRO:
Affrontando il problema della geografia occidentale dell’Odissea, tra Italia
e Sicilia, non intendiamo riaprire la vexata quaestio dell’identificazione
materiale, sul terreno, delle località che furono teatro delle avventure di
Ulisse. Su questo problema si sono cimentati in molti senza mai giungere
ad alcuna concreta soluzione; ed è, questa, di fatto, impresa impossibile,
dato che il nostro testo dell’Odissea appare quasi intenzionalmente
‘ripulito’ da qualsiasi pure lieve indizio atto ad ancorarne il teatro di
azione in siti geograficamente individuabili.
Ma indagheremo qui sulla nazionalità dei primi coloni greci che, a
nostro avviso, possono avere dato impulso alla più nota localizzazione
‘occidentale’ della geografia dell’Odissea. La quale – per doviziosa
segnalazione dei commentatori antichi – è quella che identifica l’isola dei
Feaci con Corcira; che ubica i gorghi mostruosi di Scilla e di Cariddi
nello stretto di Messina; che localizza il pascolo dei buoi del Sole
nell’angolo nord-orientale della Sicilia; che colloca in area
immediatamente limitrofa, presso l’Etna, le caverne dei Ciclopi e, presso
Leontini, le sedi dei Lestrigoni; che indica nell’arcipelago delle Lipari il
regno di Eolo, signore dei venti; che pone i recessi delle Sirene presso gli
scogli antistanti il promontorio di Sorrento; che riconosce nel
comprensorio dei Campi Flegrei, presso il lago di Averno, il sito dove
risiedono i Cimmeri; che fissa nel medesimo luogo il nekyomanteîon dove
Ulisse incontra Tiresia e interroga le anime dei defunti; che, infine,
stabilisce presso l’omonimo promontorio la terra dove la maga Circe ha la
sua splendida dimora.
Orbene, tutte queste località sono interessate, in forma marcata, a
fondazioni, o comunque a frequentazioni commerciali, da parte dei Greci
di età arcaica protagonisti della grandiosa colonizzazione nei mari
dell’occidente. La quale, infatti, si snoda esattamente sulle medesime rotte
che – nella localizzazione occidentale dell’Odissea – sarebbero state
percorse da Ulisse, che diviene così il vero e proprio precursore di tutti i
mercanti o navigatori o colonizzatori che hanno solcato le acque della
nostra penisola. Riandando con la mente alle località dell’occidente dove
gli antichi localizzano il teatro delle sue avventure, riaffiorano alla
memoria dati notissimi in ambito di storia delle frequentazioni coloniali;
dati documentari che, in forma introduttiva, non sarà inopportuno
richiamare all’attenzione del lettore (fig. 1).
Fig. 1. La colonizzazione greca in Italia e Sicilia
Corcira, l’isola dei Feaci, prima ancora di divenire un’importantissima
colonia corinzia, conosce un insediamento di Eubei di Eretria. Chi ne
possiede il controllo domina, di fatto, già da età arcaica, sulle vie di
accesso all’occidente, sia ionico sia adriatico.
Lo stretto di Messina, dove sono i gorghi di Scilla e di Cariddi, ospita
sulle sue sponde le colonie di Rhegion e di Zancle, fondate per
intraprendenza degli Eubei di Calcide, i quali così si assicurano il
controllo del braccio di mare che è porta di accesso allo spazio tirrenico.
Il comprensorio nord-orientale della Sicilia, località del pascolo dei buoi
del Sole, nonché territorio di insediamento dei Ciclopi e dei Lestrigoni,
ospita ancora, a sud di Zancle, le colonie di Nasso, di Leontini e di
Catania. Le prime due sono fondazioni degli Eubei di Calcide; la terza,
Catania, è una subcolonia di Nasso.
L’isola di Lipari, dove è la reggia di Eolo, il dio che domina
sull’omonimo arcipelago, è area di tarda colonizzazione da parte di Cnidî
e di Rodî. Ma è anche una terra che presenta tracce vistosissime di
frequentazioni più arcaiche, nonché terra che, in ogni caso, non può
considerarsi disgiunta dagli stessi interessi commerciali che portano gli
Eubei/Calcidesi di Zancle a fondare la subcolonia di Mile sull’omonimo
promontorio siciliano, da sempre proiettato su Lipari e sul suo arcipelago.
Il promontorio di Sorrento, che si affaccia sugli scogli delle Sirene, e il
comprensorio dei Campi Flegrei, che ospita i Cimmeri e si apre ai recessi
degli Inferi, delimitano a meridione e a settentrione il golfo di Napoli;
golfo che è sede dei più antichi insediamenti ellenici stanziati in
occidente: Pitecussa nell’isola omonima e Cuma nella limitrofa
terraferma, o ‘perea’. L’emporio di Pitecussa – il più antico stanziamento
greco in occidente – è frequentato e potenziato dagli Eubei di Calcide e
di Eretria già nella prima metà dell’VIII secolo. La colonia di Cuma è
dedotta poco appresso dagli Eubei/Calcidesi. Sua subcolonia sarà Napoli,
almeno limitatamente al suo più arcaico insediamento.
Il promontorio Circeo, legato al nome della maga Circe, non ospita
insediamenti greci, ma è pur sempre in area di influenza calcidese;
gravitante, come è, su Cuma e sulle direttrici del suo più immediato
espansionismo territoriale in area settentrionale.
2. Esiodo e la geografia occidentale dell’«Odissea»
La geografia tradizionale dell’Odissea si lega dunque ad alcune delle aree
dell’occidente che sono teatro di intensa attività coloniale tanto in Italia
quanto in Sicilia. Ma quando nasce una tale codificazione occidentale del
grande poema omerico? A quale livello cronologico possiamo ancorarla?
È un luogo comune affermare che essa in linea di massima sia tarda,
dovuta, in tutto o in parte, al lavoro di tavolino degli eruditi alessandrini.
Ma le cose stanno altrimenti. Infatti, la localizzazione occidentale delle
avventure di Ulisse è già ampiamente vulgata in età classica, come
testimonia lo storico Tucidide che conosce l’identificazione di Scheria
con Corcira (1, 25, 4); che ubica nello stretto di Messina i gorghi di Scilla
e di Cariddi (4, 24, 5); che localizza in Sicilia la sede di Ciclopi e di
Lestrigoni (6, 2, 1); che, infine, definisce le Lipari isole di Eolo (3, 88, 1).
Ma c’è assai di più. Tucidide, almeno in un caso, ci permette di risalire a
livelli cronologici sicuramente molto più alti. Interrogandosi su un
ipotetico stanziamento di Ciclopi e di Lestrigoni in terra di Sicilia, egli
infatti ci dice che sul loro conto «ci si deve accontentare di quello che
hanno cantato i poeti», cioè akreít
ō
de
ō
s poi
ē
taîs te eír
ē
tai. Ma chi sono
questi poeti? Non certo i rapsodi omerici che nulla sanno di una
localizzazione siciliana di Ciclopi e di Lestrigoni, bensì «poeti» loro
posteriori. Esiste quindi un livello cronologico, che è intermedio tra
Omero e Tucidide, nel quale un cantore, un poi
ē
t
ḗ
s, localizza in Sicilia il
territorio di questi primordiali selvaggi. Un poi
ē
t
ḗ
s cui oggi, con tutta
tranquillità, possiamo attribuire il nome di Esiodo! Questi (fr. 150 M.
W.), infatti, come testimonia un mutilo papiro, nomina i Lestrigoni in un
contesto dove pure si menziona l’isola siracusana di Ortigia e una
montagna scoscesa e dirupata facilmente identificabile con l’Etna.
Assai probabilmente è proprio nell’età di Esiodo, intorno alla prima
metà del VII secolo, e quindi nell’età stessa della colonizzazione arcaica,
che si elabora la prima codificazione scritta della geografia occidentale
dell’Odissea; ovviamente sulla base di una tradizione orale sicuramente già
vulgata da almeno qualche generazione. Ne riscopriamo, in Esiodo, un
altro importantissimo indizio nella chiusa della Teogonia; dove il poeta
ricorda che dall’unione di Ulisse con Circe sarebbero nati due figli, Agrio
e Latino, i cui nomi, senza ombra di dubbio, ci riconducono ad ambito
etrusco-laziale.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :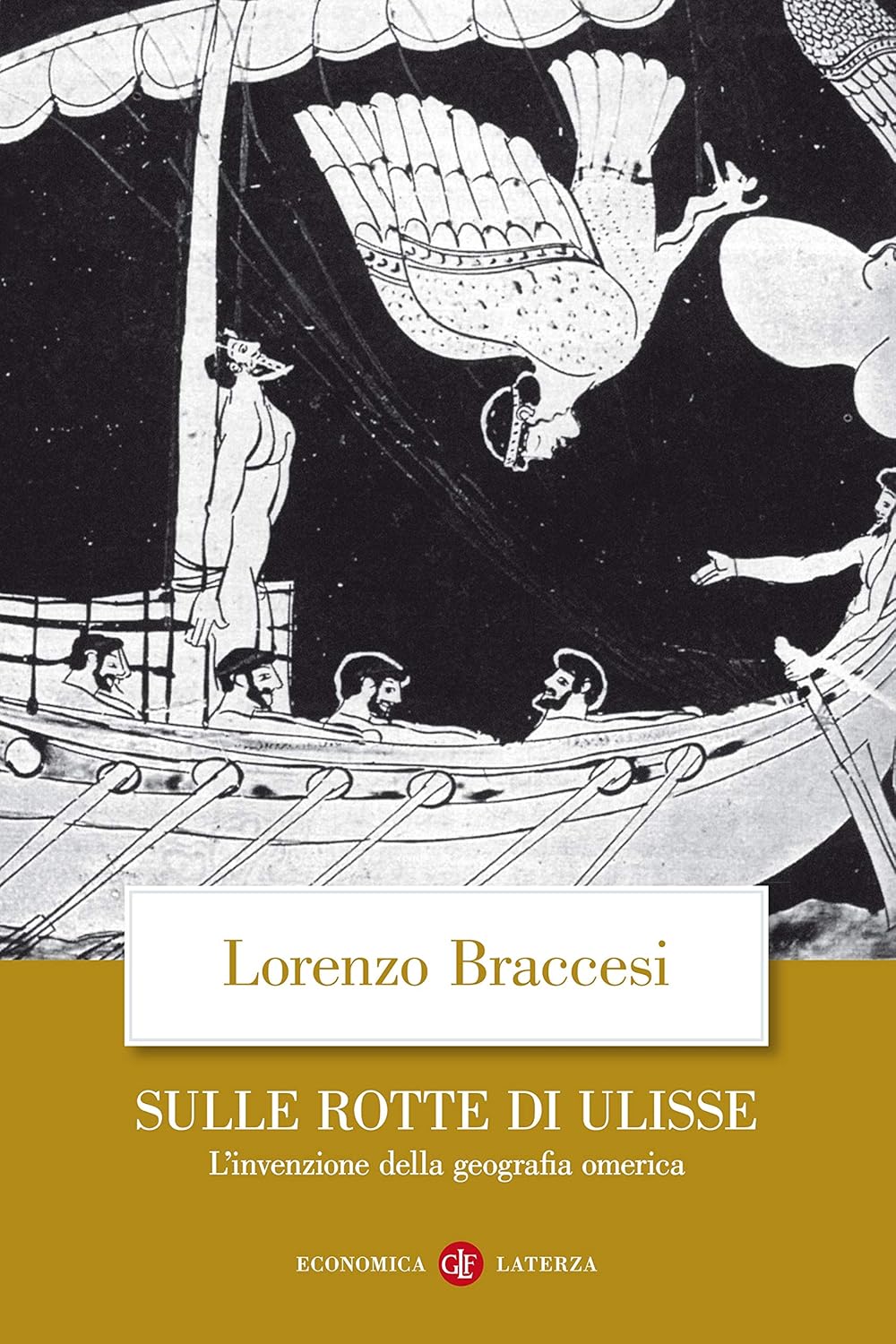






Commento all'articolo