Questione di virgole- Punteggiare rapido e accorto – Leonardo Giovanni Luccone
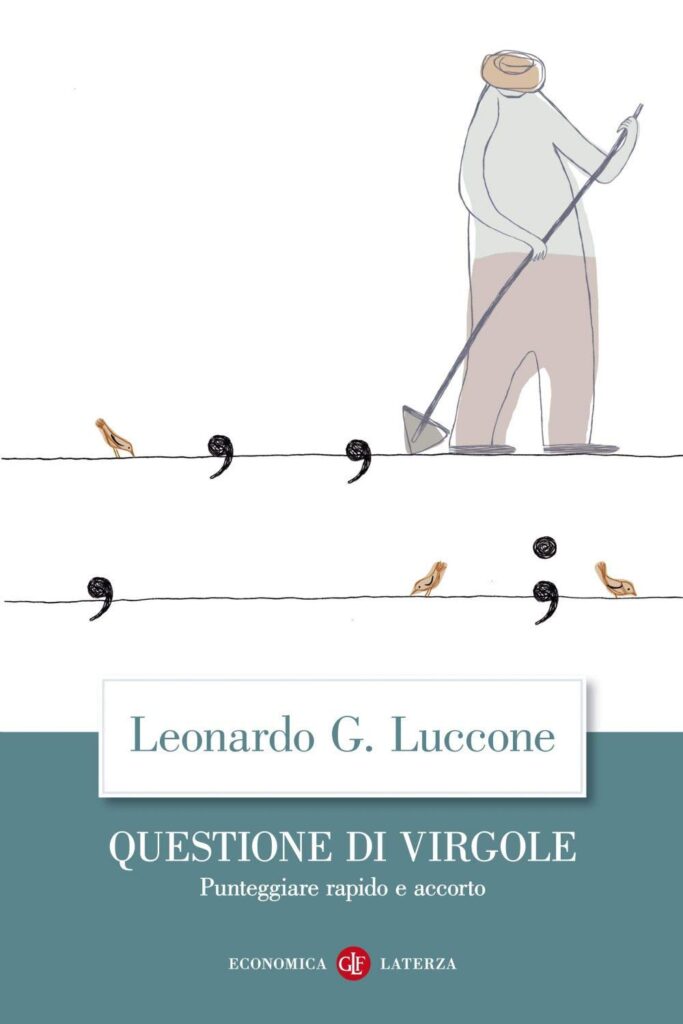
SINTESI DEL LIBRO:
Ve lo dico subito: c’è un verso che mi ha folgorato quando
avevo tredici anni:
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia.
Sì, parliamo di Dante, quinto canto dell’Inferno, quello di
Paolo e Francesca.
La versione che avevo io si presentava proprio come la
vedete. Credo sia il verso più bello di tutti i tempi.
Sentite come suona statuario, con quell’avverbio fantastico.
Come si sta orribilmente? E poi quella virgola seguita dalla
congiunzione e dal verbo.
Minos sta lì in tutto il suo orrore e, tanto per mettere le cose
in chiaro, ringhia.
Nella versione del mio compagno di banco Gianluca c’era
scritto:
Stavvi Minòs, orribilmente, e ringhia.
È sempre un bellissimo verso, ma – lo capivo già allora
non è la stessa cosa. Per me è importante che
quell’«orribilmente» si incateni per bene a «stavvi», e non
che lo segua ingabbiato tra due virgole.
Ma nella testa di Dante come suonava?
Come forse sapete, quelle che leggiamo non sono le virgole
di Dante: purtroppo non abbiamo autografi. E quindi chi
cavolo ce le ha messe quelle virgole (e tutti gli altri segni che
troviamo nella Commedia)? perché abbiamo due versioni del
mio verso preferito?
È chiaro a tutti che il senso cambia, e nemmeno di poco?
Insomma, con un semplice segnetto in più si rischia di
rovinare tutto.
Se vi fa impressione che non sapremo mai come Dante
abbia punteggiato la sua Commedia, come ci rimanete se vi
dico che gli antichi Romani non usavano la punteggiatura?
Guardate l’iscrizione della Colonna traiana, che, tra l’altro,
segna l’inizio della tipografia come la conosciamo oggi.
Avete di fronte agli occhi una scritta bellissima – che entra
nel marmo; sentite ancora il frusciare del pennello grondante
pece che scivola sulla pietra; sentite lo scalpellino che
sottrae la materia al blocco. Guardatela, e ammirate la
splendida diversità delle lettere.
Ecco: le lettere sono attaccate l’una all’altra, più o meno alla
stessa distanza. Non ci sono virgole, non ci sono punti, non
ci sono frasi, periodi, proposizioni.
Avvicinatevi ancora e vi accorgerete che a dividere le parole
ci sono dei puntini più o meno a metà altezza. Ma ripeto: non
c’è punteggiatura. Come facevano i Romani a scandire bene
le parole, le frasi per capirne bene il senso?
Come facevano a orientarsi?
Con la testa accesa, la mente connessa: con la logica, e
grazie al naturale appoggiare delle parole.
La verità, vi prego, su scrittura e lettura
Si scrive di più, questo è certo. Si scrive di più, tutti. Merito,
per molti discutibile, dei messaggi di testo che scandiscono
le nostre giornate. La comunicazione scritta è succinta, ma è
continua, continuamente differita, rimandata. C’è sempre la
possibilità di precisare.
Più scrittura vuol dire più consapevolezza. Quando si scrive
si affronta la difficoltà comunicativa, la necessità di sintesi e
quella di trovare le parole giuste, il tono più adatto (aiutati
oramai dagli indicatori di emozione, le emoticon, che servono
a sinestetizzare il messaggio).
Si scrive di più e si legge di più, sempre grazie ai device (gli
smartphone, i tablet e più in generale l’accesso alla rete). È
una lettura non particolarmente pregiata, chiaro, che sta
erodendo l’autorità della stampa periodica e l’idea stessa di
editoria.
Se da un lato si registra un passo in avanti nelle
competenze linguistiche minime da parte dello strato meno
alfabetizzato (gli stessi individui che qualche anno fa non
avrebbero letto né scritto quotidianamente), dall’altro si
attesta un impoverimento delle letture negli strati medi e alti.
La frammentata ma continua (spesso convulsa) fruizione
attraverso gli smartphone sottrae tempo alle forme più
tradizionali dell’informazione e dell’arricchimento (lettura di
libri, riviste eccetera).
Dal punto di vista della scrittura il miglioramento si riverbera
sia sulla capacità complessiva sia su aspetti più specifici
come l’ampiezza del lessico e la conoscenza dell’ortografia.
La situazione rimane però grave.
C’è da dire, di contro, che nella maggior parte dei casi gli
errori ortografici e lessicali non compromettono la fruizione
basilare del contenuto.
Perché accanirsi su ortografia e punteggiatura, allora?
Perché punteggiatura e ortografia sono l’abito che fa il
monaco, sono il condimento che fa il primo piatto, sono una
vasta parte dell’essenziale. Se la sintassi è quella porzione
della lingua che incatena il contenuto al pensiero e lo rende
organicamente espresso, la punteggiatura rappresenta il
segno del comando; e l’ortografia è la capacità di stare al
mondo.
Il contenuto deve fluire liscio, senza rumore, senza subire
disturbi.
Una cattiva punteggiatura rende un testo come una strada
accidentata. Certo che la si può percorrere, specie se si ha
un fuoristrada, ma perché sobbalzare a ogni buca? Perché
procedere con il rischio di rimanere in panne?
Ve la do io la punteggiatura
Perché imparare a usare bene la punteggiatura? Si vive
benissimo senza, si vive benissimo senza usare bene il
punto e virgola, anzi si sta da dio usando perfino male il solo
punto e la sola virgola.
La verità è baricentrica a tre atteggiamenti contrastanti:
considerare la punteggiatura qualcosa di così personale da
non sentire la necessità di regole (una legittima espressione
di sé, quindi non attaccabile, non negoziabile); considerare la
punteggiatura null’altro che un elemento decorativo; sentire
la necessità di un sistema condiviso di segni ordinatori.
Non giriamoci intorno: la punteggiatura è una parte tangibile
della scrittura. La punteggiatura è il quadro dove sta il testo;
minimizzando, è la cornice comprensiva dei chiodi che
tengono la scrittura alla parete.
Sentite questa storiella: c’è uno scrittore di grande talento
visivo ma del tutto incapace di usare la punteggiatura.
Appena ha finito il suo romanzo, chiama il suo editor e gli
dice: «Senti, l’ho scritto sul tablet, tutto in minuscolo, e la
punteggiatura non l’ho proprio messa, pensaci tu». L’editor
gli risponde: «Sarebbe più facile se mi avessi mandato solo
la punteggiatura corretta, senza le parole».
Questo per dire che nelle scritture che funzionano la
punteggiatura è incastonata nel contenuto e, naturalmente,
che una cattiva punteggiatura corrode il contenuto.
Vediamola da un altro punto di vista. La punteggiatura sta in
mezzo alle parole, ok, ma a che serve?
Ci sono persone convinte che le virgole vadano usate
quando è bene fare una pausa. Malissimo!, è così che questi
segnetti-formichina finiscono nei posti più impensabili.
Non c’è dubbio che l’aspetto emotivo della lettura abbia la
sua parte, ma non si possono distribuire le virgole a seconda
del fiato. C’è chi parla di «relativismo interpuntivo», cioè si fa
un po’ come si vuole. Punteggiamo a orecchio, a occhio, a
sensazione, e quindi bye bye sistema condiviso. Un po’
come due persone distanti migliaia di chilometri che
comunicano con il codice Morse senza conoscerlo bene.
Allora a che serve la punteggiatura? A guidarci nella selva
delle parole? A marcare i periodi? A enfatizzare le cose più
importanti?
Ci arriveremo per gradi. Intanto, a proposito di selve,
rileggiamo insieme uno dei passi più belli della letteratura
degli ultimi duecento anni. Vi chiedo la pazienza di arrivare
fino in fondo. Godetevi la magnificenza della prosa e
l’imperiosità della punteggiatura.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :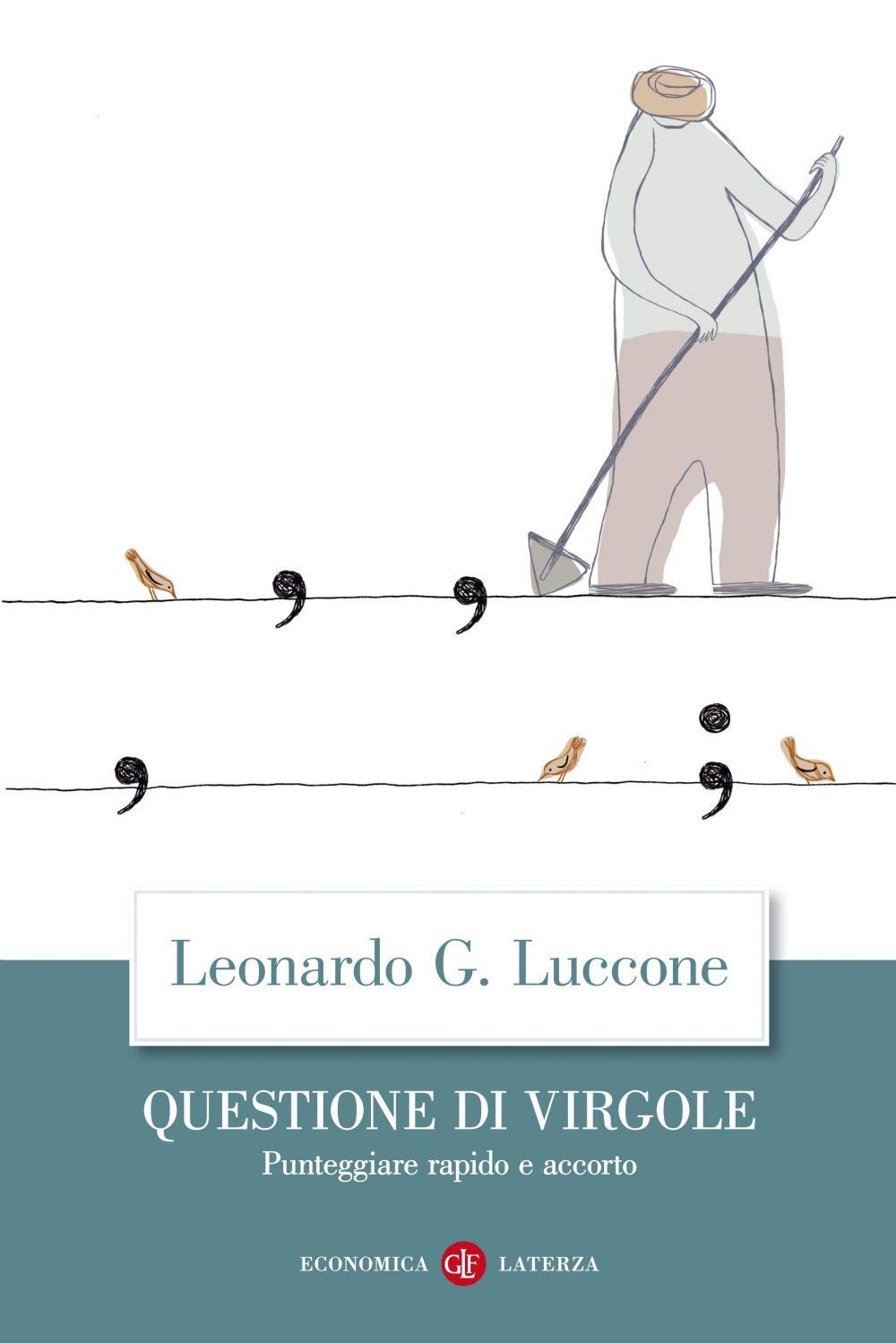






Commento all'articolo