Oltre la legalità – Paolo Grossi
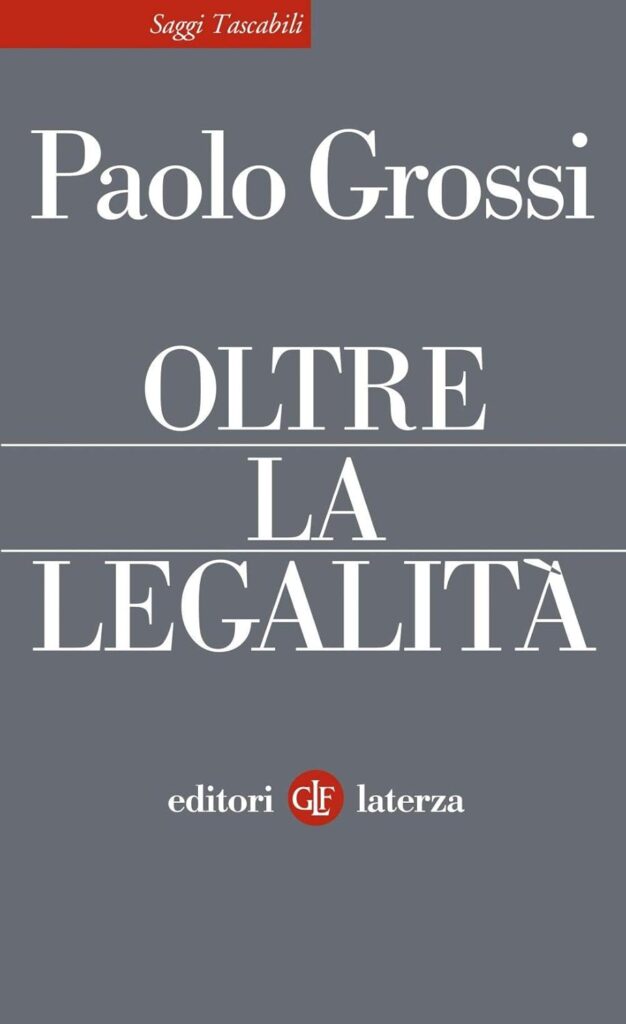
SINTESI DEL LIBRO:
Credo che sia giunta l’ora di una indispensabile revisione dei due pilastri
che la cultura politico-giuridica del Settecento ha, nell’Occidente
continentale europeo, offerto allo Stato ottocentesco, troppo
ottimisticamente chiamato ‘Stato di diritto’ (Rechtsstaat)4: la separazione
dei poteri e il principio di legalità. Ed è proprio in questa orientazione
che va interpretato il titolo che l’autore ha voluto, Oltre la legalità, titolo
probabilmente per molti provocatorio e per taluni addirittura oltraggioso
di certezze radicate nel sacrario di una dimensione etica. Certamente, c’è
in esso il rifiuto fermo di ogni sentiero che possa condurre verso la deriva
della ‘illegalità’, ma, al tempo stesso, vuole esser chiaro in esso il segno di
una schietta insofferenza per come, hic et nunc, noi – generalmente – si
riafferma il principio della separazione dei poteri quale dogma intangibile
e, quindi, indiscutibile, e ci si sta comportando con la legalità
attualizzando fino al giorno d’oggi, senza alcuna variazione, un fossile
settecentesco, quasi che fosse un carbone capace di dare attualmente lo
stesso calore, malgrado il gran tempo trascorso, malgrado gli enormi
eventi che la vicenda storica ha dovuto registrare in un paese di civil law
come l’Italia, malgrado le decisive novazioni nel nostro approccio con il
diritto.
I due pilastri, nella loro genesi settecentesca, avevano delle fondazioni
così salde da risultare incontestabili. Frutto di scienziati e politici
‘illuminati’, si proponevano come delle verità sottoposte non a discussione
o problematizzazione, bensì a una prona credenza. Si origina qui quella
mitizzazione5 che si trascina stancamente fino ad oggi, ma che è senza
dubbio accolta con fervore dalla pigrizia intellettuale di parecchi odierni
giuristi beatamente immersi nelle appaganti certezze (o ritenute tali, o
presunte tali) del pianeta giuridico di civil law. Conviene cominciare col
porre attenzione alla rigida e irrigidente impronta settecentesca.
Con la separazione dei poteri si volle creare arginamenti ai poteri del
Principe moderno, che pretendeva di assommare in sé legiferazione
governo giurisdizione. In un secolo che viveva la caoticità delle estreme
ramificazioni del pluralismo giuridico medievale6 e, nello stesso tempo,
un acceso ottimismo riguardo alle capacità regolative del Principe,
l’indirizzo separatorio offriva garanzie formali al cittadino ma si
concretizzava altresì in una consistente strategia: sottraeva a giudici e
sapienti ogni coinvolgimento nel processo produttivo del diritto,
consegnàndolo interamente alla volontà del titolare del supremo potere
politico.
A sua volta, il principio di legalità rappresentava una integrazione
necessaria al fine di compiere quello che è veridico chiamare un autentico
‘assolutismo giuridico’. Infatti, la invenzione del diritto7 era sottratta al
particolarismo
consuetudinario
strettamente
connesso
alla
frammentatissima empiria dei fatti e, ugualmente, a giudici notai sapienti,
che sempre di più avevano assunto il ruolo di leggere interpretare definire
tecnicamente il complesso e variegato materiale consuetudinario. Ormai,
il nuovo diritto – specchio dell’età dei Lumi – doveva disdegnare una
genesi dal basso: non più di invenzione doveva trattarsi8, ma di regole
generali e astratte, progettate da una volontà suprema e tali da evitare il
condizionamento da parte dei fatti; pertanto, sì generali e astratte ma
anche rigide. E la inflessibilità del nuovo diritto si contrapponeva alla
elasticità del vecchio ius commune9. Un solco profondo si veniva a creare
fra diritto e società. Assai pernicioso perché causa di un marcato
inaridimento.
È apprezzabile franchezza ammetterlo: molti, tra noi giuristi, sono
ancora i proseliti del verbo illuministico, destinatarii e, in certo modo,
anche vittime del messaggio forte dell’Illuminismo settecentesco. Un
messaggio in cui spiccava la rivalutazione (consistente in una
ipervalutazione) del titolare del potere politico, cui veniva convintamente
affidato il ruolo della produzione di tutto il diritto10.
Non dimentichiamo che, fino al secolo XVIII (come si accennava
all’inizio), quel ruolo era nelle mani dei giuristi – cioè di coloro che
sapevano di diritto e che, in quanto tali, potevano offrire garanzie di
competenza tecnica e di una conseguente imparzialità –, particolarmente
dei grandi dottrinarii maestri nelle università disseminate in tutto il
continente, ma anche di giudici notai avvocati. Tutto era nato in quel
secolo XII11 in cui l’esperienza medievale ci propone un paesaggio socio
politico-giuridico di un diritto senza Stato, senza organismi politici
totalizzanti e omnicomprensivi12, paesaggio che si trascina poi per inerzia
anche durante i primi secoli della modernità, quando – a cominciare dal
Regno di Francia – gli Stati emergono in modo sempre più vigoroso
affermando, in sempre maggiore progressione, un proprio protagonismo,
ossia facendosi sempre più legislatori, facitori del diritto.
Nel secolo dei Lumi, al termine di un itinerario plurisecolare, si era
arrivati alla situazione paradossale di un diritto comune (quello dei
giuristi) diventato un cùmulo enorme di opinioni, sentenze, pratiche
consuetudinarie, incertissimo perché caotico, in presenza di Stati assoluti
dove il Principe era in grado di sostituirsi (e tendeva a farlo) con alcuni
immediati risultati da raggiungere modellando l’ordine giuridico dall’alto
del potere supremo: una sicura unitarietà e, quindi, una sicura coerenza;
la sua facile riduzione a sistema con le apprezzabili qualità della chiarezza
e della certezza; la sua perfetta controllabilità perché ormai inglobato
nell’orbita del potere politico.
Nasce qui, in questo fertile Settecento, l’icona del Principe come
modello di uomo, immune dalle passioni umane di cui sono facili prede il
sapiente e il giudice13, e, quindi, come modello di una imparzialità
conseguente alla sua assoluta superiorità, capace – ripetiàmolo pure,
perché si tratta di una convinzione fondativa – di produrre un diritto che,
provenendo dalla volontà di un solo soggetto, non potrà che essere
saldamente compatto. Avrebbe in ciò riflesso la compattezza della
struttura politica, un bene da salvarsi ad ogni costo con il rifiuto più netto
all’interno dello Stato di ogni rischiosissima articolazione comunitaria14;
resta, in basso, alla società il non-ruolo di piattaforma meramente passiva.
Nasce qui quella sfiducia nella dottrina e nel ceto giudiziario – di cui è
testimone in Italia, a metà Settecento, il libello virulento ma efficace di
Muratori contro i ‘difetti della giurisprudenza’15 – che è calata e riposa
ancora nel nostro animo (e, forse, più nel nostro cuore) di giuristi odierni
in un paese di civil law, rendendo alterata e viziata la nostra valutazione di
viventi e operanti in un frangente storico tanto diverso (e, ohimè, perciò
tanto bisognevole di non avere dei paraocchi prefabbricati trecento anni fa
e totalmente inadatti).
Ovviamente, i ‘Lumi’, con la ipervalutazione del Principe, furono
portatori della ipervalutazione della legge e del principio di legalità come
totale conformità a quella; principio che, così immedesimato, non
dovrebbe poter restare ancora tra le convinzioni più ferme di tanti giuristi
e sul quale ormai è stato deposto un fardello di luoghi comuni, dei quali è
sperabile che ci si sbarazzi quanto prima per costruire qualcosa di
veramente nuovo, invece di ribiascicare decrepiti e inutili ritornelli. A ciò
vorrebbe, pur nella sua modestia, contribuire questa lezione.
2. Quella illuministica fu, nella storia del diritto continentale europeo,
una rivoluzione di grande rilievo, anche perché, pienamente confermata
dai giacobini francesi, si trasformò nel programma giuridico del nuovo
Stato moderno nelle sue varie epifanie. Si trattava di un formidabile
riduzionismo, formidabile perché, consegnando il diritto nelle mani di un
solo soggetto, lo rendeva straordinariamente compatto, certo ed
efficiente. Il risultato più vistoso fu in Francia (e, poi, dappertutto) la
codificazione del diritto attuata dal despota Napoleone, ma che è ben
segnata tra i primi auspicii della stessa Rivoluzione16. Si progettano le
linee di una fonte novissima, il Codice, nuova per i contenuti che si
vogliono dare a questo arcivecchio vocabolo17: la riduzione, pensata e
attuata in alto, di una intiera branca dell’ordine giuridico in una
dettagliatissima quantità di disposizioni composte in un armonico
sistema.
Ciò a cominciare da quel ‘diritto civile’ concernente le relazioni private
fra soggetti privati, lasciato intatto dai legislatori dell’antico regime18 e
affrontato decisamente dal legislatore napoleonico, espressione di quel
potere borghese che esige la protezione massima per le proprietà
individuali, per la loro libera circolazione, per la loro trasmissione mortis
causa. Il diritto civile è – inevitabilmente – il primo ad essere codificato e,
malgrado che costituisca la disciplina dei quotidiani fatti di vita del
cittadino, è voluto e redatto quale disciplina meta-temporale, immessa in
categorie astratte immuni dalla fangosità dei fatti e destinate a durare (se
non per l’eternità) almeno per un futuro indefinito. Ora, 1804, lo si può
fare, perché ormai la Francia pos-rivoluzionaria è uno Stato unitario e
centralizzato assolutamente distante, come puntualizza efficacemente
Portalis nel suo celebre discorso inaugurale, da quella ‘société de sociétés’
in cui si incarnava la vecchia monarchia borbonica19.
Il riduzionismo, a livello di una rinnovata sistemazione delle fonti, si
traduce in una ferrea gerarchizzazione20, che riduce a una mera parvenza il
mantenimento formale di una pluralità. Infatti, solo la fonte situata sul
sommo gradino gerarchico, la legge, rappresenta una volontà
indipendente e incondizionata chiamata a condizionare tutte le altre fonti
dei gradini inferiori ridotte a una semplice ancillarità. È una verità, questa,
che non è discutibile e che, purtroppo, dopo la Costituzione troviamo
dommaticamente affermata nelle Preleggi al Codice Civile del 1942,
ultima reliquia durevole nell’ordinamento italiano – anche se oggi
soltanto formale – di un regime autoritario.
Un solo ordinamento può qualificarsi come giuridico, ed è lo Stato,
titolare del supremo potere politico; ed è la volontà dello Stato – la legge– che è norma per eccellenza. Il diritto si identifica in un crea tivo atto di
volontà21, in un comando che deve essere obbedito. In questa visione
rigorosamente monistica non può che imporsi il principio di legalità, inteso
nel senso più costrittivo (e al di là dello specifico riferimento ai rapporti
tra politica e amministrazione), l’unico senso che gli si può dare in un
universo giuridico che tiene a identificarsi nella legge. Una legge – si badi– che non è la lex di cui parla san Tommaso quasi novecento anni prima,
una ordinatio rationis22, un ordinamento della ragione, un atto cognitivo,
una lettura dell’assetto sociale che rinviene nella suprema autorità politica
soltanto l’organo affidatario della solenne proclamazione23; piuttosto, una
legge che è il comando strettamente collegato ad una situazione di potere,
proiettato dall’alto verso il basso della società con la pretesa ineludibile
dell’obbedienza.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :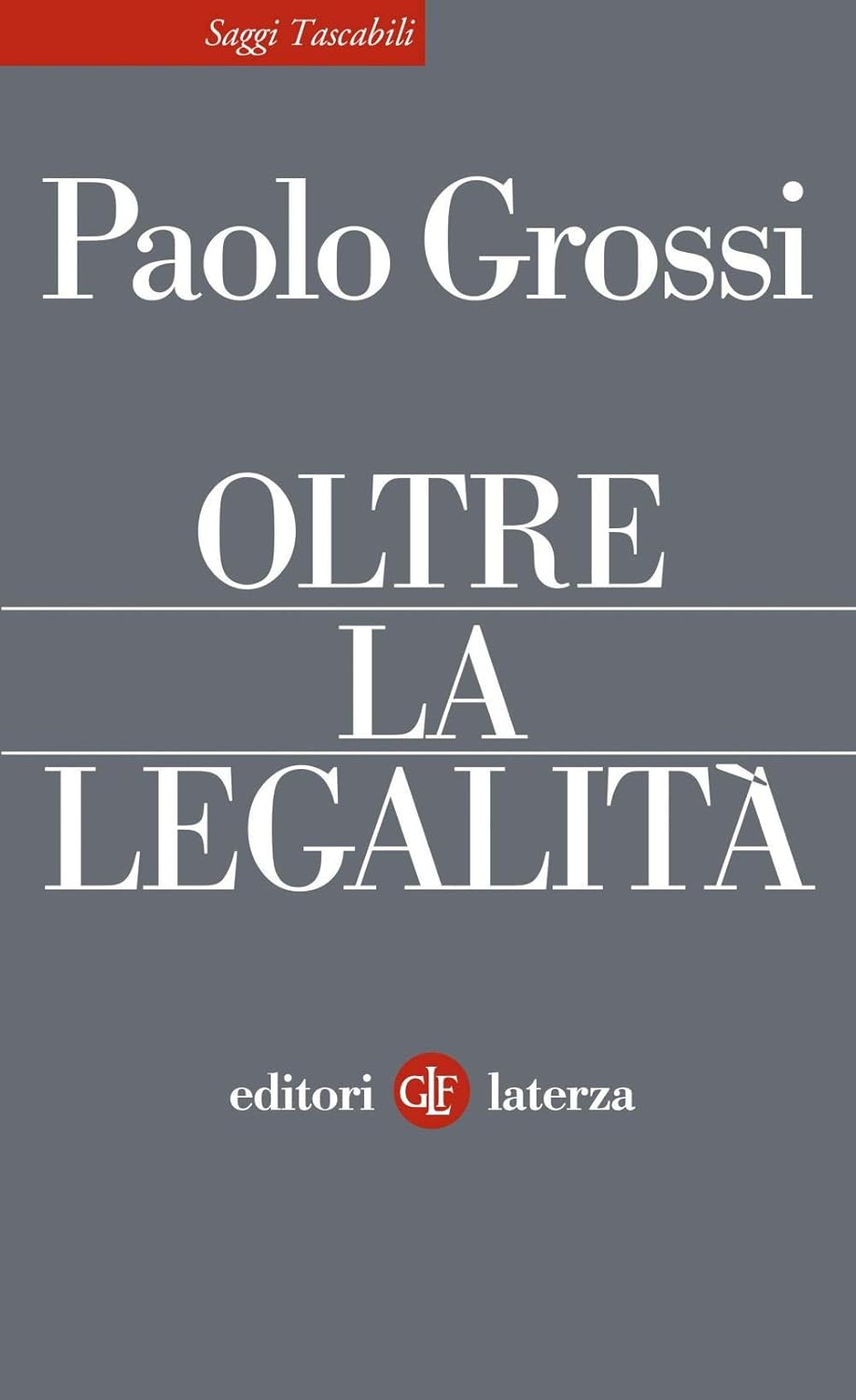






Commento all'articolo