La menzogna del cinema – Giuseppe Tornatore
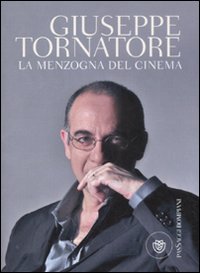
SINTESI DEL LIBRO:
“Sempre più spesso, ricordare non significa richiamare alla mente
una storia, bensì essere in grado di evocare un’immagine.” Mi piace
iniziare la mia riflessione sul cinema di Giuseppe Tornatore con
questa frase, tratta dal libro Davanti al dolore degli altri di Susan
Sontag. Mi piace iniziare così perché credo che il cinema di
Tornatore abbia come tema ossessivo e ricorrente proprio questo: il
ruolo delle immagini – e delle immagini filmiche in particolare
nell’esercizio della memoria e nei processi di costruzione
dell’immaginario individuale e collettivo. Ora: che le immagini
svolgano una funzione imprescindibile nei processi di elaborazione e
di estrinsecazione della memoria non è una scoperta dell’età
moderna né, tanto meno, un’invenzione di Giuseppe Tornatore. Tra
immagini e memoria c’è un legame profondo, antico, forse perfino
ontologico. La mia convinzione è che il cinema di Tornatore lavori
prima di tutto su questo legame. Parafrasando Aristotele, che
considerava l’anima una collezione di ritratti dipinti, si potrebbe dire
che per Tornatore l’anima del nostro tempo è una collezione di ritratti
filmati, di immagini filmiche, da intendere però non come semplici
supporti su cui si conservano tracce di esperienze sensibili, ma
come strumenti di mediazione fra la realtà e l’immaginazione.
Il cinema – ci dice con tutti i suoi film Giuseppe Tornatore – non è
uno dei tanti elementi costitutivi della cultura del Novecento. Il
cinema è la cultura del Novecento, tout court.
E lo è a dispetto di quegli autorevoli esponenti del mondo politico
e giornalistico che ancora poche settimane fa proclamavano con
tronfia sicurezza l’estraneità del cinema alla cultura. Tornatore – e
credo che dobbiamo essergli tutti grati per questo – ha speso la sua
vita per sostenere il contrario, e per dimostrarci e ricordarci che il
cinema è il dispositivo in cui convergono le pratiche, i discorsi, i
linguaggi, i segni, i codici e gli alfabeti attraverso cui il Novecento ha
rappresentato se stesso ai soggetti e agli sguardi che l’hanno
abitato. Non c’è film in cui Giuseppe Tornatore non racconti il cinema
e non individui nel guardare il gesto politico più importante e centrale
di tutta la modernità. Ho detto gesto politico: il che può voler dire che
a volte è un gesto etico, altre volte estetico, altre ancora erotico o
filosofico, ma è comunque politico perché sempre ha a che fare con
il modo in cui gli uomini e le donne del Novecento vivono gli uni con
gli altri, o gli uni accanto agli altri, o gli uni contro gli altri.
Prendete Baarìa. Come fa il protagonista Peppino a vincere la
diffidenza della famiglia e l’ostilità dell’ambiente e a sposare la
donna che ama? Dove trova il modello culturale a cui ispirare il suo
comportamento quotidiano?
Nella scuola? Nella chiesa? Nel partito? Assolutamente no. La
scuola, quelli come lui, quelli che rompono le gerarchie e i codici
dominanti, quelli che stanno fuori dal coro, li mette in castigo dietro
la lavagna e li lascia lì, in ibernazione sociale, anche per decenni. La
chiesa? Men che meno. La chiesa a Bagheria è aniconica se non
addirittura iconoclasta, e fa ricoprire con una mano pesante di
calcina bianca un affresco sulla cupola della chiesa in cui i ritratti
consentono processi di identificazione troppo forte nei fedeli. Il
partito, allora? È il Partito comunista che offre a Peppino una cultura
per emanciparsi? Nemmeno per sogno. Il partito caso mai aiuta
Peppino a mettere a fuoco lo sguardo sul grande mondo attraverso il
viaggio “terribile” – così lo definisce lui stesso – in Unione Sovietica,
ma non lo aiuta a risolvere i suoi problemi affettivi ed esistenziali.
Peppino Torrenuova i suoi problemi li risolve andando al cinema. È
vedendo Girandola di Mark Sandrich, con Fred Astaire, che Peppino
capisce come deve agire. E agisce.
Nella modernità novecentesca, il cinema opera nei film di
Tornatore come un grande dispositivo modellizzante: insegna a
coloro che non dispongono di altri mezzi, di altri linguaggi, di altri
poteri, come vivere nel mondo. Nel piccolo paese siciliano in cui si
svolge Nuovo cinema Paradiso, ad esempio, il cinema insegna a
baciare, e il suo insegnamento è tanto contagioso e scandaloso che
il
parroco deve provvedere a censurare proprio le scene di bacio
sforbiciando fisicamente la pellicola di celluloide. A Realzisa,
l’immaginario borgo siciliano in cui inizia L’uomo delle stelle, succede
l’opposto: basta fingere che ci sia una macchina da presa e che
questa stia filmando, come fa credere l’imbroglione interpretato da
Sergio Castellitto, che organizza falsi provini senza pellicola nel rullo
della macchina da presa, basta far sentire l’occhio del cinema sul
mondo, perché il mondo si riveli, e perché gli uomini inizino a parlare
e a raccontarsi, e perché tutti sentano il bisogno di rappresentarsi,
come per lasciare una traccia di sé dentro il grande sogno del
cinema, cinema che è anche qui epifania e rivelazione della vita.
Tutti i personaggi di Tornatore sono iconofagi. Sono avidi e golosi
di
immagini. Le divorano, le inglobano, le digeriscono, le
metabolizzano. A volte, sono addirittura degli archivisti del visibile
filmico. Lo è, ad esempio, il ragazzino di Baarìa, che colleziona
frammenti di pellicola di celluloide (da Gli argonauti a Italiani brava
gente, da Catene a Salvatore Giuliano) con la stessa giocosa avidità
con cui altri ragazzini, cultori di un altro epos, collezionano figurine di
calciatori, e riconosce i film da un solo fotogramma, come un file
vivente, un archivio organico di memorie visive in cui l’esperienza
vissuta prende senso e luce dalla sua capacità di connettersi con i
fantasmi e con le ombre filmiche che l’hanno modellizzata.
Fra tutti i film di Tornatore, quello in cui questa funzione formativa
e performativa del cinema risulta drammaturgicamente più evidente
è con ogni probabilità Malèna, film aspro e dolcigno come il nome
sincopato della protagonista, come certi frutti troppo maturi, o certi
dolci siciliani deliziosamente e peccaminosamente iperglicemici.
Ambientato tra la fine degli anni trenta e la prima metà degli anni
quaranta nell’immaginaria cittadina siciliana di Castelcutò, Malèna
racconta l’iniziazione erotica ed esistenziale di un adolescente timido
e acerbo che si invaghisce della donna più bella del paese e grazie a
lei – grazie alle immagini rubate osservandola sfacciatamente
quando cammina per la strada o spiandola di nascosto mentre si
aggira sensuale nella penombra della sua casa – elabora le
fantasticherie e i sogni a occhi aperti che lo aiutano a crescere e a
diventare uomo.
Oltre a spiare Malèna, il ragazzino protagonista va continuamente
al cinema, e si abbandona al sogno. Qualunque cosa veda sullo
schermo, a lui appare sempre e solo Malèna, di volta in volta nei
panni della pupa del gangster, della fidanzata di Tarzan o
dell’avventuriera di Ombre rosse. Come un erede di Germi andato a
lezione da Fellini, Tornatore continua a raccontarci (vuole continuare
a raccontarci) com’eran belle l’infanzia e l’adolescenza quando c’era
il cinema a farle sognare.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




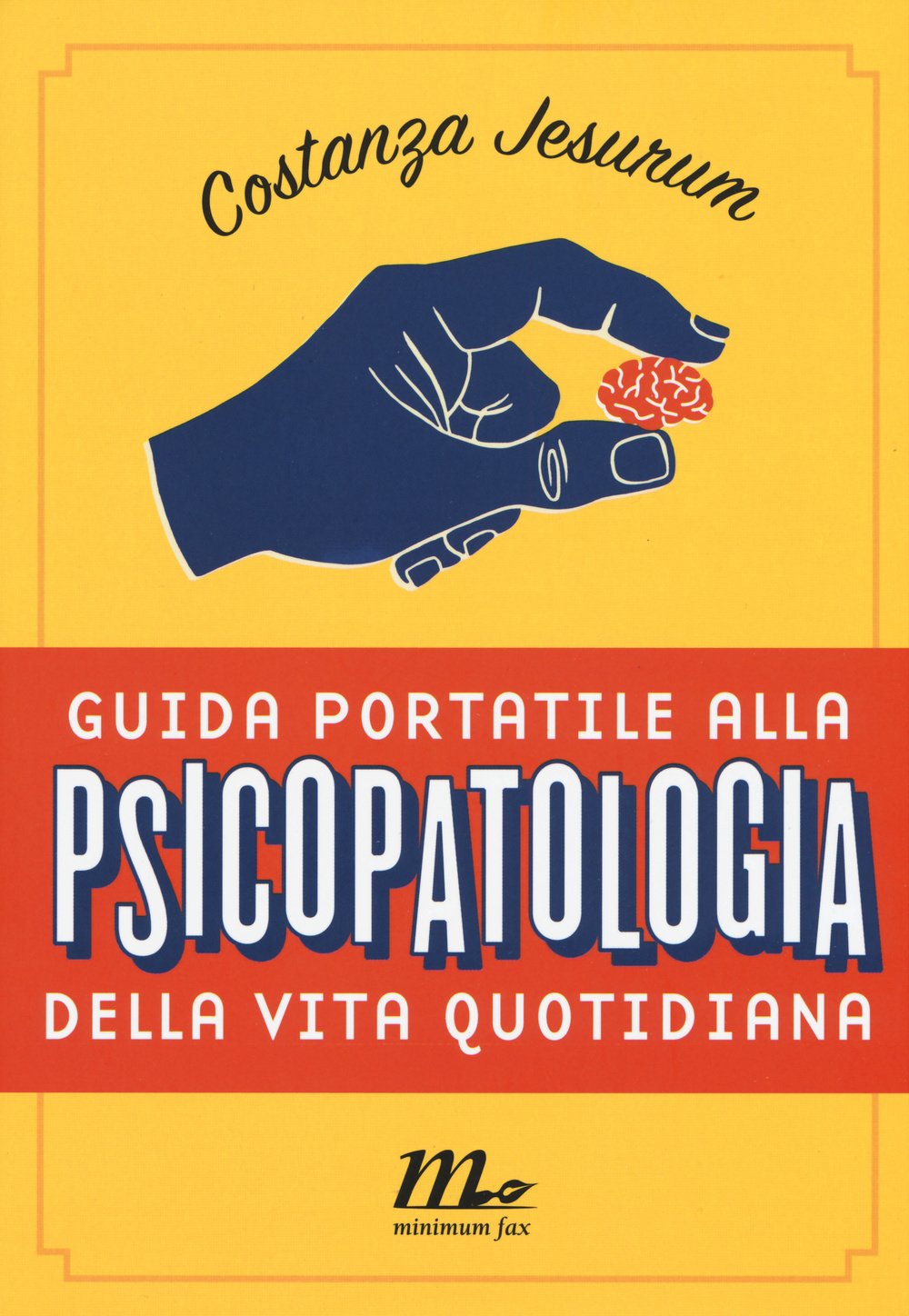
Commento all'articolo