La malattia del mondo – In cerca della cura per il nostro tempo – Francesco Borgonovo
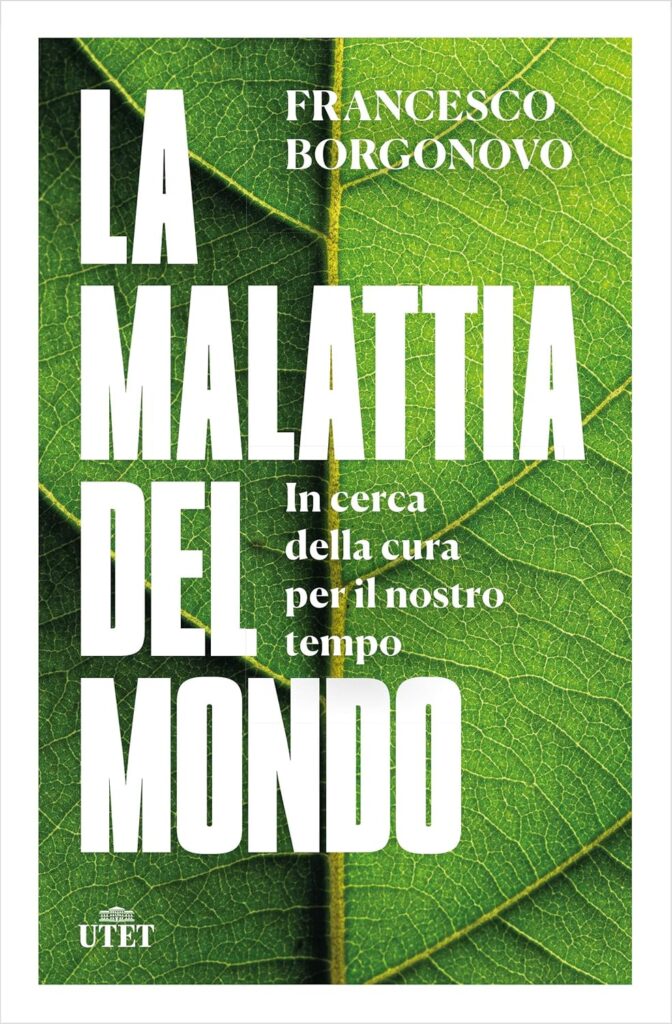
SINTESI DEL LIBRO:
Cominciamo a comprendere, allora, che non è (solo) “colpa della
Cina”. La diffusione della Peste contemporanea è avvinghiata alle
dinamiche della globalizzazione, ne accompagna la trionfale marcia
di morte. Una marcia che ha un nome antico e terribile, proveniente
non dalle oscurità cinesi ma dalle profondità del pensiero greco:
hybris. La tracotanza dei libri di liceo, certo, ma anche la
«dismisura», come la definisce il filosofo francese Olivier Rey.
Questa dismisura è la cifra del nostro presente e del nostro passato
recente e recentissimo. La Malattia, dunque, non è soltanto la Sars:
è la hybris, una dismisura che indica, per dirla con Jean Clair,
«l’abbandono all’orgoglio, agli eccessi sessuali, alle pulsioni
criminali». La hybris, su cui torneremo in seguito, è prima di tutto
superamento del limite, del confine. E se ci pensate, l’intera storia
dell’epidemia di Covid-19 (esattamente come la storia della
globalizzazione) è una faccenda di confini varcati e limiti infranti.
Il coronavirus origina, prima di tutto, dal superamento di un limite
umano: invece di convivere il più armoniosamente possibile con le
altre forze del creato, l’uomo va a provocarle come se fosse il loro
padrone. Il contadino e l’allevatore cinesi pressati dall’avanzata delle
grandi aziende si addentrano nella giungla, varcano il confine tra la
luce e l’oscurità. Costretti, commettono peccato di hybris e
scatenano la forza letale di nemesis, che della tracotanza è mortifera
conseguenza. Della natura noi uomini siamo, al massimo, i custodi,
come rivela il libro della Genesi. Quando veniamo meno al nostro
ruolo, o quando tentiamo di farci “creatori” sostituendoci al
“Creatore”, allora scateniamo l’epidemia, la pestilenza biblica. Che
non è, intendiamoci, un castigo divino. Sarebbe, di nuovo, troppo
semplice cavarsela così: no, la pestilenza è tutta di fabbricazione
umana, ce la siamo cercata e prodotta da soli quando – privati degli
antichi, attenti rapporti con la natura selvatica – siamo andati a
cercarne di nuovi, costruiti però sul piano del consumo, della
predazione e del piacere. Abbiamo pensato di poter dominare la
natura, vessandola e derubandola, credendo che tutto ciò non
avesse conseguenze.
Siamo noi i responsabili del diluvio che ci ha colpito. È molto
suggestiva, a questo proposito, la lettura del cataclisma biblico
fornita dalla teologa Teresa Bartolomei nel saggio Dove abita la
luce?. «In nessun’altra epoca storica», scrive la studiosa, «l’uomo ha
raggiunto il grado di potenza tecnica, economica e demografica che
lo mette oggi in condizione non più semplicemente di dominare la
Terra, ma di distruggerla. Con l’Antropocene, l’umanità è divenuta
fattore
“geologico” di modellamento – ed eventualmente
deturpazione fino alla devastazione irreversibile – dell’ecosistema
terrestre, e la consistenza quotidianamente palpabile di questo
potere, inconcepibile per le generazioni che ci hanno preceduto,
spoglia la figura del diluvio universale dei suoi contorni favolosi per
renderla ipotesi scientifica e storica di stringente, spaventosa
attualità.»
Il racconto del diluvio in Genesi diviene, da questa prospettiva, un
avvertimento. La storia di Noè, dice la Bartolomei, ci mostra «che
arriva un momento in cui comincia a piovere così forte che la Terra
comincia a essere sommersa: la violenza contro il vivente prevale, il
caos di cui essa è vettore e manifestazione travolge l’ordine
naturale, ingoiando in una spirale di morte che stritola tutti gli esseri
viventi senza distinzione – uomini, animali e piante». Distruggendo la
natura, distruggiamo noi stessi. Me lo ha fatto notare, nel corso di
un’intervista, anche il filosofo Giorgio Agamben. «Se per una volta
lasciamo l’ambito dell’attualità e proviamo a considerare le cose dal
punto di vista del destino della specie umana sulla Terra, mi vengono
in mente le considerazioni di un grande scienziato olandese, Louis
Bolk», mi ha spiegato Agamben. «Secondo Bolk, la specie umana è
caratterizzata da una progressiva inibizione dei processi vitali
naturali di adattamento all’ambiente, che vengono sostituti da una
crescita ipertrofica di dispositivi tecnologici per adattare l’ambiente
all’uomo. Quando questo processo sorpassa un certo limite, esso
raggiunge un punto in cui diventa controproducente e si trasforma in
autodistruzione della specie.» Terribile, ma vero: siamo andati di
corsa verso l’autodistruzione.
Per Teresa Bartolomei, tuttavia, il diluvio devastatore contiene in
sé entrambi gli aspetti dell’acqua (che ritroveremo più volte nel corso
di questo libro). Da un lato l’acqua che sommerge e distrugge.
Dall’altro l’acqua che salva, che riporta a vita nuova. «In questo
momento tragico, che per l’umanità è arrivato, è ancora possibile
salvarsi», scrive la Bartolomei, «dissociandosi dall’iniquità che
inerisce a un modello dominante di civiltà (impostato sul
consumismo sfrenato, sul dissennato sfruttamento delle risorse
naturali, sulla negazione delle responsabilità umane in merito al
degrado ambientale).» Violentando la natura, dunque, offendiamo
Dio, anzi arriviamo a cancellarlo dalla scena. Il predominio della
tecnica ci fa credere di essere dèi noi stessi e di poter disporre del
creato come se fosse esclusivamente nostro. Ma non lo è: ci è stato
invece dato in custodia. Possiamo goderne i frutti, ma non
approfittarne. Dobbiamo, di nuovo, darci una misura. La
microscopica belva che si è scatenata, in questo senso, non è una
punizione, quanto un monito. È un “mostro” a tutti gli effetti. E, come
spiega Jean Clair, «in latino il monstrum rientra anche nel campo
della fantasmagoria: è un prodigio, un avvertimento emanato dalla
volontà degli dèi, come suggerisce un’inattesa etimologia: monere,
cioè avvertire, prevenire, mettere in guardia. Ma monere indica
anche, in maniera altrettanto inattesa e apparentemente
contraddittoria, conservare il ricordo, la traccia, la memoria. È
l’ingiunzione della tomba, dell’iscrizione, della statua. Da monere
deriva monumentum».
Dobbiamo prendere dunque questa epidemia non come una
“occasione”, ma come un monito severo: urge cambiare
radicalmente il nostro sistema di sviluppo, e ricostruirlo su basi
nuove.
Dall’ecocidio deriva l’offesa a Dio che provoca il diluvio.
Dall’ecocidio è derivata l’epidemia che ci ha colpito. Non è un caso
che il coronavirus sia arrivato all’uomo dagli animali tramite un salto
di specie, uno spillover, come viene definito. Un evento che si
produce solo per via dell’azione umana. «Il problema non è la
biodiversità virale», ha detto in un’intervista a “Le Scienze” Danilo
Russo, professore associato di Ecologia all’Università Federico II di
Napoli, «ma il nostro rapporto con la natura, in particolare con la
fauna.» Questa azione umana porta due specie animali, che
naturalmente mai sarebbero venute in contatto, a trovarsi vicine.
«Gli esseri umani sono ospiti ideali per un virus», mi ha spiegato
Russo. «Siamo tanti, ci spostiamo in lungo e in largo per il globo
aiutando la diffusione. Laddove esiste biodiversità, ci sono patogeni.
Quando deforestiamo e portiamo l’uomo a contatto con questi
ambienti naturali, creiamo le condizioni per il salto di specie.
Abbiamo tanto parlato dei pipistrelli. Ebbene i pipistrelli vengono
catturati, vengono sottoposti a enorme stress (che favorisce la
diffusione dei patogeni), quindi tenuti – per esempio nei wet market
a contatto con numerose altre specie. Così si crea un perfetto
laboratorio virale all’aperto. Lì il virus può provare le sue varianti e
commettere errori, fino a che non sarà riuscito ad arrivare all’uomo in
forma adatta. Se un tempo l’impatto con la natura era relativamente
limitato, oggi non è più così. Dunque la crisi che stiamo affrontando,
prima che sanitaria, è ecologica.»
Il problema non è certo limitato alla Cina. «In Congo», prosegue
Russo, «si deforesta per estrarre il coltan, un minerale
indispensabile per la produzione di cellulari. Oltre a deforestare, i
minatori vengono autorizzati a cacciare fauna selvatica: è un’altra
bomba a orologeria pronta a scoppiare. Bisogna inoltre considerare
che spesso emergenze di questo tipo scoppiano in aree del mondo
in cui la sorveglianza sanitaria è bassissima. Il punto dunque non è
se scoppierà una nuova pandemia. Ma quando.»
Già, il coronavirus non è certo la prima né la più devastante
epidemia a cui abbiamo assistito. Non bisogna dimenticare che
persino l’Aids è dovuta a uno spillover, cioè a un salto di specie.
Come ricostruisce Russo, l’origine di questa malattia va ricercata in
Camerun, agli inizi del Novecento. «Per la precisione nel 1908», dice
il
professore. «Un cacciatore di scimpanzé si procurò una ferita e
venne in contatto con uno scimpanzé che era già ferito a sua volta.
Dall’animale il virus passò all’uomo. Poi ci volle un mutamento
ulteriore delle condizioni sociali prima che il virus si diffondesse.»
Ancora una volta, però, parliamo di un passaggio da animale a uomo
prodotto dalla distruzione di una barriera.
«Dal 1940», scrive la giornalista Sonia Shah su “Le Monde
diplomatique”, «centinaia di microbi patogeni sono comparsi o
riapparsi in aree in cui, in alcuni casi, non si erano mai visti prima. È
il
caso del virus dell’immunodeficienza umana (Hiv), dell’ebola
nell’Africa occidentale e dello zika sul continente americano. La
maggior parte di essi (60 per cento) è di origine animale. Alcuni
provengono da animali domestici o da allevamento, più di due terzi
da animali selvatici.» Bestie che, a causa della distruzione degli
habitat naturali e della deforestazione, «non possono fare altro che
ammassarsi nelle piccole porzioni di habitat lasciate libere dagli
insediamenti umani. Il risultato», ricorda la Shah, «è una maggior
probabilità di contatto stretto e ripetuto con l’uomo, cosa che
permette a microbi benigni di passare nel nostro corpo e di
trasformarsi in agenti patogeni mortali».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :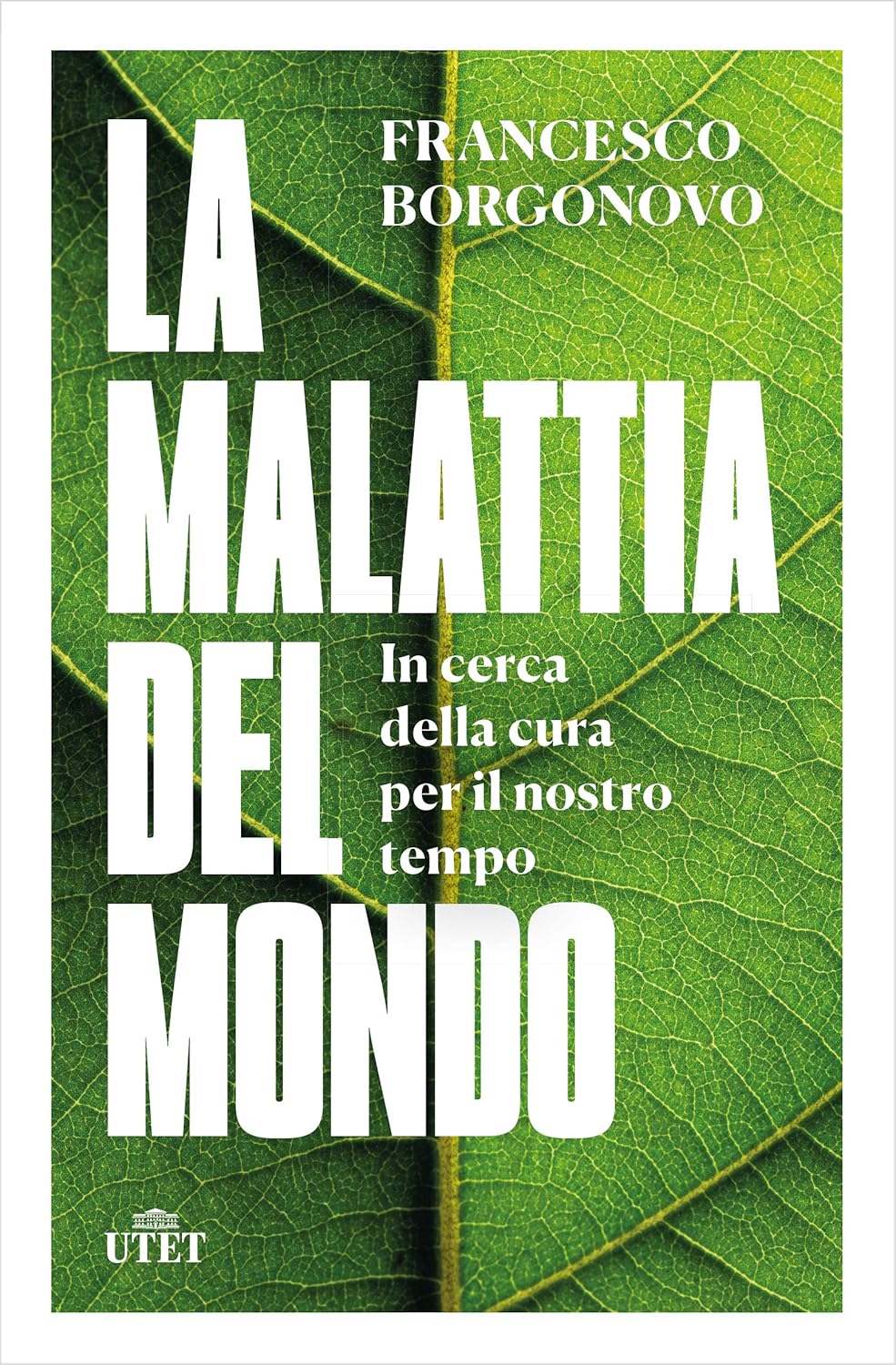






Commento all'articolo