La favolosa storia delle verdure – Évelyne Bloch-Dano
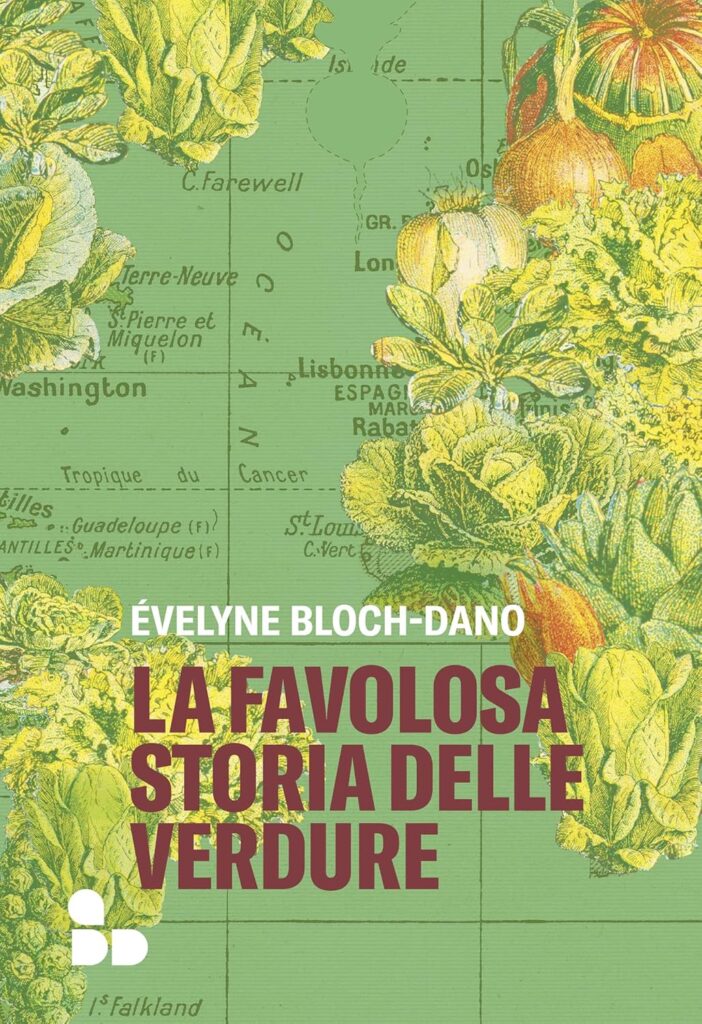
SINTESI DEL LIBRO:
L’aria che respiriamo e gli alimenti che ingeriamo: per l’essere
vivente nutrirsi è essenziale. Il cibo è ciò che ci mantiene in vita, ma
è anche quello che ci lega all’ambiente circostante, alla nostra storia,
alla nostra società, alla nostra epoca, al nostro status sociale: agli
altri. Claude Lévi-Strauss, nelle Origini delle buone maniere a tavola,
dice che «la cucina di una società costituisce un linguaggio nel quale
questa società traduce inconsciamente la propria struttura o
addirittura rivela, sempre senza saperlo, le proprie contraddizioni»,
segno rivelatore, pietra angolare dei nostri comportamenti e di ciò in
cui crediamo, dei nostri miti, dei nostri sistemi organizzativi, la cucina
non è soltanto «buona da mangiare», ma «buona da pensare».
Nutrirsi, mangiare… «Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei» scrive il
gastronomo del XIX secolo Brillat-Savarin all’inizio del trattato sulla
Fisiologia del gusto, ma anche “dimmi cosa mangi” e ti dirò che
legame hai con i tuoi cari, con la natura, con la cultura, con la
società. Quando ci nutriamo, non è coinvolto soltanto il nostro
involucro corporeo (magro, grasso, troppo magro, troppo grasso),
ma anche il nostro cervello, i nostri sensi, la nostra psiche. L’uomo è
l’unico essere vivente a non subire meccanicamente i vincoli
dell’ambiente che lo circonda ma a poter scegliere la propria
alimentazione in base a criteri non fisiologici, bensì simbolici. Può
privilegiare questa dimensione simbolica a scapito della sua salute o
della sua vita: alimenti considerati carichi di mana, che danno la vita
ma possono anche causare la morte, alimenti tabù o totemici, di cui
incorporiamo la sostanza, cibi rituali, vietati o sacralizzati dal giovane
hua di Papua Nuova Guinea che mangia una verdura che cresce in
fretta per ottenere lo stesso effetto, dall’ebreo o dal musulmano che
non mangiano la carne di maiale, all’indiano bramino che non
consuma carne di mucca, al cristiano che con l’ostia assimila
simbolicamente il corpo di Cristo. Ma la dimensione simbolica fa
parte anche dei grandi momenti di condivisione segnati da riti
conviviali: il banchetto del matrimonio o il pranzo del compleanno, il
cenone di San Silvestro o le veglie funebri. L’amico, la persona cara:
è con loro che dividiamo il pane.
Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che
è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce
seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli
uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei
quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne.
Genesi, 1, 29-30
Oggi dunque l’alimentazione interessa antropologi, archeologi,
archeozoologi – che ci insegnano per esempio, smentendo un luogo
comune, che i Galli mangiavano più manzo o cavallo di allevamento
che cinghiale –, storici che studiano il galateo della tavola o la storia
del gusto e dell’alimentazione, psicologi, linguisti (indovinello: quale
parola francese ha la stessa origine del pudding?1), geografi,
economisti, sociologi, botanici, medici, biologi, politici. La presenza
di rilievi montuosi, il clima, le risorse hanno condizionato a lungo il
destino culinario di una regione o di un popolo. Ma anche le guerre e
i
flussi migratori hanno contribuito ai cambiamenti alimentari,
introducendo nuove verdure diventate essenziali, come la patata che
i conquistadores hanno portato in Europa dal Sud America, o la soia
importata dai cinesi in Giappone. E non dimentichiamo che la storia
dell’uomo è segnata sin dalle origini da fame e carestie. Basta poco
perché una popolazione cominci a soffrire di denutrizione, un
cambiamento climatico, una guerra: gli europei ricordano l’ultima
guerra mondiale – niente burro, uova, latte, zucchero, carne, caffè,
verdure. Gli abitanti del Darfur oggi, dell’Etiopia o della Somalia ieri.
Attraverso le questioni dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente, degli
scambi Nord-Sud o degli Ogm, l’alimentazione è al centro della
politica. E lo sarà sempre di più.
Quanto alla “distinzione” sociale, cara a Pierre Bourdieu, forse è
nell’alimentazione che si manifesta nel modo più marcato, dal
comportamento a tavola agli alimenti, alla cucina stessa. La
globalizzazione non ha portato all’uguaglianza. Certo, oggi
mangiamo meglio e la Cina, per esempio, è passata da una sorta di
carestia endemica a un regime alimentare sufficiente a determinare
nei giovani una crescita media di sei centimetri in trent’anni. Ma
ovunque, e in modo clamoroso nei Paesi sviluppati, le differenze
nell’alimentazione sono rimaste, e talvolta si sono persino
accentuate. Dai pasti sugli aerei agli angoli delle “specialità
gastronomiche” dei supermercati, non tutti mangiano in prima
classe. Da un lato l’“alta cucina”, dall’altro l’“abbuffata”. Dichiararsi
gastronomi è già un preciso segno di appartenenza. Cos’è la
gastronomia, se non il frutto di una collaborazione tra persone che
scrivono e persone che cucinano per far accedere, nel XIX secolo, i
borghesi a un’arte culinaria fino ad allora riservata alla nobiltà? Ciò
non significa che le classi medie o meno abbienti mangino male, ma
che mangiano in modo diverso e, soprattutto, che lo si racconta in
modo diverso. È sufficiente leggere i menu dei ristoranti per
rendersene conto.
Dal momento che ci legano alla terra, alla Madre Terra di cui
parlano gli antichi, le verdure occupano un posto particolare tanto
nella storia dell’alimentazione quanto nel nostro immaginario, nei
nostri miti, nei nostri costumi, nella nostra eredità familiare. Per
molto tempo hanno rappresentato se non la base della nostra tavola,
garantita dai cereali, sicuramente una parte fondamentale.
Coltivate o spontanee – pensiamo ancora oggi ai denti di leone nei
prati, ai funghi nei boschi, alle more lungo i sentieri – le verdure sono
una sicurezza, che assicura la sussistenza quando non si ha niente.
Esistono sin dall’alba dell’umanità, rappresentano il grado
elementare dell’organizzazione sociale, il passaggio dal crudo al
cotto, dalla natura alla cultura, dallo stadio della raccolta a quello
dell’agricoltura: gli esseri umani hanno addomesticato le verdure
come gli animali, scegliendo le piante e osservandone gli effetti sul
corpo. Le piante, i cereali, le erbe e le radici seguono l’inizio della
sedentarizzazione: l’atto di coltivare implica che ci si fermi per avere
il tempo di seminare, lasciar crescere e raccogliere.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :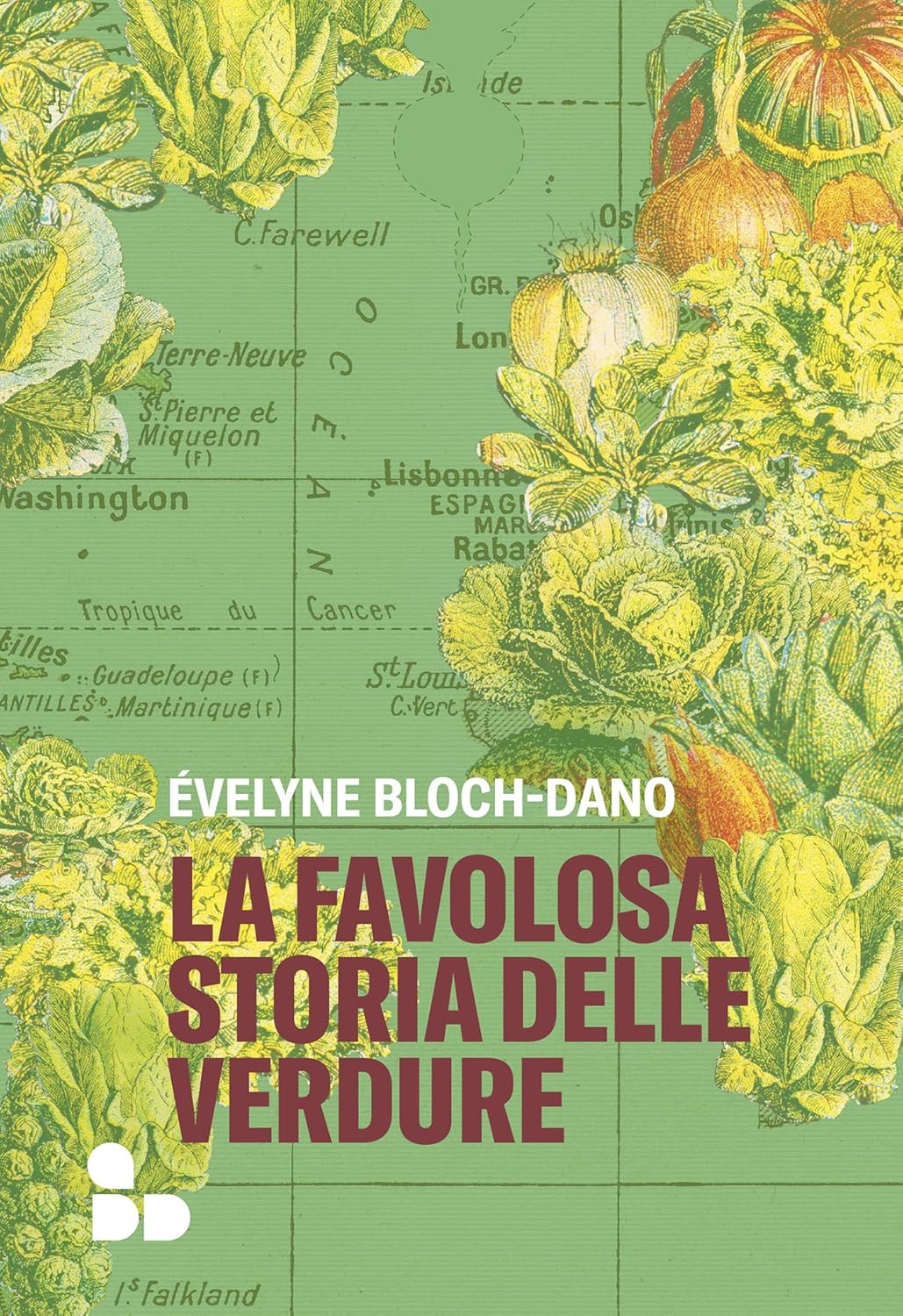






Commento all'articolo