La grande mattanza – Storia della guerra al brigantaggio – Enzo Ciconte
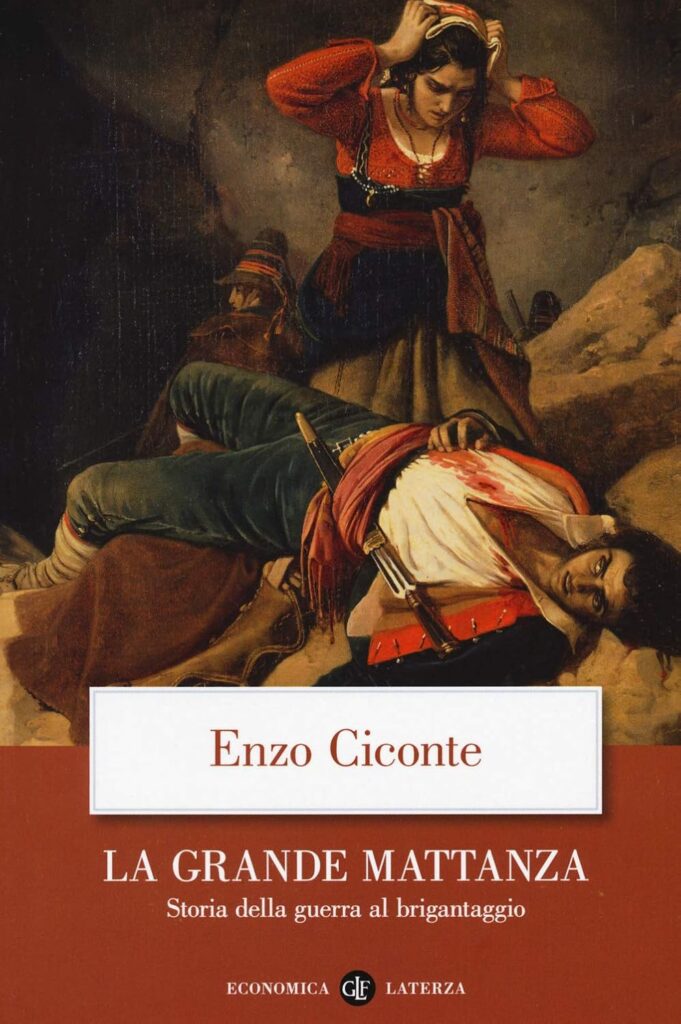
SINTESI DEL LIBRO:
Sono tanti e di natura diversa i banditi d’ancien régime. Non si trovano solo
al Sud, ma anche al Nord dove sono diffusi su un territorio molto ampio.
La parola ‘bandito’, già lo abbiamo accennato, cela realtà diverse:
comprende i fuorusciti, cioè nobili o cittadini eminenti espulsi senza tanti
riguardi in seguito alle lotte fra le fazioni municipali che sembrano non
spegnersi mai; tra di loro c’è anche una quota di soldati disoccupati che
sanno fare un solo mestiere: maneggiare le armi. Il contingente più
numeroso è composto da ladroni, banditi di strada, masnadieri,
delinquenti comuni colpiti dal bando per crimini gravi, per aver ucciso o
rubato o rapinato, e che di conseguenza sono privati dei beni, se ne
posseggono, e in ogni caso espulsi per un periodo di tempo limitato o, nei
casi più gravi, per sempre. È questa, ad una prima approssimazione, la
realtà che si presenta nell’Italia del Cinquecento.
È un banditismo dalle molte facce. Una di queste rivolge l’attacco
contro le proprietà baronali, e la violenza è esercitata esclusivamente
contro i ricchi. E forse qui trova origine il mito del brigante che combatte
il ricco a favore del povero. È un mito, non una realtà diffusa, ma i miti, si
sa, non sempre hanno aderenza alla vita d’ogni giorno.
È una realtà molto complessa, quella del banditismo, e bisogna avere
l’accortezza di distinguere. C’è una varietà infinita: c’è il banditismo
come fenomeno di delinquenza comune, c’è quello che è frutto di
ribellismo popolare e infine quello che acquista un’enorme rilevanza e
dimensione fra Cinquecento e Seicento, quando incrocia e coinvolge in
maniera trasversale diversi ceti sociali, s’incunea nei legami fra signori e
banditi, avviluppa realtà urbane e rurali.
Bisogna saper distinguere: il banditismo di fine Cinquecento, la cui
radice è legata alla crisi sociale ed economica di vasta portata, è diverso da
quello della prima metà del Seicento quando ad emergere sono masnade
che si mettono al servizio dei signori locali o degli eserciti privati dei
baroni diventando strumento della reazione feudale. Ancora diverso sarà
quello di fine Settecento, quando l’arrivo dei francesi in Italia sconvolgerà
gli equilibri politici, creerà nuovi assetti di potere e darà fiato alla nascente
borghesia determinando situazioni di aspre conflittualità e diffusa
violenza al Nord ma ancora di più al Sud.
I banditi creano allarmi, ma i governanti non sempre sanno cosa fare e se
ne interessano solo quando arrivano fin dentro le mura delle città.
La fame occupa per un lungo periodo il primo posto fra le ragioni che
spingono al banditismo. Un nugolo d’affamati, poveri, disperati, storpi,
sciancati, cenciosi – uomini, donne e tanti bambini – affollano le vie delle
città, si arrangiano come possono e quando possono, aggrediscono,
rubano, si danno all’accattonaggio, chiedono l’elemosina davanti a chiese
e conventi, turbano la quiete, o almeno così dicono i benpensanti e tutti
coloro che non hanno voglia di vederseli girare tra i piedi.
Sono in molti, non c’è dubbio; c’è persino il sospetto che non tutti siano
davvero così poveri da essere costretti a stendere la mano. Qualcuno forse
porge la mano perché è un modo come un altro per tirare a campare. Chi
sono i poveri che hanno diritto di chiedere davvero l’elemosina? Non si
può stabilirlo a colpo d’occhio guardando superficialmente quelle
moltitudini. Ma poi, che importa? Non lavorano, e non fanno niente per
guadagnarsi da vivere; tanto basta per metterli al bando, per scacciarli, per
allontanarli dalla vista.
Sono tanti e sono dappertutto. Nella Roma papalina sono così numerosi
che papa Pio IV nel 1561 decide di proibire l’accattonaggio senza avere
riguardi per l’età e il sesso, minacciando, in caso d’inadempienza, severe
sanzioni: l’arresto, la frusta, la berlina, e quando tutto ciò non sortirà
l’effetto sperato ci sarà il bando perpetuo dalla città oppure la galera.
Sono in tanti anche a Venezia, e infatti il Consiglio dei Dieci decide che
è vietato chiedere l’elemosina. È il 1564. Anno terribile che porta a
decisioni difficili da prendere, ma che sembrano inevitabili ai governanti
per preservare i cittadini dal cadere nel tranello dell’inganno; e così «sono
stati prohibiti i questuanti che vanno attorno con indulgentie spillando
sotto pretesto di religione et ingannando i simplici christiani»1. Qualche
anno prima una decisione altrettanto drastica: i mendicanti forestieri, una
volta individuati, devono essere rispediti nelle loro località d’origine.
Come se fosse facile! O come se fosse risolutivo impedire a questa massa
di chiedere soldi a chi soldi ne ha in quantità. In ogni caso, è certo che ci
sono disagio, paura e una sottile inquietudine che scorrono tra le mura
della città, ma anche una certa insofferenza da parte dei cittadini
infastiditi o disturbati dai questuanti; e infatti il Consiglio dei Dieci è
costretto a intervenire più volte.
Cosa fare per fronteggiare costoro e gli altri che fuori dalle mura urbane
uccidono, rubano, creano allarmi, paure, insicurezze, aggrediscono i
viandanti, rapinano, rendono insicure o impraticabili le vie al punto da
costringere a viaggiare in gruppi e ben armati? Come fare per fronteggiare
i latrones, come sono chiamati, con un altro termine ancora una volta
onnicomprensivo e perciò ambiguo?
Le risposte sono tante, forse troppe e diverse, e di segno opposto. Molti
Stati in mancanza di meglio, e non sapendo cosa fare, inaugurano la
politica del pendolo. Si parte da una minaccia molto forte e
sproporzionata rispetto al fatto contestato e poi si arriva ad una politica
premiale. Sempre a Venezia, il Consiglio dei Dieci nel 1549 emana una
legge con la quale consente al bandito di poter riacquistare la libertà
uccidendo un altro bandito che è nelle sue stesse condizioni oppure, se è
persona libera, ha la facoltà di liberare un bandito che magari sia un suo
servo o un suo amico. I veneziani non rimangono da soli in questa
politica; sono in buona compagnia.
Un pendolo. Da un estremo all’altro: dal rigore eccessivo, a volte brutale
e disumano, al premio; e tutto nel giro di pochi anni. Qual è la strada
giusta? Non sembrano saperlo i governanti dell’epoca che appaiono
incerti, insicuri, senza una bussola. Si muovono a tentoni, attenti solo alle
convenienze del momento, alle emergenze sempre in agguato, senza una
strategia di lungo respiro. Forse nessuno ha voglia, o interesse, di guardare
le cause reali della recrudescenza del fenomeno. Nessuno sembra
chiedersi: perché succede tutto ciò?
In questi decenni incerti e aspri si gettano le basi per scelte repressive o
premiali che troveranno il modo di sopravvivere nelle diverse contingenze
storiche e di tenere un filo di continui tà che, pur negli inevitabili
mutamenti delle politiche repressive e delle diverse norme giuridiche dei
vari regimi, attraverserà i secoli, quasi che il tempo non sia passato o sia
stato sospeso.
Lotta contro i banditi «ad modum belli»
Sono tempi difficili per chi non ha niente e non sa come andare avanti. E
lo sono anche per chi ha il compito di garantire l’ordine pubblico e la
sicurezza. Riportare l’ordine e ristabilire l’autorità statale non sono cose
facili a farsi, né si possono ottenere usando le belle maniere. Ci vogliono
metodi convincenti, duri, violenti, atroci e, se serve, persino barbari.
Le campagne contra delinquentes o contra fuorusciti prevedono procedure
speciali e l’impiego della forza. La convinzione in questi decenni è che
bisogna dare l’esempio con sentenze esemplari emesse in tempi
rapidissimi. Si combatte con durezza, ad modum belli, de facto, ad horas. Non
c’è da stupirsi. I tempi sono quelli che sono e non si va tanto per il sottile;
«la barbarie» è «una ‘categoria’ flessibile, graduale»2. E i casi di barbarie
sono innumerevoli, li si incontra ovunque e con impressionante
frequenza.
Sentenze rapide, esemplari, che siano da monito ad altri perché non si
mettano su quella strada perigliosa sono in realtà dimostrazione di forza
da parte di chi ha il potere di emettere ed eseguire quelle sentenze, e di
annichilimento per chi si è messo fuori legge. Come sorprendersi, allora,
se c’è qualcuno che pensa di giustiziare all’istante, senza processo, pur di
colpire chi ha avuto rapporti con i banditi? È terrorismo, e dei peggiori,
di cui nessuno si stupisce.
La sorpresa potrebbe esserci per il fatto che chi la pensa così è un
eminente uomo di Chiesa, il cardinale Giustiniani, legato pontificio delle
Marche, impegnato in una lotta contro Marco Sciarra; ma è una sorpresa
che vale per noi contemporanei, perché per quei tempi il comportamento
del cardinale è normale e per di più appare giustificato dalle terribili
circostanze di un banditismo che non accenna a diminuire e che anzi è
diventato di massa e molto insidioso, poiché Sciarra ha relazioni altolocate
con principi e regnanti. Il periodo che intercorre tra la cattura del bandito
e l’esecuzione della pena tende sempre di più ad accorciarsi. Questo vuole
la cultura del tempo attenta all’esemplarità e alla rapidità della pena e per
nulla preoccupata, anzi estranea, rispetto alle garanzie dell’imputato e
della sua difesa nel processo.
Il «decreto delle teste» mozzate
Banditi e potere legale abitano gli stessi luoghi, agiscono sullo stesso
territorio; si fronteggiano: a volte c’è uno scontro, altre volte no. Si
conoscono e si riconoscono; non sono estranei gli uni agli altri. Il
banditismo di questi secoli è un fenomeno endemico che ogni tanto ha
delle violente fiammate. Spesso sono le contingenze economiche a
determinarne durata e caratteristiche. Ad esempio in Calabria, dove la
coltivazione dei gelsi è estesa, la criminalità precipita tra maggio e agosto,
ossia nel periodo di raccolta dei bachi da seta, e comincia a risalire subito
dopo, quando, terminata la raccolta, i contadini non hanno più fonti di
reddito e molti di loro scelgono la via dei monti. Poi fanno rientro a casa
per la riproduzione dei bruchi; sempre che non siano stati uccisi o
catturati dalle forze dell’ordine. È un banditismo legato ad una
contingenza, e non è tra i più preoccupanti. È pericoloso per chi lo
subisce, certo; ma nulla di più.
Il banditismo non ha solo radici economiche o sociali. Ci sono anche
altre ragioni che hanno il loro peso, come i conflitti tra diversi soggetti
della comunità per ragioni di prestigio e d’onore oppure l’abitudine di
farsi giustizia da sé, di scatenare faide sanguinarie, come succede nelle
zone di montagna attorno a Reggio Emilia, oppure nella Roma papalina
del Cinquecento o nella Repubblica di Genova. È diffusissima l’abitudine
di portare armi: spade, pugnali e archibugi sono lo strumentario
indispensabile se si vuole sopravvivere a lungo.
In molte aree è facile imbattersi in odi terribili e rancori inestirpabili che
si rincorrono per intere generazioni e che alimentano continui delitti tra
le principali famiglie. In alcuni casi c’è chi arriva a chiedere alle autorità il
permesso di potersi armare per difendersi da altri signori, suoi pari, con i
quali è da tempo in lite.
In questi territori vige la regola che, ucciso un bandito e portata la sua
testa al podestà, si ha diritto a scegliere tra una taglia proporzionata alla
nomea della vittima e la cancellazione del bando a carico di un parente, di
un amico o di un servitore. Il conte Paludi nel 1631 fa giungere al podestà
di Castelnuovo ne’ Monti la testa di un bandito di Parma e in cambio
reclama la liberazione di un suo bravo. Il bravo, una figura criminale che è
passata alla storia per la descrizione che ne ha fatto Alessandro Manzoni
nei Promessi sposi, fa la sua comparsa durante il periodo di dominazione
spagnola in Italia, tra il Cinquecento e il Seicento, per poi declinare
nell’uso (nessuno dopo quei due secoli parlerà ancora di bravi). Anche
nella Repubblica veneta del Seicento ci sono «huomini sicarii,
sanguinolenti forestieri, che si conducono a servir particolari per bravi,
cavandone il viver et altre molte comodità»3.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :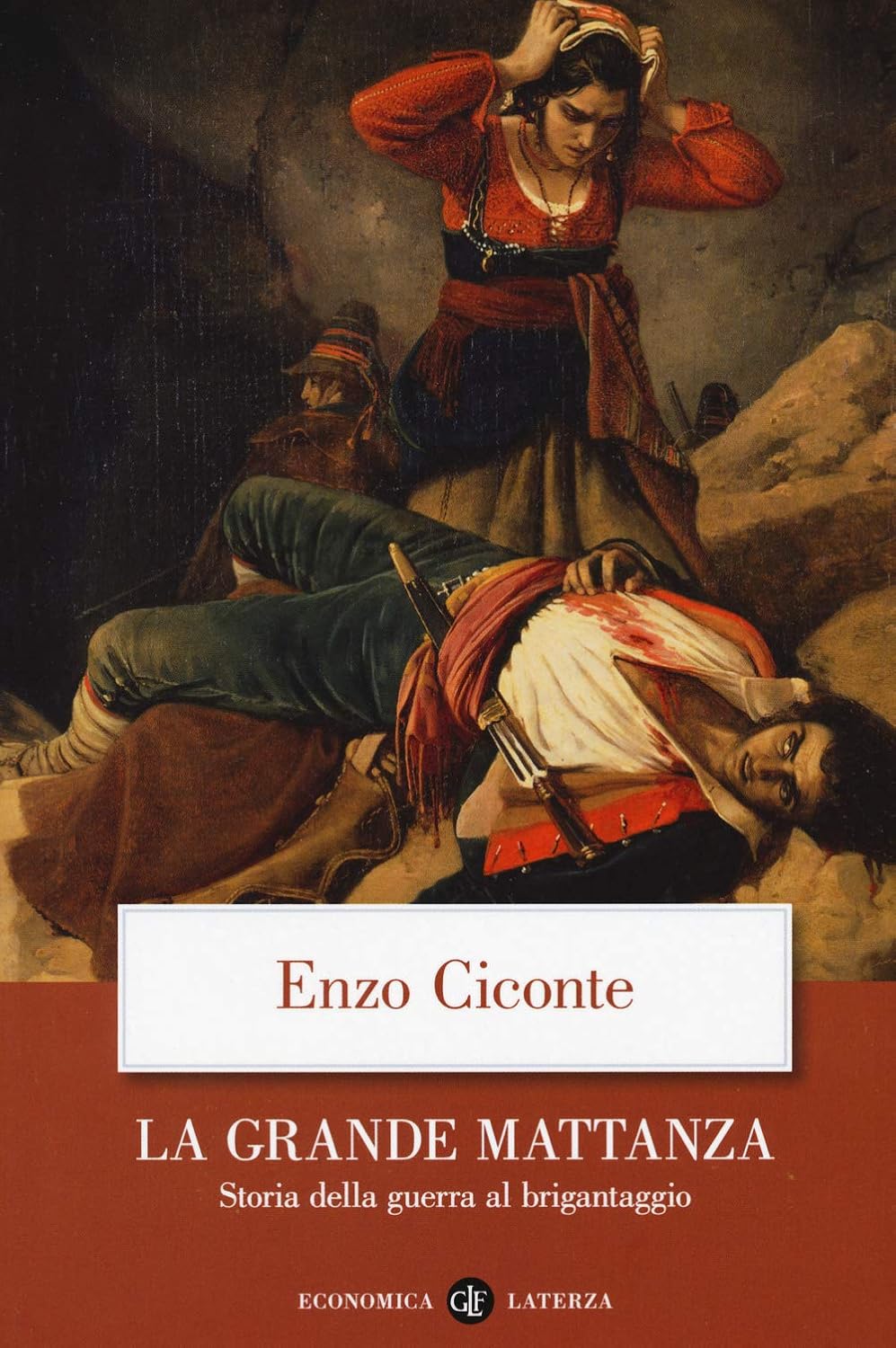






Commento all'articolo