La conquista dell’America – Il problema dell’«altro» – Tzvetan Todorov
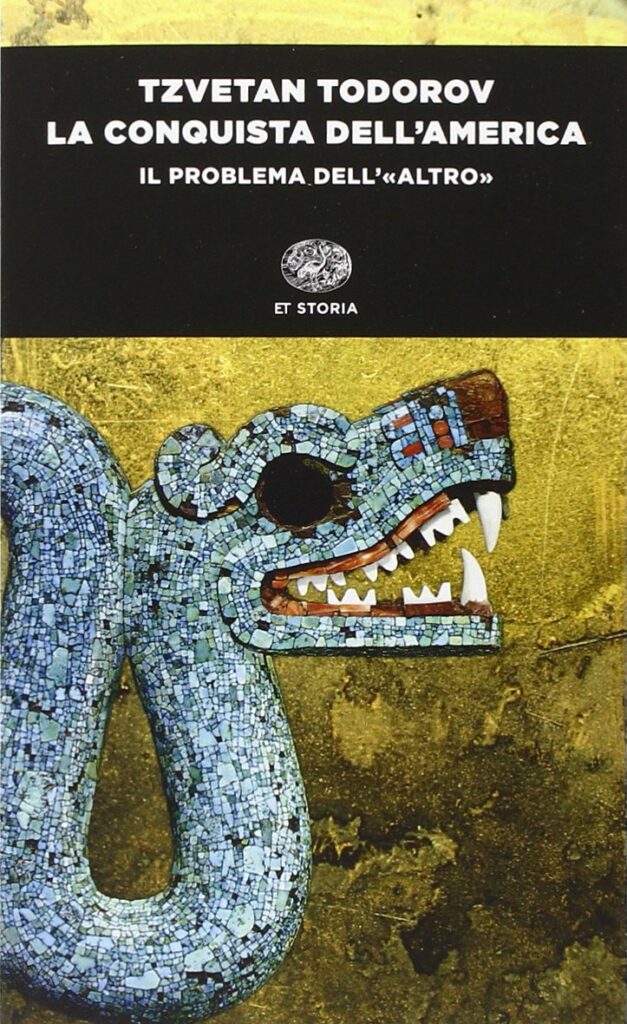
SINTESI DEL LIBRO:
Voglio parlare della scoperta che l’ fa dell’
io
altro
. L’argomento è
vastissimo. Non appena lo abbiamo formulato nei suoi termini
generali, lo vediamo subito suddividersi in molteplici categorie e
diramarsi in infinite direzioni. Possiamo scoprire gli altri in noi
stessi, renderci conto che ognuno di noi non è una sostanza
omogenea e radicalmente estranea a tutto quanto non coincide con
l’io: l’io è un altro. Ma anche gli altri sono degli io: sono dei soggetti
come io lo sono, che unicamente il mio punto di vista – per il quale
tutti sono laggiù mentre io sono qui – separa e distingue realmente
da me. Posso concepire questi altri come un’astrazione, come
un’istanza della configurazione psichica di ciascun individuo, come
l’Altro, l’altro o l’altrui in rapporto a
me;
oppure come un gruppo
sociale concreto al quale noi non apparteniamo. Questo gruppo, a
sua volta, può essere interno alla società: le donne per gli uomini, i
ricchi per i poveri, i pazzi per i «normali»: ovvero può esserle
esterno, può consistere in un’altra società, che sarà – a seconda dei
casi – vicina o lontana: degli esseri vicinissimi a noi sul piano
culturale, morale, storico, oppure degli sconosciuti, degli estranei, di
cui non comprendiamo né la lingua né i costumi, così estranei che
stentiamo, al limite, a riconoscere la nostra comune appartenenza ad
una medesima specie. Scelgo questa problematica dell’altro esterno e
lontano, un po’ arbitrariamente e perché non si può parlare di tutto
in una sola volta, per cominciare una ricerca che non potrà mai
essere conclusa.
Ma come parlarne? Ai tempi di Socrate, l’oratore aveva l’abitudine
di chiedere all’uditorio quale fosse il suo modo
di esprimersi o
genere preferito: il mito, cioè il racconto, o l’argomentazione logica?
Nell’epoca del libro, non si può lasciare questa decisione al pubblico:
perché il libro esista si deve fare una scelta, e ci si accontenta di
immaginare – o di augurarsi un pubblico che avrebbe dato una
certa risposta anziché un’altra; così come si ascolta la risposta che
suggerisce o impone l’argomento stesso. Ho scelto di raccontare una
storia. Più vicina al mito che all’argomentazione logica, essa tuttavia
se ne distingue sotto due aspetti. Prima di tutto perché è una storia
vera (mentre il mito poteva, ma non doveva necessariamente
esserlo), e in secondo luogo perché il mio principale interesse è più
quello di un moralista che di uno storico: il presente mi importa
assai più del passato. Alla domanda: come comportarsi nei confronti
dell’altro? non sono in grado di rispondere se non narrando una–
storia esemplare (è il genere da me scelto), una storia dunque
quanto più vera è possibile, ma della quale cercherò di non perdere
mai di vista quel che gli esegeti della Bibbia chiamavano il senso
tropologico o morale. In questo mio libro si alterneranno, un po’
come in un romanzo, le sintesi o vedute d’insieme sommarie, le
scene, o analisi particolari gremite di citazioni; le pause, nel corso
delle quali l’autore commenta quanto è accaduto; non mancheranno
neppure frequenti ellissi od omissioni: ma non è questo il punto di
partenza di ogni storia?
Delle numerose narrazioni che ci si offrono ne ho scelta una: quella
della scoperta e della conquista dell’America. Per ottenere migliori
risultati, mi sono fissato un’unità di tempo: il centinaio d’anni che
segue il primo viaggio di Colombo, cioè all’incirca il XVI secolo;
un’unità di luogo: la regione dei Caraibi e del Messico (che viene
talvolta chiamata Mesoamerica) e un’unità d’azione: la percezione
che gli spagnoli ebbero degli indiani. Essa costituirà il mio unico
argomento, con una sola eccezione, riguardante Moctezuma e i suoi
seguaci.
Due ragioni hanno giustificato, a cose fatte, la scelta di questo tema
come primo passo nel mondo della scoperta dell’altro. Anzitutto la
scoperta dell’America, o meglio degli americani, è l’incontro più
straordinario della nostra storia. Nella «scoperta» degli altri
continenti e degli altri uomini non vi fu un vero e proprio
sentimento di estraneità radicale: gli europei non avevano mai del
tutto ignorato l’esistenza dell’Africa, dell’India, o della Cina; il
ricordo di esse fu sempre presente, fin dalle origini. La Luna, è vero,
è più lontana dell’America; ma noi oggi sappiamo che quell’incontro
non è stato un vero incontro, che quella scoperta non ha comportato
sorprese dello stesso genere: perché si possa fotografare un essere
vivente sulla Luna, bisogna che un cosmonauta vada a piazzarsi
davanti all’apparecchio, e nel suo scafandro egli non vedrà altro
riflesso che quello di un’altra creatura terrestre. All’inizio del XVI
secolo gli indioamericani sono invece ben presenti, ma si ignora
tutto di loro, benché come c’era da aspettarsi sugli esseri appena
scoperti vengano proiettate immagini e idee relative ad altre
popolazioni lontane (fig. 1). L’incontro non raggiungerà mai più una
simile intensità (se quest’ultima è veramente la parola adatta): il XVI
secolo avrà visto compiersi il più grande genocidio della storia
dell’umanità.– –
1. Navi e castelli nelle Indie occidentali.
Ma non solo perché si trattò di un incontro estremo ed esemplare
la scoperta dell’America costituisce un fatto essenziale per noi oggi:
insieme a questo valore paradigmatico, essa ne possiede un altro,
direttamente causale. La storia del globo è fatta, certo, di conquiste e
di sconfitte, di colonizzazioni e di scoperte dell’altro; ma, come
cercherò dimostrare, è proprio la conquista dell’America che
annuncia e fonda la nostra attuale identità; anche se ogni data con la
quale si cerchi di separare due epoche è arbitraria, nessuna è più
adatta a contrassegnare l’inizio dell’era moderna dell’anno 1492,
l’anno in cui Colombo attraversa l’Oceano Atlantico. Noi siamo tutti
discendenti diretti di Colombo; con lui ha inizio la nostra genealogia,
nella misura in cui la parola inizio ha un senso. Con il 1492 siamo
– –
entrati
come scrisse Las Casas «in questo nostro tempo così
[1]
nuovo e così diverso da ogni altro» (Historia de las Indias, I, 88 ).
A partire da tale data il mondo è chiuso (anche se l’universo
diventa infinito), «il mondo è piccolo», come dichiarerà
perentoriamente lo stesso Colombo (Lettera rarissima, 7 luglio
1503); e c’è un’immagine di Cristoforo Colombo che ci trasmette in
parte questo spirito (fig. 2). Gli uomini hanno scoperto la totalità di
2. Cristoforo Colombo
cui fanno parte, mentre – fino a quel momento – essi erano una
parte senza il tutto. Questo nostro libro sarà un tentativo di capire ciò
che avvenne in quel giorno, e nel secolo successivo, attraverso la
lettura di alcuni testi, i cui autori saranno i miei personaggi. Essi
monologheranno, come Colombo, o dialogheranno fra loro con il
linguaggio delle azioni, come Cortés e Moctezuma, o con quello delle
parole dotte, come Las Casas e Sepúlveda; o useranno un linguaggio
meno perspicuo, come quello di Durán e di Sahagún con i loro
interlocutori indigeni.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :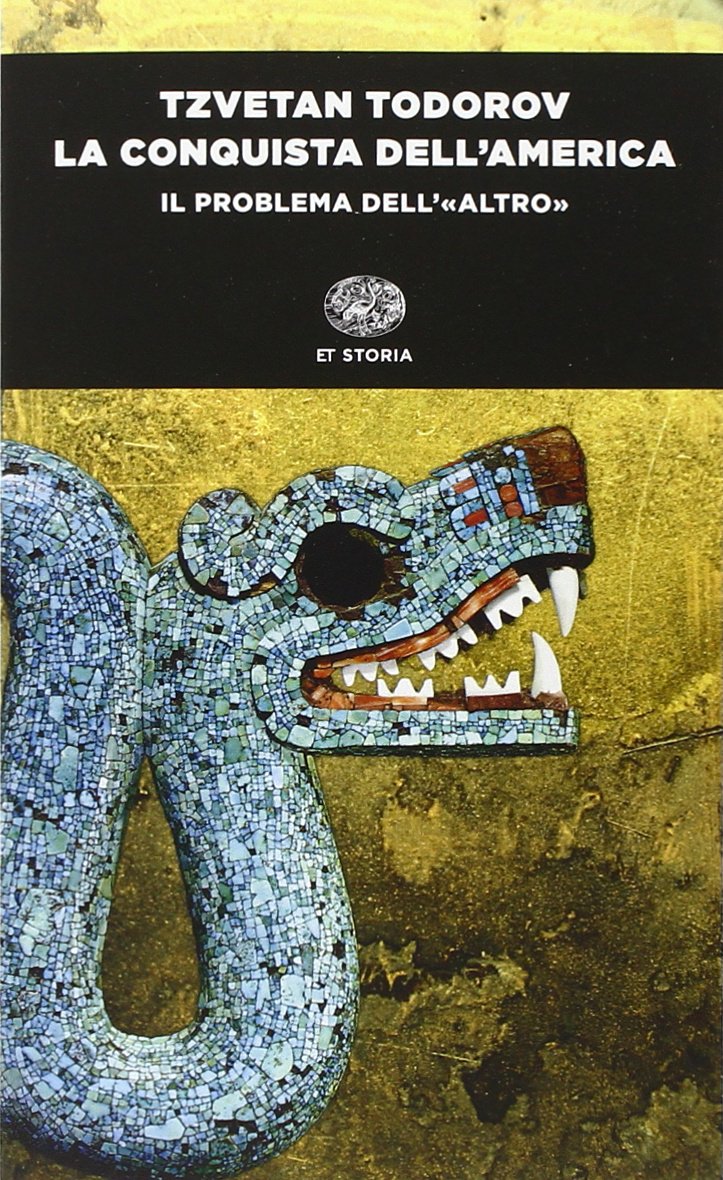






Commento all'articolo