Il futuro del lavoro è femmina – Come lavoreremo domani – Silvia Zanella
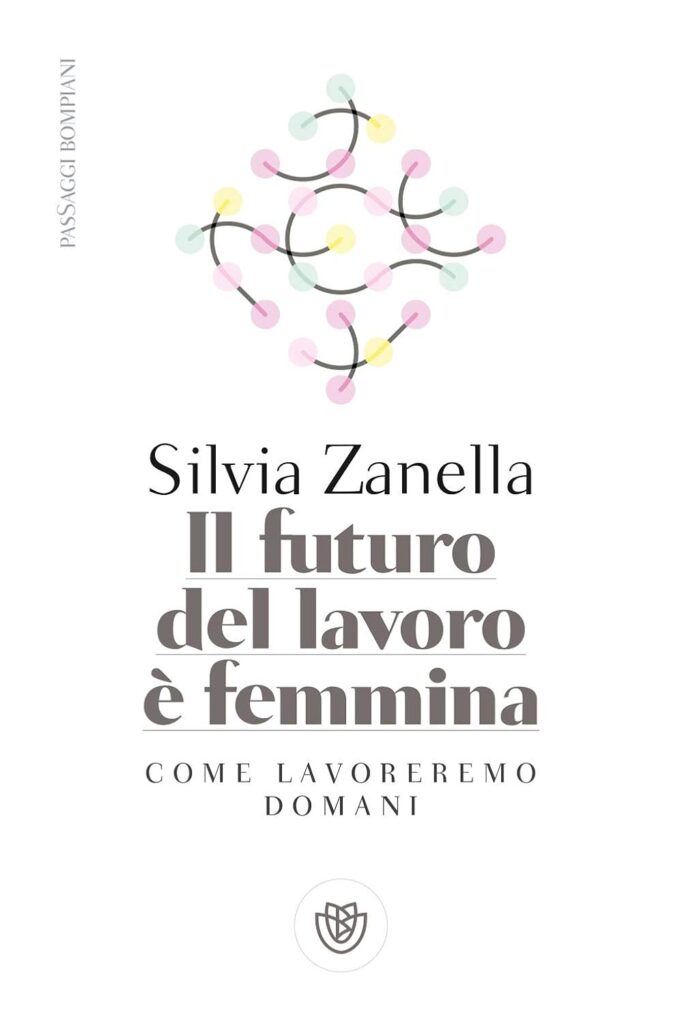
SINTESI DEL LIBRO:
Facciamo un esperimento. Cerchiamo di elencare tutti i tratti
distintivi delle aziende, così come le abbiamo viste e vissute fino a
oggi. Subito dopo, tentiamo di immaginarne le evoluzioni future.
Cominciamo dagli orari: in genere, nelle aziende sono molto
strutturati. Di solito si lavora dalle 9 alle 18, oppure si segue il
funzionamento degli impianti o l’erogazione dei servizi effettuando
delle turnazioni, programmate in maniera rigida. I contratti nazionali
stabiliscono le ore settimanali, regolamentano gli straordinari e
fissano le ferie e i momenti di riposo. Già negli ultimi anni, però,
stiamo assistendo a una trasformazione. La tecnologia, in particolar
modo attraverso gli smartphone e i social network, ha fatto venire
meno questa rigidità, non sempre in senso positivo. Ci si sente
obbligati a rispondere alle email nel weekend, e anche in vacanza
non si stacca mai davvero. Si parla di “diritto alla disconnessione” e
alcune aziende (BMW in Germania o Brunello Cucinelli in Italia)
hanno promulgato regolamenti interni ad hoc per permettere ai
lavoratori di non essere sotto la costante pressione dell’always on. Al
tempo stesso, si stanno introducendo in maniera sempre più
massiccia orari flessibili regolamentati ed è stata varata la legge sul
lavoro agile.
Con l’emergenza Covid-19 nei primi mesi del 2020, si è assistito a
un’accelerazione di tutti questi fenomeni. L’isolamento forzato di
milioni di lavoratori, coniugato all’esigenza di non bloccare
completamente l’economia, ha visto l’adozione del remote working in
migliaia di imprese nel settore privato e pubblico. Lo stesso governo
ha varato misure specifiche per ampliare i casi di utilizzo e ha
introdotto misure di supporto per una diffusione più rapida.
Passiamo agli spazi. Perdonate il calembour, ma è significativo il
fatto che un tempo il posto di lavoro si trovasse in un posto di lavoro.
Poteva essere uno stabilimento tessile, una banca, un negozio, un
ufficio, la bottega di un artigiano. Certo, molti di questi luoghi
esistono ancora. Ma con due importanti differenze.
La prima è che essi sono profondamente trasformati, soprattutto
nell’uso che ne fanno i destinatari finali, i clienti. Gli sportelli bancari
ci sono, ma per molti servizi si può utilizzare l’home banking. Le
lavanderie non sono scomparse, ma ora con un’app si può prenotare
il
ritiro del bucato a casa. L’online consente a piccoli laboratori
artigianali di raggiungere acquirenti ovunque.
La seconda è che grazie allo smart working le aziende, specie nel
terziario, possono dare ai propri collaboratori la facoltà di lavorare in
qualsiasi luogo: da casa, dal parco o da uffici terzi come i coworking.
Una volta si raggiungeva l’indirizzo fisico di un’azienda, che nella
maggior parte dei casi era anche la sua sede legale. Ora i dipendenti
e i collaboratori possono scegliere (in teoria) dove lavorare. La
tecnologia è ancora una volta il fattore abilitante, ma non sufficiente,
per attuare il cambiamento.4
Perché le cose cambino veramente, e ora consideriamo il focus
delle aziende, serve che si passi da un’attenzione all’input a una
sugli output. In altre parole, non bisogna più concentrarsi sulle
timbrature del cartellino o sulla mera esecuzione degli ordini, ma
sugli effettivi contributi portati da ciascun collaboratore, in maniera
più creativa e indipendente di un tempo. Questo significa, tra le altre
cose, ripensare la natura stessa del lavoro. Finora si sono proposte
mansioni in gran parte predefinite, con una serie di competenze
all’apparenza immutabili. Adesso si ragiona più per mansioni
declinabili e personalizzabili a seconda del singolo progetto a cui si
sta
prendendo
parte.
Ciò
prevede
una
concezione
dell’organizzazione molto fluida, del tutto in antitesi con la sua
impostazione tradizionale.
Per decenni le imprese si sono fondate sul command and control,
che prevede l’esercizio dell’autorità per raggiungere gli obiettivi. Tale
paradigma, che non a caso deriva dall’ambiente militare, pone un
forte accento sui processi e sulle decisioni, che vengono prese
dall’alto ed eseguite ai piani bassi dell’organizzazione, con un
approccio tipicamente top-down e dal netto carattere verticistico.
Come vedremo, questo tipo di impostazione è del tutto inefficace per
far fronte alle evoluzioni dei nostri tempi. Le aziende debbono quindi
rivedere il modo in cui sono strutturate e in cui gestiscono persone e
processi.5
Per la digital transformation le aziende sono organismi fortemente
interconnessi. Specie nel nostro Paese è spesso prevalsa un’ottica
padronale, familistica, di contrada, che ha impedito non solo
l’innovazione ma anche la sopravvivenza stessa di molte
organizzazioni vecchio stampo:
In Italia […] c’è una conflittualità così esasperata che si arriva a realizzarsi nel fatto
che l’altro perda. Come nel Palio, dove molte contrade che non hanno cavallo e
fantino competitivi corrono per far perdere la contrada rivale.6
Il
cambio di paradigma in atto, invece, richiede una visione di
sistema, dove la relazione, il network e la condivisione delle
informazioni sono asset imprescindibili. L’accentramento dei team
verrà man mano sostituito da (più) piccole squadre distribuite su
scala globale, si imporrà infine un freno al lavoro in silos (ogni
reparto a sé) per favorire la collaborazione e la co-creazione. Si
passerà da un ecosistema limitato a uno aperto, dove i successi non
saranno del singolo dipartimento ma il frutto della trasversalità dei
progetti, gestiti da team che lavorano in aree diverse. Le aziende
dovranno diventare più agili e adattative, e per farlo dovranno
sostituire le attuali gerarchie rigide con strutture più orizzontali, in cui
ciascuno possa dare il proprio contributo.7
Si è fatto un gran parlare, negli ultimi anni, di “aziende senza
organigrammi” o di “olocrazia”, per riferirsi a nuove tipologie di
imprese che hanno scelto di appiattire le organizzazioni, rimuovere
le prime linee e rivedere i job title in un’ottica più democratica. C’è da
dire che non sempre sono stati esperimenti andati a buon fine. Le
gerarchie hanno diversi difetti, ma sono molto facili da capire, le
conosciamo fin da bambini a partire dalle relazioni genitori-figli,
chiariscono subito i rapporti di forza fra A e B. Tant’è vero che
funzionano benissimo laddove ci si focalizzi su compiti semplici, in
cui conta solo l’esecuzione operativa e non ha rilevanza il pensiero
strategico: “Si dice che i robot stiano per sottrarre il lavoro agli esseri
umani, la realtà però è che molte persone svolgono mansioni che
sembrano disegnate per robot”.8
Nel mondo di oggi (e soprattutto di domani) le gerarchie rigide
non sono efficaci proprio perché non siamo alle prese con compiti
facili.
Fare a meno degli organigrammi, però, è un’impresa
complicata, ed è anche la decisione più estrema. Sono invece assai
maggiormente percorribili soluzioni più morbide, dove non viene
meno la struttura a cui siamo abituati, ma si dà maggior valore al
singolo collaboratore. La leggerezza, così come l’ascolto e la volontà
di cooperazione, farà da contraltare all’esercizio del potere fine a sé
stesso. Di nuovo, la tecnologia può fungere da acceleratore, nel
caso in cui le aziende, per esempio, si dotino di piattaforme
collaborative e di knowledge sharing.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :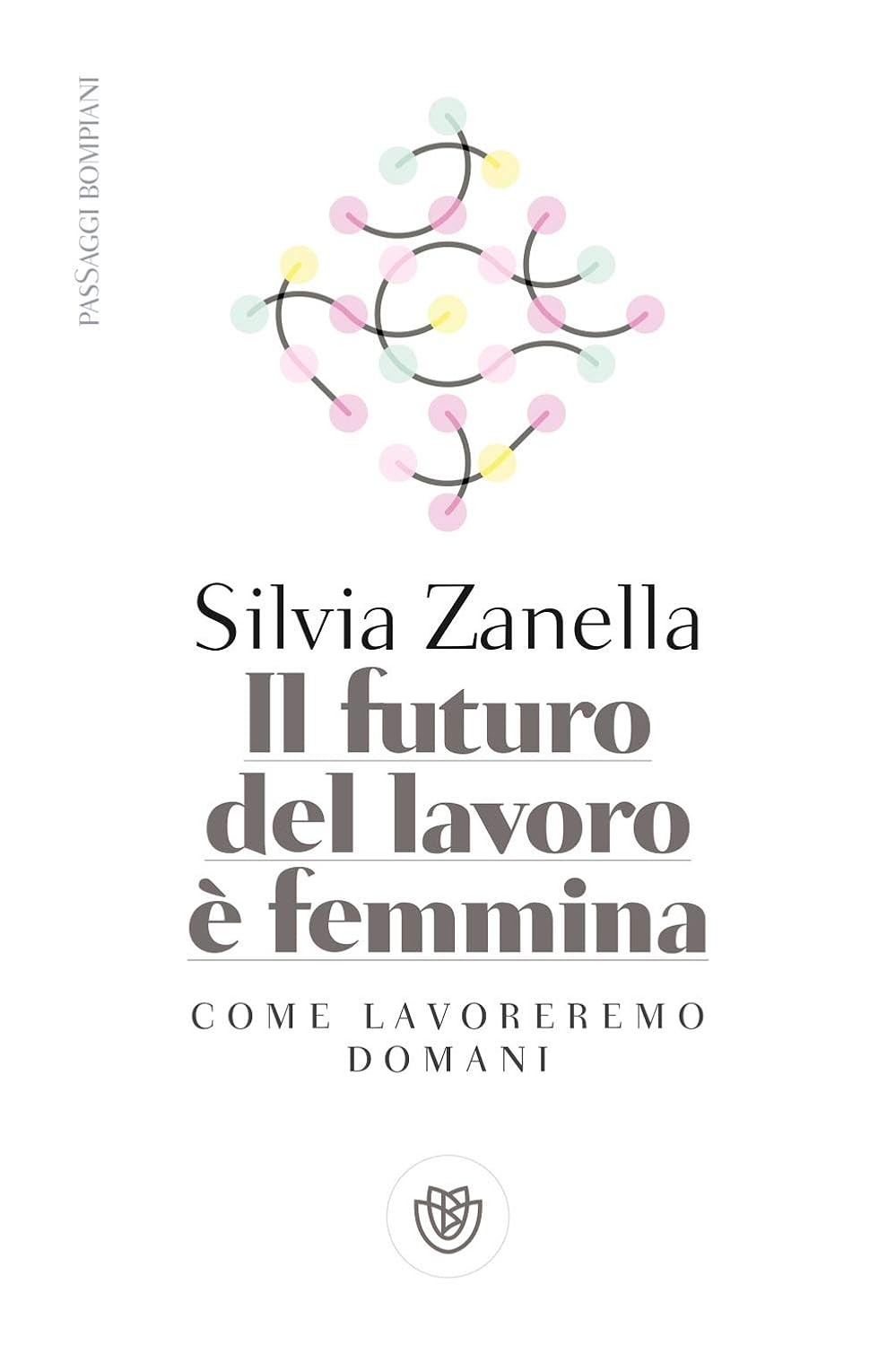





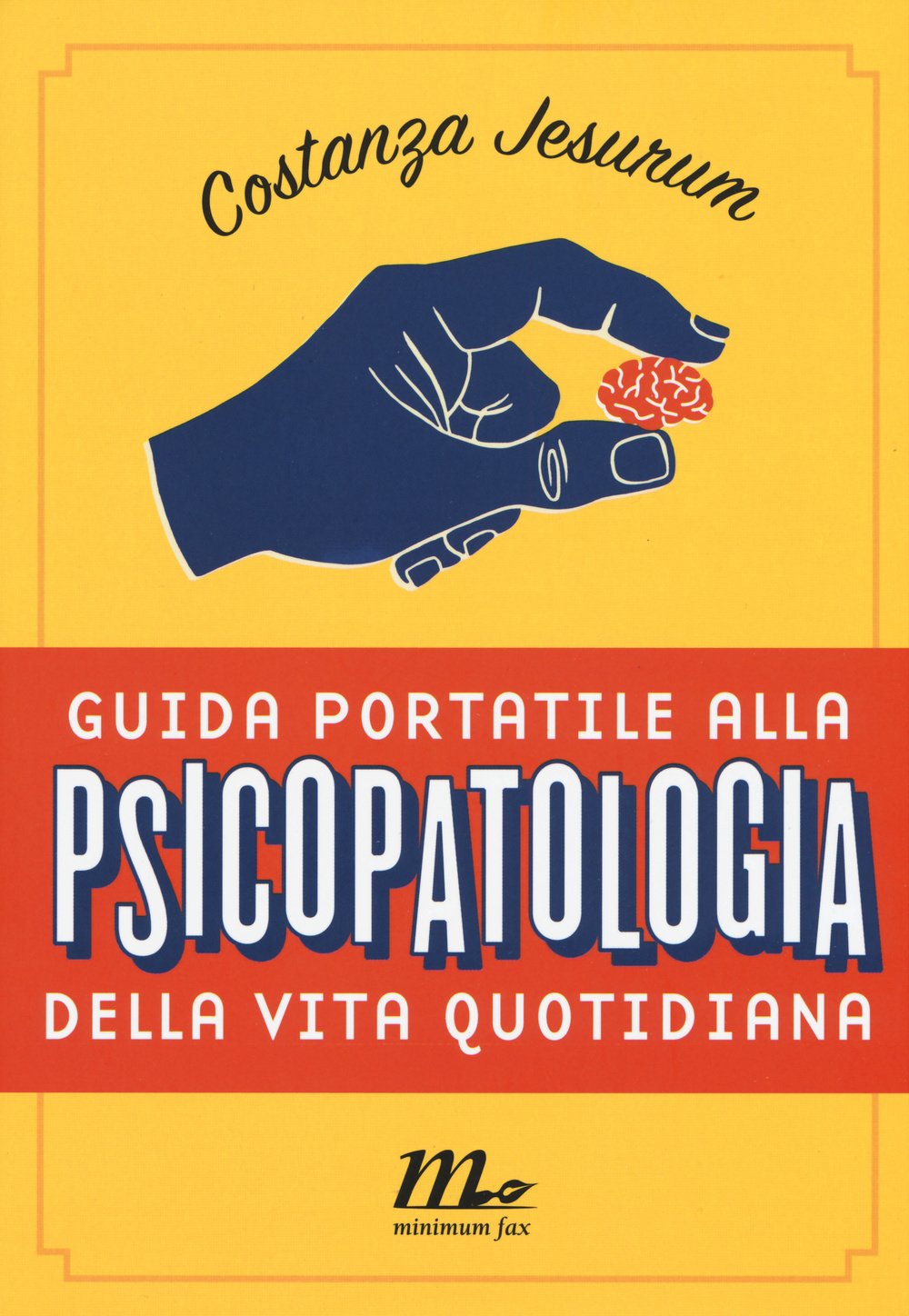
Commento all'articolo