I due Hotel Francfort – David Leavitt
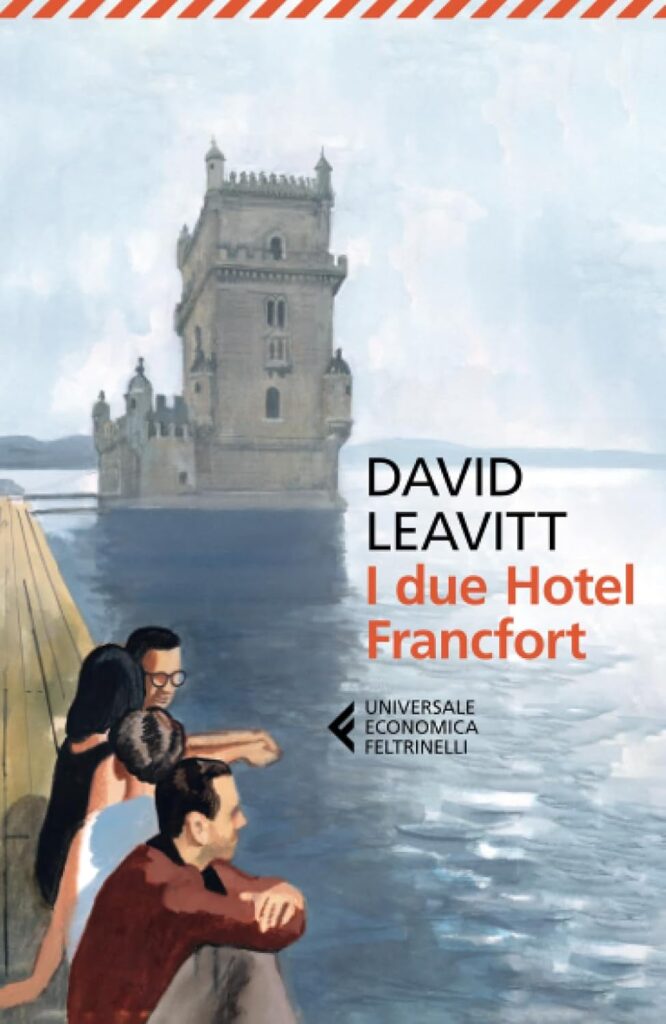
SINTESI DEL LIBRO:
Conoscemmo i Freleng a Lisbona, al
Café Suiça. Questo nel giugno del
1940, quando eravamo tutti a
Lisbona in attesa della nave che
stava venendo a metterci in salvo e
portarci a New York. Quando dico
noi,
intendo naturalmente noi
americani, perlopiù espatriati di
lunga data, per i quali la prospettiva
di tornare in patria era tutt’altro che
gradevole. Adesso sembra incivile
parlare della nostra situazione, che
non era niente in confronto a quella
dei veri profughi: gli europei, gli
ebrei, gli ebrei europei. Tuttavia,
allora ci preoccupavamo troppo di
quello che stavamo perdendo per
curarci di quelli che stavano
perdendo più di noi.
Io e Julia eravamo a Lisbona da
quasi una settimana. Io sono di
Indianapolis, lei era cresciuta a
Central Park West ma aveva
sognato, per tutta la giovinezza, un
appartamento a Parigi. Ebbene, io
avevo realizzato il suo sogno,
almeno fino a un certo punto. Vale a
dire che l’appartamento lo avevamo.
Avevamo i mobili. Eppure non era
mai soddisfatta, la mia Julia. Ho
sempre sospettato di essere io il
pezzo che non andava bene.
Sia
come sia, quell’estate
l’invasione della Francia da parte di
Hitler
ci
aveva costretti ad
abbandonare la nostra casa parigina
e partire a rotta di collo per Lisbona,
dove avremmo aspettato la SS
Manhattan, che il dipartimento di
Stato aveva requisito e mandato a
mettere in salvo gli americani in
difficoltà. All’epoca, solo quattro
piroscafi –
l’Excalibur,
l’Excambion, l’Exeter e l’Exochorda
– facevano la traversata regolare per
New York. Venivano chiamati così,
si diceva scherzosamente, perché
portavano ex-europei in ex-ilio.
Ciascuna nave aveva una capienza
di circa 125 passeggeri, contro i
1200 della Manhattan, e, come per i
voli
Clipper
che decollavano
dall’aeroporto sul fiume Tago ogni
settimana, non c’era verso di
prenotare un posto, a meno di non
essere un diplomatico o un Vip.
E così avevamo almeno una
settimana di tempo da trascorrere a
Lisbona prima dell’arrivo della
Manhattan, e la cosa mi stava
benissimo, dopo quello che avevamo
passato, schivando bombardamenti e
colpi di mortaio lungo tutto il
tragitto attraverso la Francia, per poi
affrontare la sfida del passaggio
della frontiera spagnola e lottare con
gli agenti doganali, che nelle loro
tattiche d’interrogatorio erano decisi
a dimostrarsi più nazisti dei nazisti.
E Lisbona era una città in pace, di
conseguenza
tutto
ciò
che
scarseggiava in Francia e Spagna lì
c’era
in
abbondanza:
carne,
sigarette, gin. L’unico problema era
il
sovraffollamento. Le stanze
d’albergo erano quasi impossibili da
trovare. La gente stava sveglia tutta
la notte al casinò di Estoril, a
giocare d’azzardo, e poi dormiva
tutto il giorno sulla spiaggia. Ma noi
eravamo fortunati, avevamo una
camera, e comoda per giunta. Sì, a
me stava benissimo.
Non a Julia, però. Lei odiava il
Portogallo. Odiava le urla delle
pescivendole e l’odore del baccalà.
Odiava
i
bambini
che
la
rincorrevano con i biglietti della
lotteria. Odiava i rifugiati ricchi che
avevano camere in alberghi migliori
del nostro e i rifugiati poveri che
non avevano nessuna camera, e la
donna misteriosa che trascorreva la
maggior parte della giornata
appoggiata allo stipite della sua
porta, a fumare nel corridoio buio,
“come Messalina in attesa di Gaio
Silio” diceva Julia. Ma ciò che
odiava di più – ciò che odiava più di
ogni altra cosa – era la prospettiva di
tornare in patria.
Oh, com’era contraria a tornare in
patria! Era stato così fin dall’inizio.
Prima aveva cercato di convincermi
a restare a Parigi; poi, quando
avevano iniziato a piovere bombe
sulla città, a stabilirci nel Sud della
Francia; infine, quando Mussolini
aveva ventilato l’idea di invadere il
Sud della Francia, a imbarcarci per
l’Inghilterra,
una cosa che il
Neutrality Act ci impediva di fare
(per la quale Julia non avrebbe mai
perdonato Roosevelt). E adesso
voleva rimanere in Portogallo. In
Portogallo, dico io! Dovrei far
notare – anzi posso far notare,
poiché Julia è morta e non può più
impedirmelo – che mia moglie era
ebrea, un fatto che preferiva tenere
nascosto. Ed è vero, in Portogallo
non
c’era
nessun
tipo
di
antisemitismo, molto semplicemente
perché
non
c’erano
ebrei.
L’Inquisizione aveva provveduto a
risolvere questo problemino. E così
lei aveva deciso che quel piccolo
paese nel quale era così restia a
trascorrere
qualche
settimana
sarebbe stato un posto perfettamente
gradevole per aspettare la fine della
guerra.
Perché aveva giurato,
quando si era stabilita a Parigi
quindici anni prima, che non sarebbe
più tornata in patria finché viveva. E
di fatto non ci tornò più.
Fu così che ci trovammo al Suiça
quella mattina: il Suiça, il caffè che,
come tutti i caffè di Lisbona, gli
stranieri
avevano
colonizzato.
Eravamo seduti fuori, a fare
colazione osservando il traffico che
scorreva attorno all’ovale di piazza
del Rossio, ed era su quest’idea di
stabilirci in Portogallo che Julia si
stava
incaponendo, mentre io
bevevo il mio caffè e mangiavo la
seconda di quelle tortine ripiene di
crema per cui il Suiça andava
famoso, e lei preparava una mano di
solitario,
a
incessantemente,
cui
giocava
usando mazzi
speciali di carte in miniatura. Slap
slap facevano le carte, bla-bla
faceva la sua voce, mentre per la
centesima volta illustrava il progetto
folle di affittare un appartamento o
una villa a Estoril; e io le spiegavo,
per la centesima volta, che non era
una buona idea, perché da un
momento all’altro Hitler poteva
stringere un’alleanza con Franco, nel
qual caso il Portogallo sarebbe stato
inghiottito dall’Asse. E com’è strano
pensare che, alla fin fine, lei avesse
ragione e io torto! Infatti saremmo
stati perfettamente al sicuro in
Portogallo. Be’, ormai è troppo tardi
perché lei possa rinfacciarmelo.
Fu allora che i piccioni calarono
in picchiata, così numerosi, e a volo
radente, che dovetti chinare il capo,
facendo cadere le carte dal tavolino.
«Niente paura, adesso le recupero»
dissi a Julia, e stavo piegandomi
quando mi caddero gli occhiali dal
naso. Un cameriere di passaggio,
nello sforzo di tenere in equilibrio il
vassoio per non versare il caffè dalle
tazzine, scalciò gli occhiali sul
marciapiede, proprio sul percorso di
Edward Freleng. Fu lui che li
calpestò.
«Oh,
accidenti»
esclamò,
raccogliendo quel che restava della
montatura. «Di chi sono questi?»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :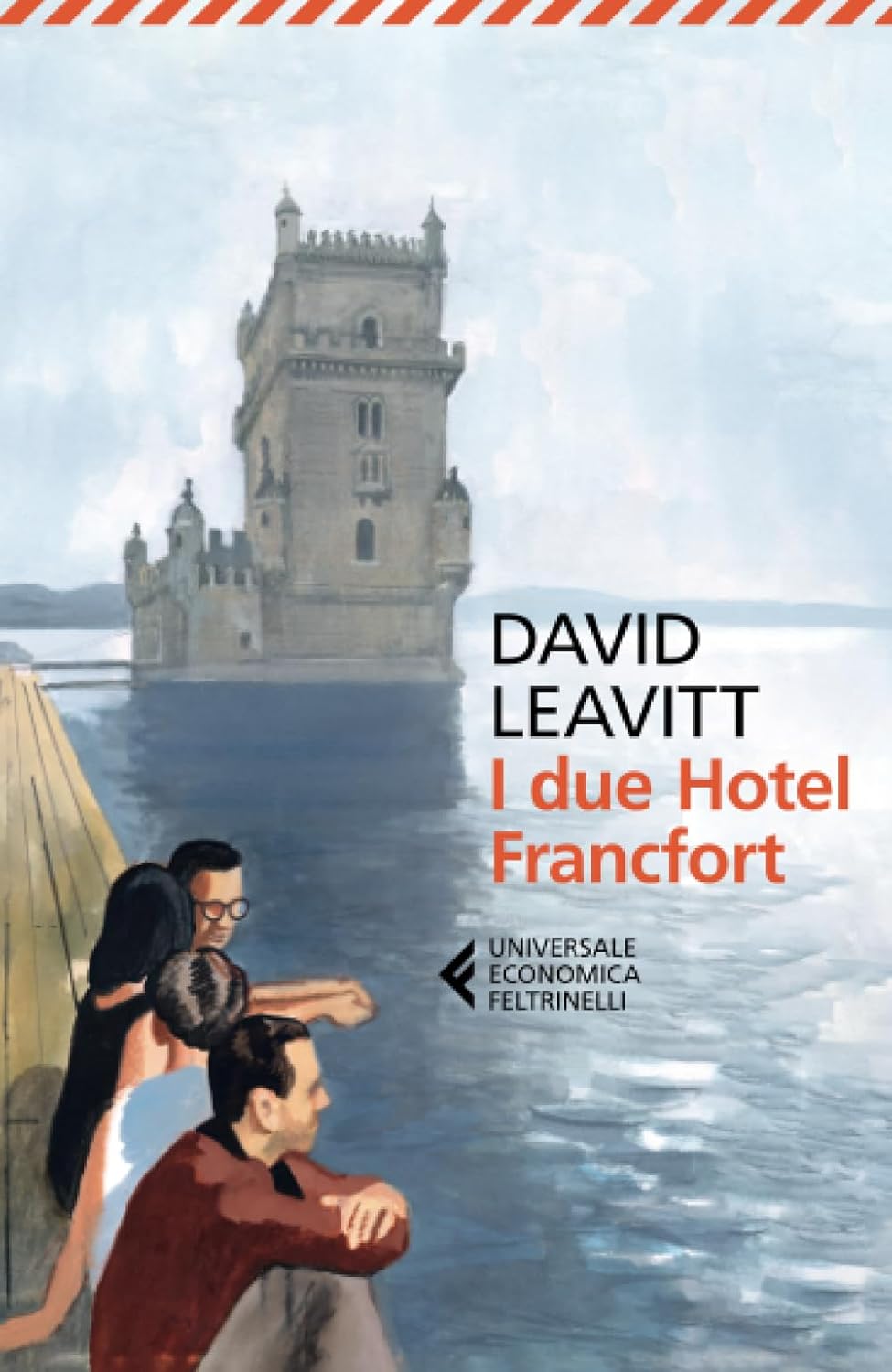






Commento all'articolo