A conti fatti – Quarant’anni di capitalismo italiano – Franco Bernabè
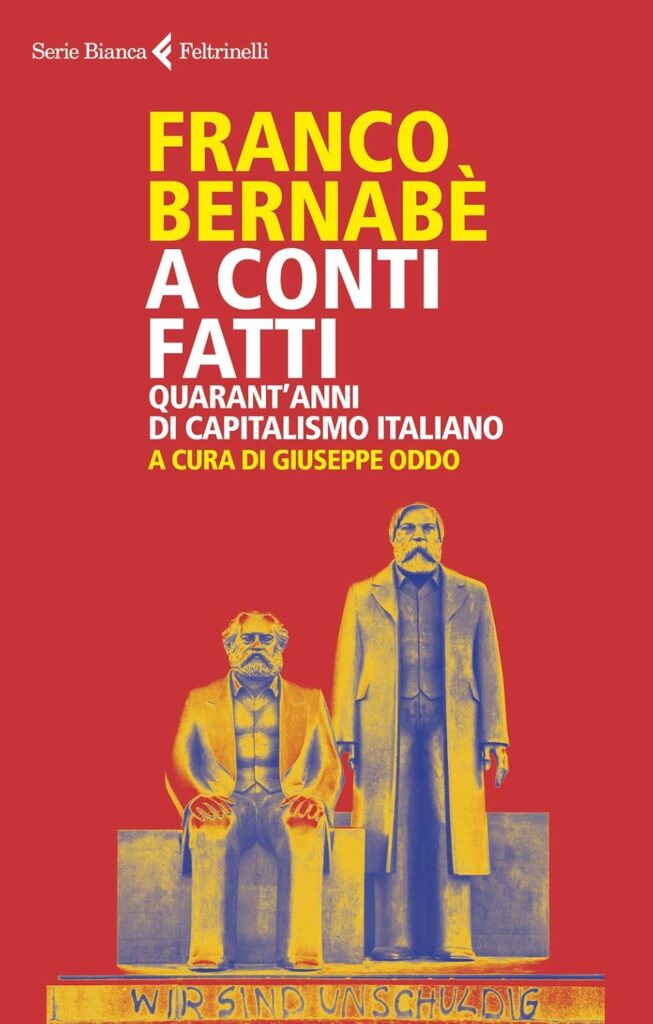
SINTESI DEL LIBRO:
La statua di Karl Marx e Friedrich Engels era ancora al suo posto
in un’area un po’ appartata tra la Karl Liebknecht Strasse e la
Spandauer Strasse in quello che fino a poco tempo prima era stato il
centro di Berlino Est. Lo scultore che l’aveva realizzata, Ludwig
Engelhardt, l’avrebbe voluta all’estremità occidentale della piazza,
dove in precedenza si trovava un importante monumento del periodo
guglielmino, ma le autorità della Germania comunista, che forse
avevano percepito i primi scricchiolii del sistema, avevano optato per
una posizione più discreta. Sulla base di granito che reggeva
l’imponente gruppo in bronzo qualcuno aveva scritto con mano
malferma Wir sind unschuldig: “Siamo innocenti”. Testimonianza
discreta e malinconica di una rivoluzione che aveva cambiato la
storia.
Era l’autunno 1990 e la riunificazione delle due Germanie era stata
dichiarata da pochi giorni. Il tempo a Berlino era umido e nebbioso,
ma avevo deciso di vedere la città a pochi mesi dalla caduta del
Muro e avevo convinto mia moglie, Grazia, a seguirmi con la scusa
di una visita all’“Isola dei musei” finalmente accessibile senza la
necessità di visti. A Mitte, il quartiere che oggi è il centro artistico e
culturale di Berlino e che nella Germania comunista avrebbe dovuto
rappresentare la celebrazione monumentale del regime, erano
ancora visibili i segni del passato accanto alla straordinaria
eccitazione del presente. Le numerose brecce che erano state
aperte lungo il Muro, nei tratti in cui non era stato abbattuto, erano la
rappresentazione tangibile della caduta della cortina di ferro che
aveva diviso l’Europa in due.
Gli avvenimenti che si erano susseguiti nei paesi dell’Est nel corso
del 1989 avevano avuto un effetto dirompente. Nel giro di pochi mesi
i
regimi comunisti del Vecchio continente erano stati travolti. Tutto
era cominciato in Polonia, dove alle elezioni di giugno il sindacato
cattolico di Lech Wałesa, Solidarność, aveva conquistato una
larghissima maggioranza in parlamento. Dalla Polonia il movimento
si era esteso all’Ungheria e poi alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria, ai
paesi baltici. Era la vittoria della democrazia sul comunismo ma
anche l’inizio di una profonda trasformazione delle economie
occidentali. L’eccitazione per il cambiamento era tale che il politologo
americano Francis Fukuyama, in un impeto di entusiasmo, s’era
avventurato a proclamare, in un suo celebre saggio, la fine della
storia: l’adesione alle regole del capitalismo e ai principi della
democrazia liberale come punto d’arrivo dello sviluppo umano e
l’avvio di una fase di prosperità e di pace che avrebbe mutato i
destini dell’umanità.
Economia mista al capolinea
Il vento del cambiamento in tutta Europa stava spazzando via il
modello di economia mista che aveva favorito la rinascita dopo la
guerra. Un modello in cui convivevano intervento pubblico e
iniziativa privata, con la spesa pubblica ad alimentare investimenti
infrastrutturali e trasferimenti dello Stato. Le origini culturali del
cambiamento risalivano agli anni settanta: a Friedrich von Hayek e a
Milton Friedman, premi Nobel per l’economia, alle teorie di Michael
Jensen e di William H. Meckling sulla creazione di valore per
l’azionista come solo fine dell’impresa e alle osservazioni dello
stesso Friedman sulla natura dell’impresa. All’inizio degli anni ottanta
questa scuola di pensiero s’era tradotta in concreti programmi politici
che richiedevano un ambiente macroeconomico senza inflazione,
una concorrenza libera di operare su qualsiasi mercato, compreso
quello del lavoro, e nessun intervento dello Stato in economia.
La ricetta fu applicata inizialmente nei paesi anglosassoni. Nel
1981 il presidente americano Ronald Reagan licenziò in tronco
11.359 controllori di volo che scioperavano, sostituendoli con i
militari. E altrettanto dura fu nel 1984 la premier britannica
conservatrice Margaret Thatcher con i minatori in sciopero: protesta
culminata nella progressiva chiusura dei pozzi carboniferi dello
Yorkshire, della Scozia, del Galles e del Nottinghamshire.
In Italia, come spesso accade, il vento del cambiamento era una
leggera brezza che alimentava discussioni accademiche e dibattiti
televisivi, ma che incideva poco sugli assetti di potere reali. Mentre
nel resto d’Europa ribolliva la più grande trasformazione dalla fine
della
guerra, a Roma il 23 luglio 1989 s’insediava il
quarantasettesimo governo della repubblica. Lo aveva formato Giulio
Andreotti, campione di longevità politica, che sedeva in parlamento
ininterrottamente dal lontano giugno 1946. Niente lasciava presagire
la drammaticità degli eventi che sarebbero esplosi di lì a poco. Ma
sotto la superficie stagnante della politica, anche nel nostro paese
maturavano tempi nuovi.
Sentimenti contrastanti
Si arrivò così al 1992, alla vigilia dell’uragano giudiziario che
avrebbe travolto la vecchia classe politica e mutato l’assetto
economico, finanziario e sociale del paese. A fine gennaio era stata
promulgata una legge che imponeva l’obbligo, per i comuni di
residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato,
1un inizio
rassicurante per un anno che sarebbe stato di rottura nella storia
italiana. Si avvertivano sentimenti contrastanti: da un lato,
l’insofferenza crescente verso un sistema sempre più fossilizzato,
dall’altro l’assuefazione ai personaggi che si muovevano sulla scena
politica da oltre quarant’anni. Che Andreotti potesse essere eletto
presidente della Repubblica alla scadenza del mandato di Francesco
Cossiga sembrava del tutto naturale. Anche l’arresto di Mario
Chiesa, con l’imbarazzante dettaglio dei 7 milioni di lire di tangente
finiti nella tazza del water, sembrava l’ennesimo episodio di un
sistema corruttivo tollerato, se non addirittura considerato normale.
L’unico aspetto che rendeva particolarmente antipatica la vicenda
era il fatto che coinvolgeva una veneranda istituzione benefica
milanese, il Pio Albergo Trivulzio.
Da parte mia, gli appuntamenti previsti per quell’anno rientravano
nella normalità di una famiglia piccoloborghese con salde tradizioni
cattoliche e poche distrazioni mondane. I più importanti erano la
cresima di mio figlio e la prima comunione di mia figlia, con la
conseguente discesa a Roma dei parenti dal Nord. Nutrivo solo
qualche timore per il mio futuro in Eni, dove ero stato chiamato quasi
dieci anni prima da Franco Reviglio e avevo assunto crescenti
responsabilità, fino a diventare direttore centrale per la
Pianificazione, sviluppo e controllo. A preoccuparmi erano i continui
dissidi con la giunta esecutiva sulla questione della privatizzazione.
Ero convinto che la trasformazione in Spa, di cui tutti parlavano ma
che pochi volevano, avrebbe contribuito a liberare le energie
imprenditoriali di Eni, che vedevo mortificate dalla politica.
Viceversa, la giunta, massimo organico decisionale del gruppo, i cui
componenti erano designati dai partiti di governo, voleva ad ogni
costo mantenere lo status quo per non alterare gli assetti di potere.
Presto o tardi si sarebbero liberati di me. Per loro ero una specie di
grillo parlante senza referenti politici, di cui avrebbero fatto volentieri
a meno. Pensavo che se avessi dovuto lasciare Eni sarei tornato a
Torino, città che amavo molto, dove in Fiat avevo mosso i primi passi
della carriera.
Lo stragismo mafioso fa precipitare gli eventi
Dopo la felice parentesi della messa a dimora degli alberi per i
neonati, ci pensò la Cassazione, con la sentenza definitiva sul
maxiprocesso contro la mafia, a dare il segno della drammaticità dei
problemi che il paese stava affrontando. Il dibattimento si era
concluso con 360 condanne, 19 ergastoli in carceri di massima
sicurezza e il sequestro di un immenso patrimonio in mano
all’organizzazione criminale. Un colpo tremendo per Cosa nostra,
che reagì contro lo Stato e contro i suoi rappresentanti con logica
militare e potenza di fuoco senza precedenti. Il primo a cadere sotto i
colpi dei sicari fu Salvo Lima, il plenipotenziario di Andreotti in Sicilia,
che rappresentava l’anello di congiunzione tra politica e criminalità
organizzata. Ma l’offensiva era solo all’inizio. A Palermo stava per
arrivare il tritolo con cui sarebbero stati massacrati i due magistrati
più esposti e più determinati nella lotta contro i boss. In maggio era
toccato a Giovanni Falcone, a sua moglie e alla sua scorta, uccisi da
una devastante esplosione che aveva fatto saltare in aria un tratto di
autostrada tra Punta Raisi e Palermo, e in luglio a Paolo Borsellino e
alla
sua squadra di agenti, carbonizzati da un’autobomba
parcheggiata in via d’Amelio.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :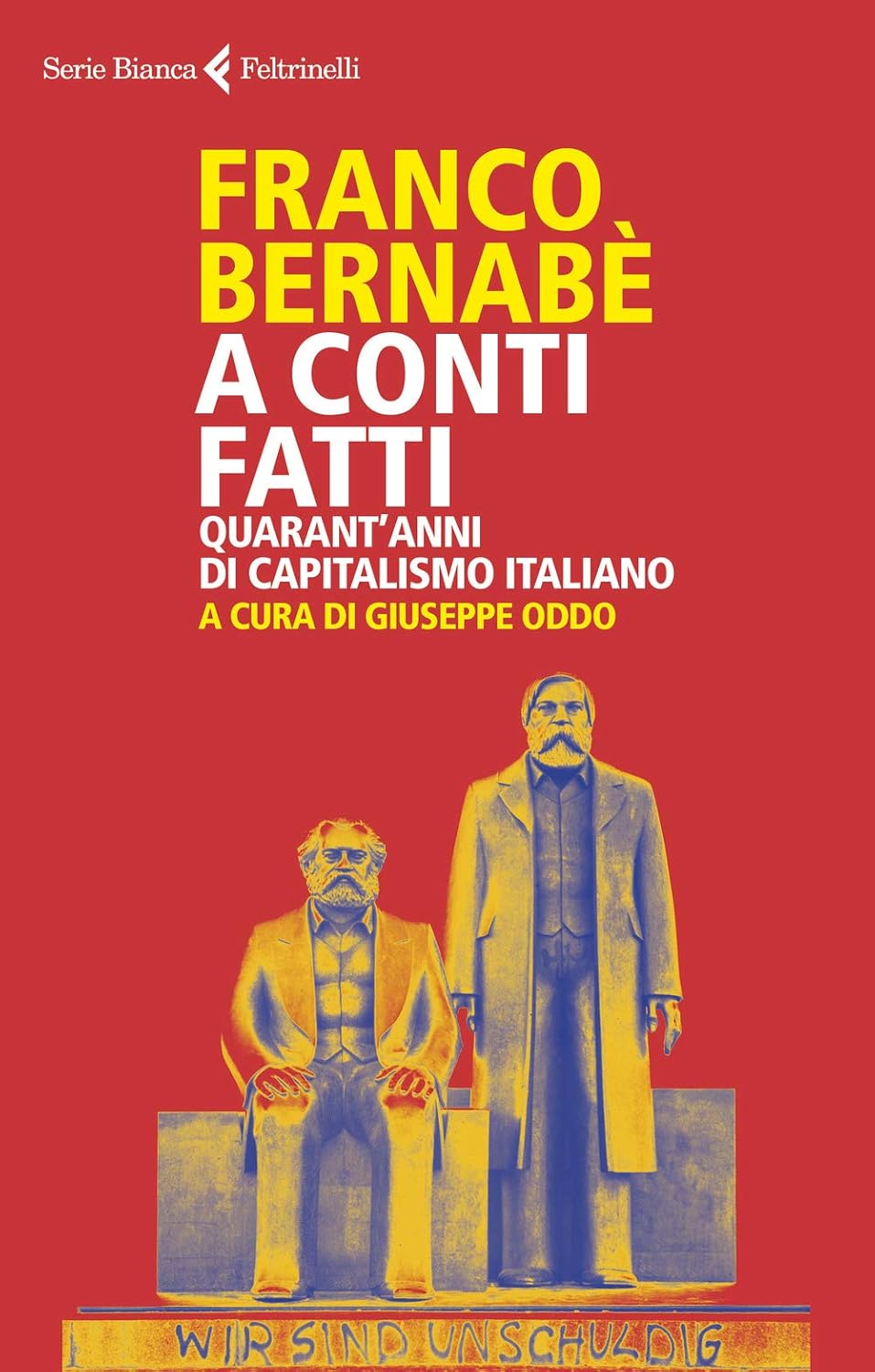






Commento all'articolo