Londra – Una biografia – Peter Ackroyd
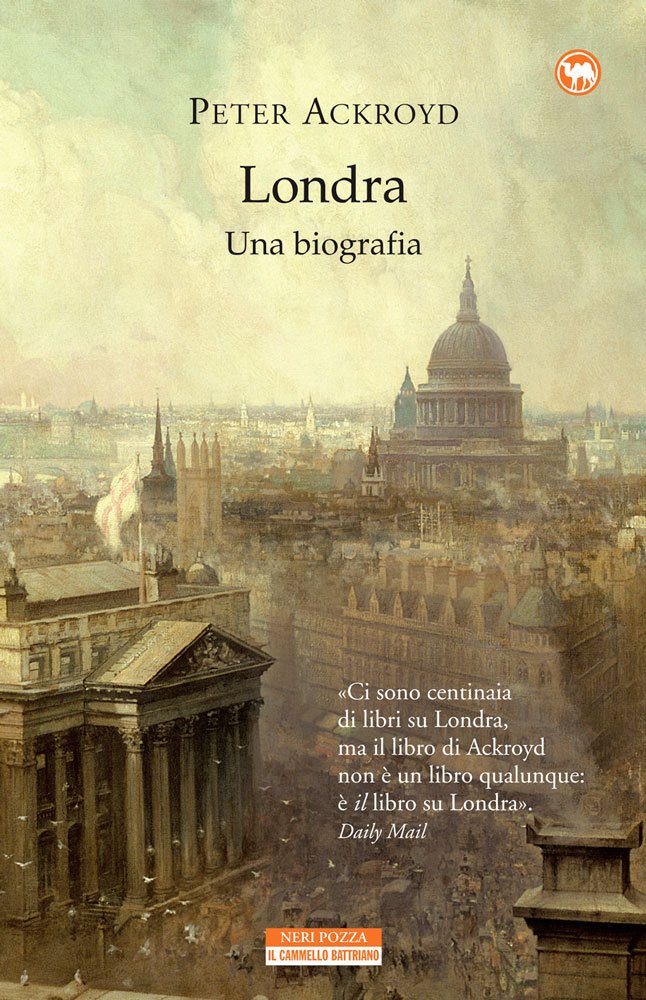
SINTESI DEL LIBRO:
Se vi venisse in mente di toccare il basamento su cui poggia la
statua equestre di Carlo I a Charing Cross, le vostre dita potrebbero
posarsi sulle sporgenze fossili di gigli, stelle e ricci di mare. Esiste
una fotografia della statua scattata nel 1839: con le carrozze di
piazza e i ragazzini dai cappelli a tubo di stufa, la scena appare già
remota; immaginatevi allora quanto sia lontana la vita di quelle
piccole creature marine. C’era una volta una canzonetta intitolata
«Perché non possiamo avere il mare a Londra?» ma la domanda è
superflua; i luoghi dove ora sorge la capitale, cinquanta milioni di
anni orsono, erano ricoperti da acque profonde.
Ancora oggi le acque non si sono completamente ritirate, e le
prove della loro esistenza sono nelle consunte pietre di Londra. La
pietra di Portland della Custom’s House e della St Pancras Old
Church ha una stratificazione diagonale che riproduce le correnti
dell’oceano; nella struttura della Mansion House e del British
Museum si trovano antichi gusci d’ostrica. Nel marmo grigiastro della
Waterloo Station si possono ancora vedere le alghe e nei
sottopassaggi pedonali scorgerete la forza degli uragani nella pietra
segnata dai passi. Nella struttura del ponte di Waterloo è possibile
anche osservare il letto del mare del Giurassico Superiore. Perciò le
maree e le tempeste sono attorno a noi, e come scrisse Shelley di
Londra, «quel grande mare… mugghia alto ancora».
Londra è sempre stata un vasto oceano in cui la sopravvivenza è
incerta. La cupola di St Paul è stata vista fluttuare sulla superficie di
un indistinto, agitato mare di nebbia, mentre scure correnti di folla
fluiscono attraverso il Ponte di Londra, o quello di Waterloo, ed
emergono come torrenti nelle strette vie della città. Gli assistenti
sociali di metà Ottocento parlavano di soccorrere «annegati» a
Whitechapel o a Shoreditch, e Arthur Morrison, un romanziere dello
stesso periodo, evoca «un mugghiante mare di naufraghi umani»,
implorando di essere salvato. Henry Peacham, il secentesco autore
di The Art of Living in London, considerava la città «un vasto mare,
con raffiche di vento, con spaventevoli e pericolosi banchi di sabbia
e scogli», mentre nel 1810 Louis Simond era lieto di «udire il ruggito
delle sue onde, che si rompono ritmicamente attorno a noi».
Se si guarda a distanza, si scorge un mare di tetti e non si
percepiscono gli scuri flussi di folla più di quanto non si possano
osservare gli abitanti di qualche sconosciuto oceano. Ma la città è
sempre un luogo di onde agitate e senza requie, con marosi,
schiuma e spruzzi. Il rumore delle sue strade è come il sussurro di
una conchiglia e nelle grandi nebbie del passato ai cittadini
sembrava di giacere nel letto dell’oceano. Perfino con tutte le sue
luci, può proprio essere ciò che Orwell descriveva come «il fondo del
mare, in mezzo a pesci che fluttuano luminosi». È questa una
visione costante dell’universo londinese, in particolare nei romanzi
del ventesimo secolo, dove un senso di disperazione e di sconforto
rendono la città un luogo di silenzi e di misteriose profondità.
Tuttavia, come il mare e il patibolo, Londra non rifiuta nessuno.
Chi si avventura nelle sue correnti cerca prosperità o fama, anche se
spesso cola a picco nei suoi fondali. Jonathan Swift raffigurava gli
speculatori di Borsa come affaristi che attendevano il naufragio per
depredare i cadaveri, mentre le ditte commerciali della City sovente
usavano una nave o una barca come segnavento e indice di
prospera fortuna. Tre dei simboli più comuni nei cimiteri cittadini
sono la conchiglia, la nave e l’ancora.
Gli storni di Trafalgar Square sono gli stessi che nidificano sulle
scogliere della Scozia settentrionale. I piccioni di Londra sono i
discendenti dei colombi selvatici delle rocce che vivevano sulle erte
falesie delle coste settentrionali e occidentali dell’isola. Per loro, gli
edifici della città sono ancora scogliere, e le vie il mare infinito che vi
si stende attorno. Ma la vera convergenza sta nel fatto che Londra,
tanto a lungo signora dei commerci e dei mari, abbia impressa nella
sua struttura la silenziosa firma delle maree e delle onde.
E quando le acque si ritirarono, la terra di Londra si palesò. Nel
1877, in un tipico grande esempio di tecnologia vittoriana, fu
trivellato un pozzo profondo 349 metri all’estremità sud di Tottenham
Court Road. Esso passò attraverso centinaia di milioni di anni,
raggiungendo la primordiale morfologia della città, e le prove
ricavate ci permettono di datare le stratificazioni che abbiamo sotto i
piedi a partire dal Devoniano fino al Giurassico e al Cretaceo. Sopra
questi strati giacciono 200 metri di gesso, i cui affioramenti si vedono
nei Downs o nei Chilterns come nel bordo del London Basin, quel
basso declivio a forma di piattino nel quale riposa Londra. Sopra il
gesso si stende la densa creta di Londra, coperta a sua volta da
depositi di ghiaia e di argilla. Qui, allora, sta la fabbrica della città, in
più di un senso: la creta, il gesso e l’argilla per circa duemila anni
sono stati impiegati per costruire le abitazioni e gli edifici pubblici. È
quasi come se la città si sia innalzata da sé dalle proprie origini
primordiali, creando un insediamento umano dall’inanimata materia
del passato.
Questa argilla viene combusta e compressa a formare il London
Stock, il mattone bruno-giallastro o rosso che ha fornito il materiale
per eccellenza dell’edilizia londinese, e che rappresenta l’autentico
genius loci. Christopher Wren sosteneva che «la terra attorno a
Londra, correttamente trattata, produrrà un mattone buono come lo
erano quelli romani… e che durerà, nel nostro clima, più a lungo di
ogni altra pietra prodotta dalla nostra isola». William Blake definiva i
mattoni di Londra «emozioni ben forgiate», intendendo che il
convertire creta e gesso per la fabbricazione delle strade
rappresentava un processo di civilizzazione che saldava la città con
il suo antichissimo passato. Le case del diciassettesimo secolo
erano fatte della polvere che si era accumulata sulla regione di
Londra in un’era glaciale venticinquemila anni prima.
L’argilla di Londra può recare anche testimonianze tangibili:
scheletri di squali (nell’East End era credenza popolare che i denti di
squalo curassero i crampi), il cranio di volpe a Cheapside, e
coccodrilli nella creta di Islington. Nel 1682 Dryden così salutava
questo ormai dimenticato e invisibile panorama di Londra:
Ancor troviamo mostri della tua gran crescita
Che ti lasciasti dietro.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo