Piantare uomini: Danilo Dolci sul filo della memoria – Giuseppe Casarrubea

SINTESI DEL LIBRO:
Sežana, cittadina di oltre dodicimila abitanti, nel cuore del Carso, a pochi
chilometri da Trieste, è il punto di partenza di questo libro. Qui nasce, il 28
giugno 1924, Danilo Dolci e qui troviamo i segni di una storia diventata,
grazie a questo personaggio, anche un pezzo della nostra memoria e di una
vicenda comune. O, meglio, l’emblema di quel senso delle cose che trovano
una loro spiegazione se si colgono i fili che le legano. Come in una tela, in un
mosaico o in una ragnatela dai segni geometricamente perfetti. Oggi
appartiene alla Slovenia ma in quell’anno è italiana dai tempi del Trattato di
Rapallo del 1920, e lo sarà ancora fino al trattato di pace di Parigi nel 1947,
quando sono definiti i confini nord-orientali dell’Italia. Sežana si situa, dal
punto di vista culturale e geografico, all’opposto dei luoghi dove Danilo
decide di vivere, dopo averli scelti come meta finale del suo viaggio: approdo
fisico e messaggio finale della sua esperienza di intellettuale impegnato e
coerente. In questa cittadina, a fasi alterne, passa alcuni anni della sua
infanzia e della sua adolescenza, attraversando il ventennio nero come uno
scenario tetro della sua vita fino all’occupazione fascista della Slovenia, nel
1941. In quest’anno Mussolini si spartisce la Jugoslavia con i nazisti,
ponendo il suo quartiere generale a Lubiana. Una regione dell’Europa e una
città martiri, come l’Italia, o Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato,
Partinico e tanti altri comuni della nostra penisola in cui la follia del regime
fascista, anche dopo il 25 aprile 1945 o negli anni della nascita della
Repubblica, compie stragi inaudite. Si ripetono, alla fine degli anni Quaranta,
in Sicilia, le tragedie subite dieci anni prima da sloveni e croati, colpevoli
soltanto di parlare un’altra lingua e di avere usi e costumi diversi. Sežana,
come Opicina, ha una storia legata anche a Trieste. Città che riescono ad
avere la virtù della grazia e della leggerezza. Di una certa rarefazione.
Lasciano la sensazione del mondo onirico e irreale di cui sono fatte.
Centro di battaglie e luogo di scoperta di alcuni caratteri propri degli
italiani, Trieste è una città che può sembrare lontana e irraggiungibile. Odiata
e amata, anche da quelli che l’hanno prescelta come luogo in cui abitare. Non
è però una città che si possa «indossare» tutti i giorni, come un vestito per i
giorni feriali, quando si è costretti a sporcarsi, lavorando. È, al contrario,
come un abito per la domenica o per le feste comandate, un capo per eventi
eccezionali, situazioni rare. Oppure come un’alunna brava trattata da un
professore non proprio imparziale alla stregua dell’ultima della classe.
Ragazza desiderata e distante nel lungo sonno di un soldato irrequieto, in
continua guerra con se stesso. Città che un non meglio definibile
immaginario giovanile vede come una adolescente in continuo divenire,
innocente e carica allo stesso tempo di antica saggezza, con la sua storia
consapevole, il suo presente, il suo futuro. A svegliarsi, però, si avverte il
bisogno della serenità del giudizio, per evitare, dopo il torpore, il ritorno
violento alla realtà, di spezzare l’aria che ci aveva pervaso. È la condizione di
molti scrittori che con Trieste hanno dovuto fare i conti, mettendo alla prova
la propria ragione e i propri sentimenti: dall’algerino Khaled Fouad Allam,
allo spagnolo J.A. González Sainz, dalla jugoslava Kenka Lekovich, alla
francese Alexandrine De Mun, o all’argentino Juan Octavio Prenz o, ancora,
all’austriaco Hans Raimund. Approcci tutti diversi, come diversa, intimistica
e attenta alla psicologia umana, appare la lettura che ne fa Italo Svevo, che a
Trieste è nato.
Questa è anche la città di Umberto Saba, delle osterie e dei caffè che egli
frequentava, dei «cantucci» dove il poeta soleva rifugiarsi per sentire la sua
città piena di una «scontrosa grazia», come un «ragazzaccio […] con occhi
azzurri e mani troppo grandi / per regalare un fiore». È anche la città dello
scrittore irlandese James Joyce. Tutta ancora percorribile, con i suoi spazi, i
suoi luoghi letterari, come un grande laboratorio di civiltà, punto di
convergenza tra est e ovest, nord e sud. Con la sua storia culturale e politica è
anche una città che ci ammonisce. Senza di essa non ci sarebbe stato Danilo
Dolci.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :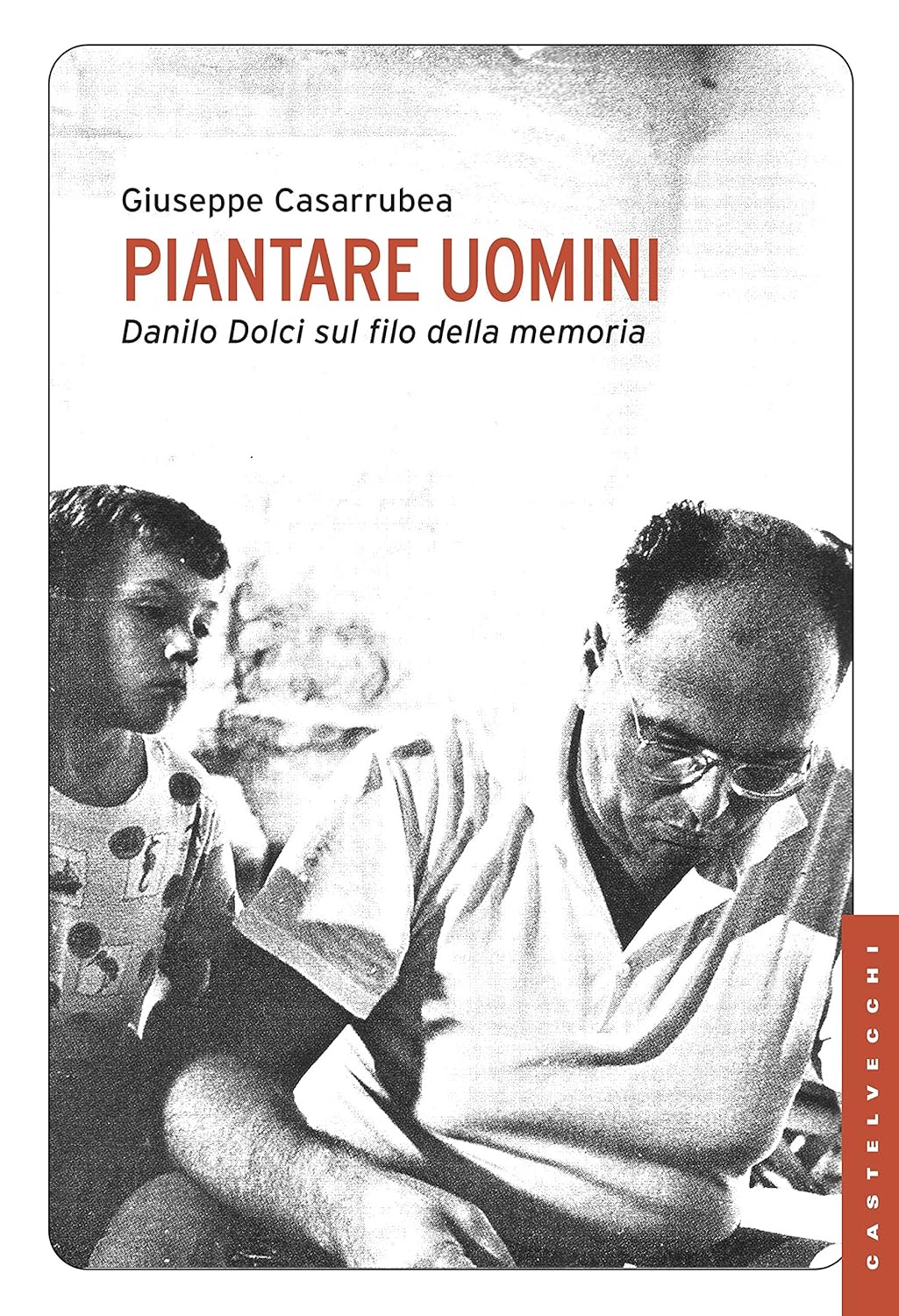



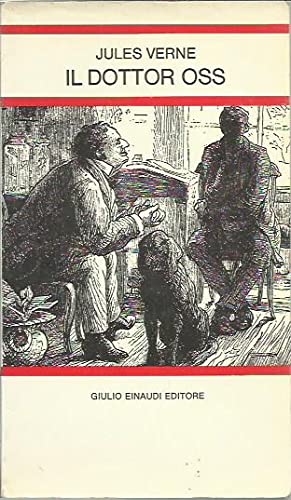
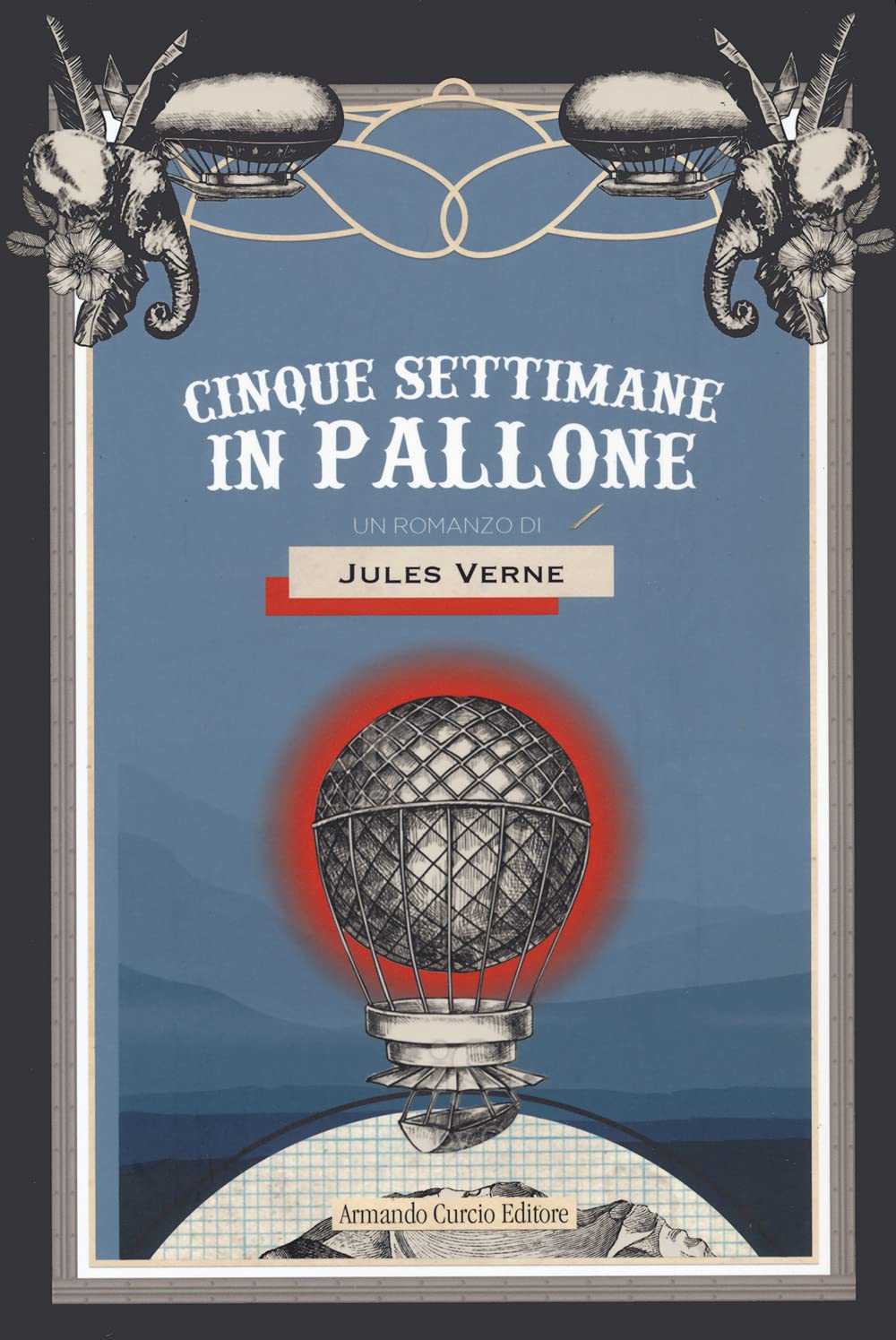
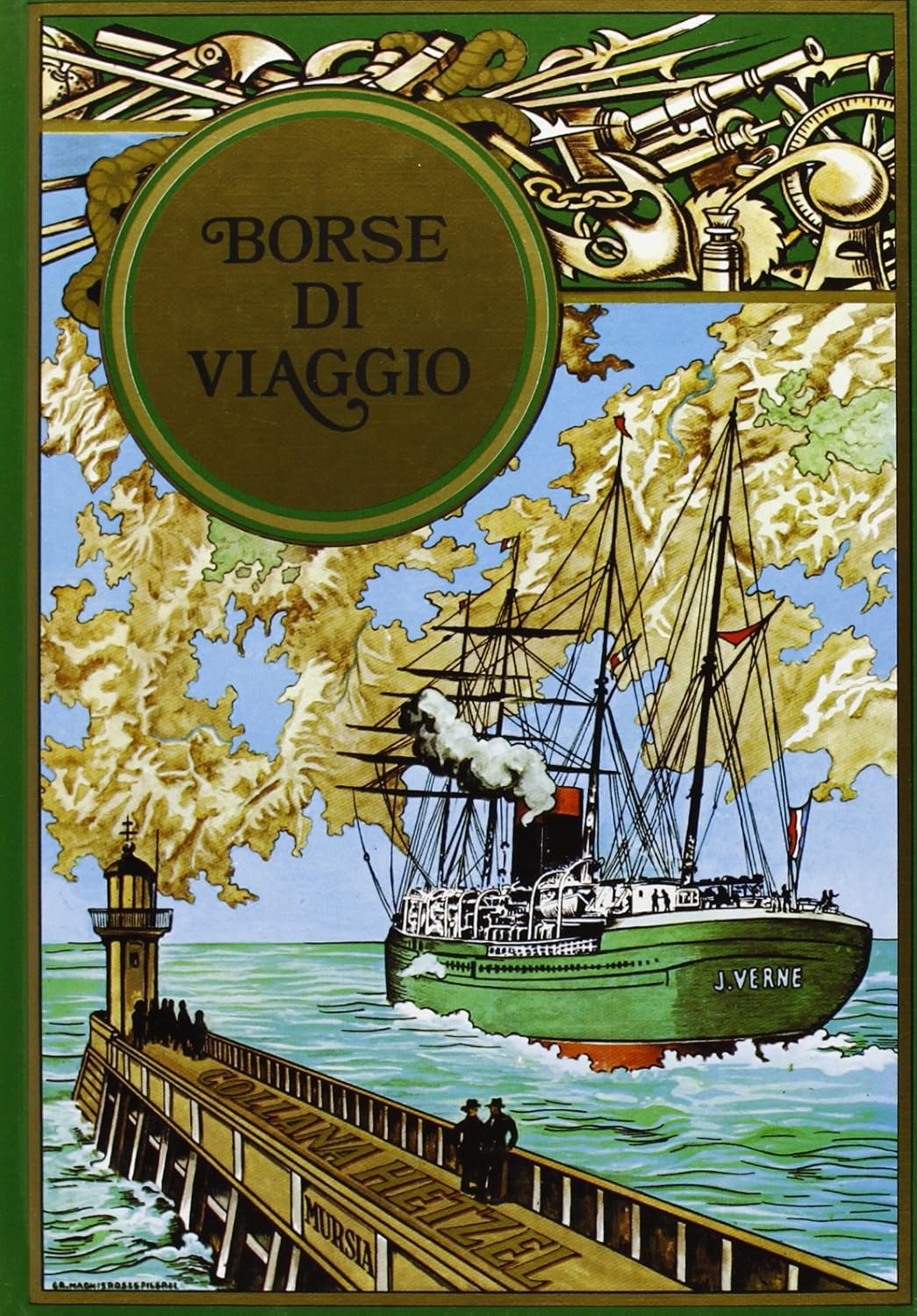
Commento all'articolo