La tentazione del muro – Lezioni brevi per un lessico civile – Massimo Recalcati
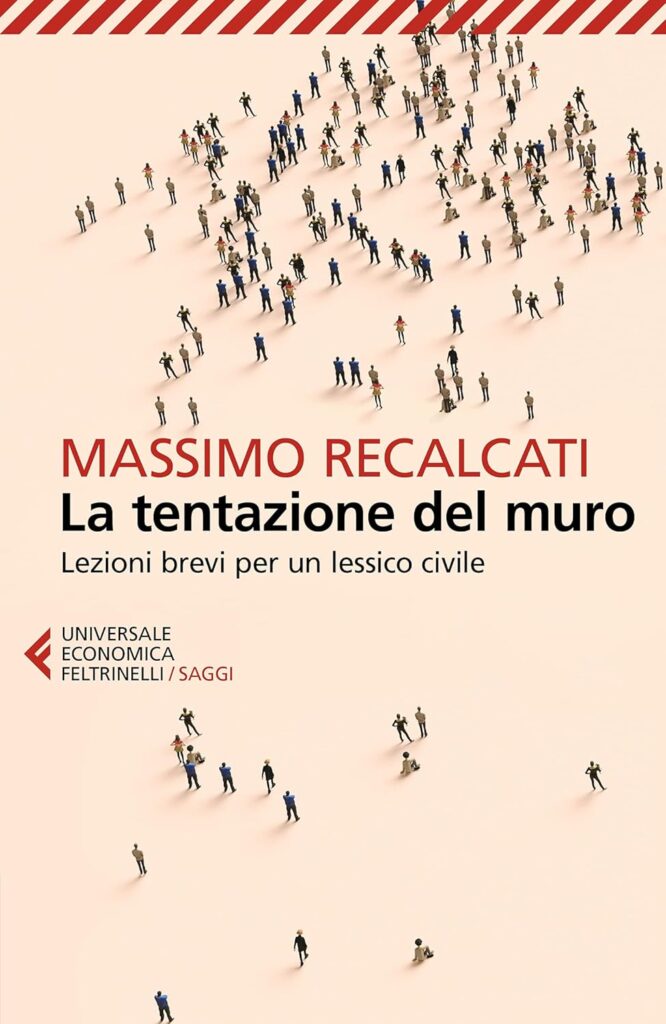
SINTESI DEL LIBRO:
La vita umana necessita del sentimento di appartenenza, del
radicamento al suolo, dell’identità, della famiglia. Non esiste lessico
civile che non tenga conto dell’importanza del confine. Freud
costruisce la psicoanalisi come una scienza dei confini tra le diverse
province psichiche (inconscio, preconscio, coscienza) e le diverse
istanze interne (Es, Io, Super-io). Bion insiste, con il linguaggio della
psicoanalisi, sull’importanza della “barriera di contatto” che separa il
conscio dall’inconscio, l’interno dall’esterno, il me dal non-me. Senza
esistenza del confine la vita precipita nell’indifferenziato, nel caos,
nell’indistinto.
La domanda di identità e di radicamento accompagna la vita
umana sin dalla sua venuta al mondo: appartenenza a una cultura di
gruppo, condivisione di un mondo, filiazione, genealogia, stirpe,
discendenza. Non esiste vita umana senza la memoria delle sue
radici. Se la vita viene alla vita senza protezione, nello sconforto,
esposta all’ingovernabilità del mondo, sommersa nella sua inermità,
il primo grido del bambino si configura come appello, invocazione,
domanda di soccorso e di aiuto rivolta all’Altro. È la socialità
fondamentale dell’esistenza. Nessuno si salva da solo; senza l’Altro
la vita cade nel nulla.
Tuttavia, in un modo che può suonare paradossale, Freud
immagina che il primo compito della vita sia anche quello di
costruirsi una “nicchia protettiva” di fronte alle potenti e incontrollabili
stimolazioni che provengono dall’interno del proprio corpo e dal
mondo esterno. La vita umana ai suoi inizi assomiglia a quella di un
“uccellino rinchiuso nel guscio dell’uovo con la sua provvista di
alimento” che deve offrire riparo alla vita ancora inerme e
vulnerabile.4 È questa una spinta primaria della pulsione: la vita
umana si deve difendere dal mondo vissuto come fonte di minacce.
Di qui l’importanza insuperabile di un’istituzione umana come quella
della famiglia. La vita del figlio esige di essere inscritta in un
processo simbolico di filiazione.
Non bisogna dunque liquidare la spinta dell’uomo a difendere i
confini della propria vita individuale e collettiva come una spinta in sé
barbara o incivile. È un’indicazione che viene da Freud stesso: la
vita individuale, come quella collettiva, necessita di protezione, di
rassicurazione, edifica barriere per poter sopportare l’avversità del
mondo. Gli esseri umani hanno da sempre protetto la loro esistenza;
dalla potenza inumana della natura e dalla minaccia dei nemici. La
spinta a delimitare il proprio territorio è un’espressione del carattere
primariamente securitario della pulsione. Il gesto di tracciare il
confine è un’operazione necessaria alla sopravvivenza della vita. La
vita ricerca primordialmente il rifugio dalla vita e, al tempo stesso, la
definizione di confini in grado di circoscrivere la propria identità. Lo
sradicamento che caratterizza la venuta della vita al mondo –
nessuno nasce scegliendo di nascere, nessuno è padrone delle sue
origini – viene compensato da un’aspirazione al radicamento nel
luogo dell’Altro (famigliare, sociale, culturale). Senza radici e senza
confini verrebbe infatti meno il sentimento stesso dell’identità di un
soggetto individuale come di un soggetto collettivo, dell’Io come di
un popolo. Non a caso nell’esperienza clinica l’assenza di confine
definisce la vita schizofrenica: vita radicalmente smarrita, errabonda,
disgregata, frammentata.
Tuttavia l’esistenza umana non è solamente desiderio di
appartenenza e di rassicurazione, ma è anche spinta all’erranza,
desiderio di libertà. Se il desiderio di appartenenza include la vita
individuale in una comunità (per esempio quella della famiglia)
offrendole diritto di cittadinanza, protezione e sicurezza, esso non
può pretendere di esaurire la forma umana della vita. Il desiderio di
erranza è desiderio di libertà, desiderio del viaggio, dell’avventura,
del superamento del confine, che risulta altrettanto importante della
necessità della sua esistenza. Non a caso la malattia di un individuo
o di una comunità è sempre legata allo sbilanciamento di questo
rapporto. Se, per un verso, l’eccesso di appartenenza comporta la
chiusura su se stessi, l’irrigidimento del confine, il conformismo, la
massificazione, l’esclusione della differenza, per un altro verso
l’eccesso di erranza comporta la recisione delle radici e la perdita del
sentimento di identità, lo sbandamento, lo smarrimento, sino al
colmo della perdita di se stessi. Sono i due modi che caratterizzano
la frattura della “proporzione antropologica”5
tra la necessità
impellente del confine e la necessità, altrettanto impellente, del suo
trascendimento.
Quando il sentimento dell’appartenenza prevale su quello della
libertà si genera malattia della vita, che nel nome dell’adesione
conformistica alla propria cultura di provenienza finisce per
rinunciare alla sua libertà, per sacrificare la propria libertà
all’esigenza della propria sicurezza. In questo caso tutto ciò che
oltrepassa il confine, tutto ciò che vive al di là delle proprie frontiere
– individuali e collettive – è vissuto come fonte di minaccia
permanente. Quando invece prevale a senso unico – sproporzionato
antropologicamente – la dimensione dell’erranza e della libertà su
quella dell’appartenenza, quando la vita si sradica, sconfina
rifiutando ogni legame e ogni discendenza, quando brucia ogni cosa
nel nome di una libertà che si vuole assoluta, allora vengono
strappati i vincoli simbolici che danno alla vita il diritto di cittadinanza
nella comunità umana.
La malattia incivile del muro
Kafka in Durante la costruzione della muraglia cinese offre
un’illustrazione precisa della patologia che può investire la
dimensione simbolica del confine:
Da chi doveva proteggere la grande Muraglia? Dai popoli del nord. Io sono oriundo della
Cina sudorientale. Nessun popolo settentrionale ci può minacciare. Di loro leggiamo nei
libri dei vecchi, le crudeltà che commettono secondo la loro natura ci fanno sospirare
nelle nostre pacifiche verande. Nei quadri realistici degli artisti vediamo quelle facce di
dannati, le bocche spalancate, le mascelle armate di gran denti aguzzi, gli occhi stretti
che pare stiano già a spiare la preda che la bocca maciullerà e sbranerà. Quando i
bambini fanno i cattivi mostriamo loro questi quadri, ed essi si rifugiano piangendo tra le
nostre braccia. Di quei popoli settentrionali però non sappiamo altro. Non li abbiamo mai
visti e se non ci allontaniamo dal nostro villaggio non li vedremo mai, neanche se in
groppa ai loro cavalli selvaggi si lanciassero direttamente verso di noi – troppo grande è il
paese e non li lascerebbe avvicinarsi, disorientati si smarrirebbero nell’aria.6
Lo straniero che abita al di là del confine – “i popoli del nord” – è,
proprio in quanto straniero, una minaccia insidiosa rispetto alla quale
dobbiamo rafforzare i nostri confini. L’estensione infinita della
muraglia descritta da Kafka deve poter esorcizzare questa minaccia
creando un baluardo invalicabile. Lo straniero viene vissuto come
un’entità maligna e crudele capace di violare l’intimità delle nostre
famiglie. È il principio basico di ogni sviluppo patologico di tipo
paranoide dell’identità: ogni straniero porta con sé il rischio di una
contaminazione nefasta per la nostra identità; l’alterità di chi abita al
di là della frontiera è un pericolo che deve essere sventato, dal quale
bisogna difendersi. Ecco allora che il confine si sclerotizza, diviene
carapacico, si trasfigura in staccionata, filo spinato, muraglia,
appunto, arginando tutto ciò che si situa al di là di esso.
Questa metamorfosi patologica del confine dimentica di
considerare che la funzione simbolica del confine non è solo quella
di delimitare la nostra identità (collettiva o individuale), ma anche
quella di garantire lo scambio, la transizione, la comunicazione con
lo straniero. Ogni confine, infatti, definisce un’identità solo
mettendola in rapporto con una differenza. Non a caso un grande
psicoanalista come Bion riconosceva nella virtù della porosità
l’attributo fondamentale del confine. Nella spinta a innalzare steccati,
staccionate, muraglie, barriere, difese organizzate, come accade nel
nostro tempo dove sembra dominare incontrastata un’inedita
pulsione securitaria, il confine rischia invece di trasfigurarsi in muro
rendendo impossibile lo scambio.7 La chiusura finisce allora per
prevalere a senso unico sull’apertura; il sentimento di appartenenza
perde ogni contatto con quello dell’erranza e della libertà. Il confine
smarrisce la sua porosità. Ritroviamo qui le due forme maggiori di
inciviltà che sovvertono ogni lessico civile. Da una parte esiste una
patologia relativa alla dissoluzione del confine, alla sua assenza, alla
sua non iscrizione simbolica. È la patologia che trova il suo
paradigma nella schizofrenia: indistinzione, confusione, caos,
indifferenziazione. Prevalenza unilaterale dello sradicamento sul
radicamento, dell’erranza sull’appartenenza. Dall’altra parte esiste
però una patologia del confine che riguarda la sua trasfigurazione in
muro, roccaforte, bastione. In questo caso l’identità si irrigidisce
paranoicamente contro la differenza. Lo straniero coincide con il
nemico, la minaccia, l’orrore, il terrificante come abbiamo visto nella
descrizione kafkiana.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :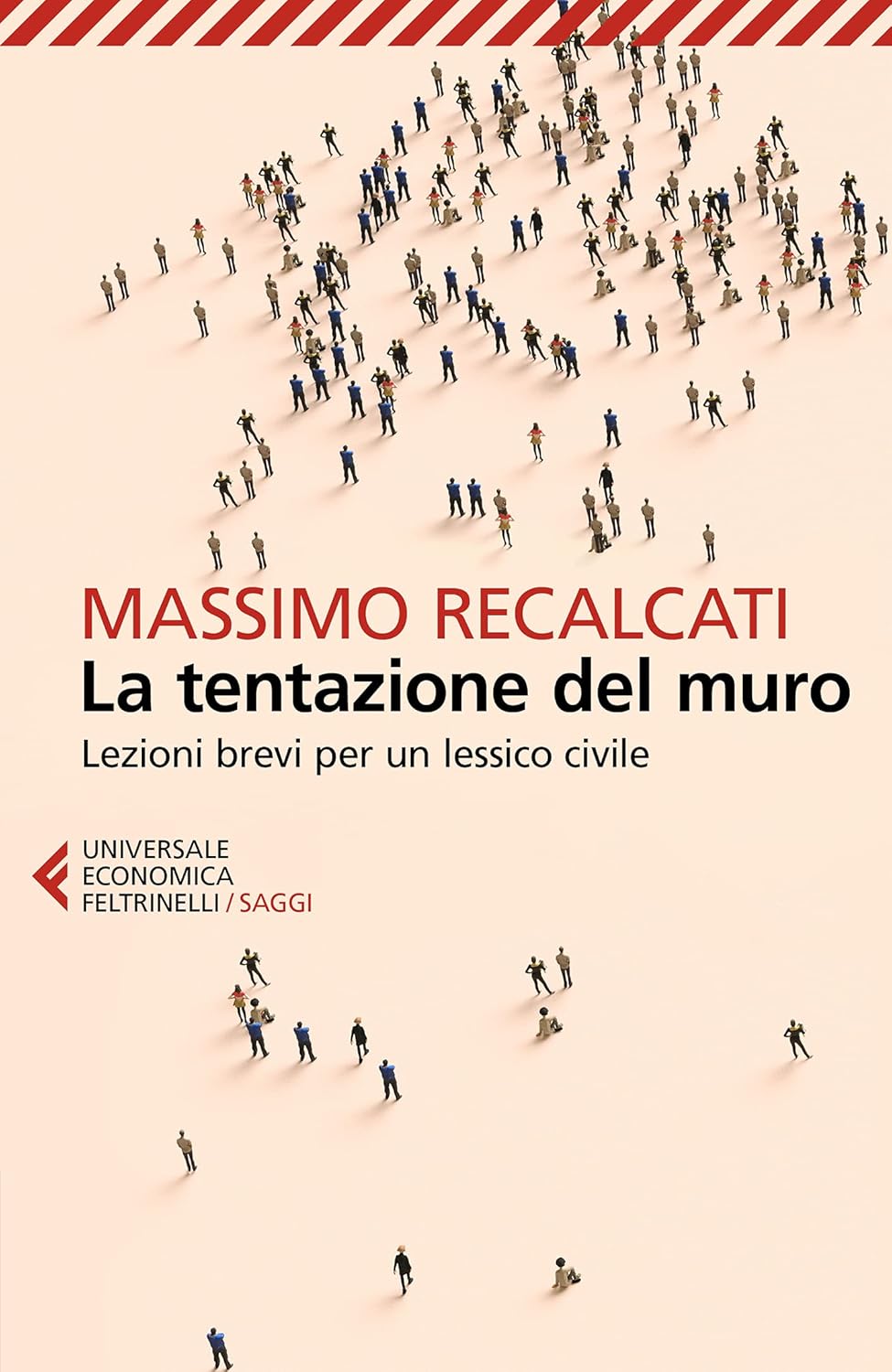






Commento all'articolo