La misura del potere – Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948 – David Bidussa
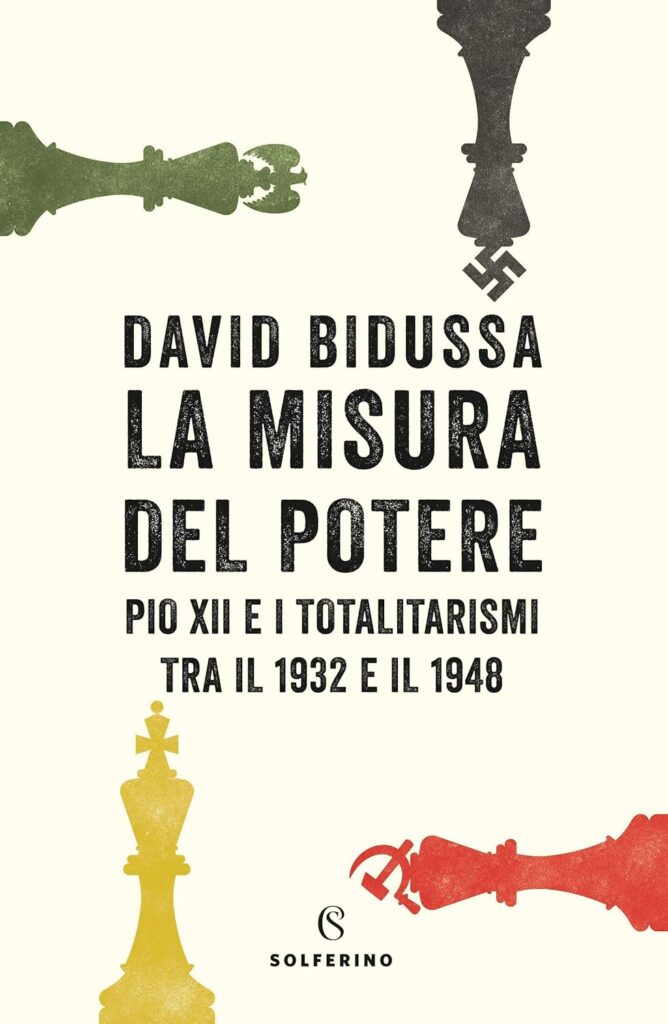
SINTESI DEL LIBRO:
Di che cosa parliamo, quando affrontiamo le scelte della Chiesa tra
anni Trenta e Seconda guerra mondiale? Per circa vent’anni
l’operato della Chiesa nel tempo dei totalitarismi (fascismi, nazismo,
comunismo sovietico) non è stato raccontato se non marginalmente
e occasionalmente. Quando quel tema è diventato prevalente ha
narrato le storie della «Chiesa del silenzio» intendendo con questa
espressione le molte storie di resistenza che hanno caratterizzato la
vita quotidiana dei fedeli e degli uomini e donne di Chiesa nel
secondo dopoguerra sotto i regimi comunisti dell’Est Europa. Forse
a lungo si è pensato di dover ritenere che questa regola, ovvero il
silenzio, indicasse un’omologa pratica di resistenza anche tra anni
Trenta e anni di guerra. Solo che non fu così. Quella pratica non
significò solo una condizione di sopruso subìto o di costrizione.
Significò inadeguatezza alla propria missione, come giustamente
richiama il 26 dicembre 1944 Albert Camus e, sulla sua scia un
decennio più tardi, ripete un grande intellettuale cattolico come
François Mauriac (vedremo, nell’ultimo capitolo, che non sarà
l’unico).
In ogni caso, è significativo che il periodo tra anni Trenta e
immediato secondo dopoguerra a lungo sia stato un non-luogo
storico nel dibattito, eccetto due voci che tuttavia rimangono
marginali nella discussione pubblica: da una parte Massimo Adolfo
Vitale, direttore del centro Comitati ricerche deportati ebrei (Crde),
che nel 1947, in una delle prime ricostruzioni storiche della
persecuzione degli ebrei in Italia, presenta alcuni elementi critici in
merito alla politica perseguita dal Vaticano; dall’altra Ernesto
Buonaiuti, che nel 1946 pubblica una biografia di Pio XII in cui critica
con severità la passività e l’eccesso di diplomazia del Papa durante i
nove mesi di occupazione nazista di Roma.
C’è stato un periodo lungo, si potrebbe dire, in cui è prevalsa una
linea del silenzio. In questo caso ovviamente il termine silenzio
aveva un valore diverso da quello che caratterizzava la realtà
dell’Est Europa, laddove con l’espressione «Chiesa del silenzio» si
intendeva quella condizione in cui la Chiesa era costretta a una
condizione di non libertà d’espressione. Voleva dire che su quel
tema il senso comune riteneva che non ci fossero questioni o punti
controversi da chiarire o da affrontare. Questo è, per esempio, il
senso della riflessione che nel 1956 propone l’arcivescovo di Milano,
Giovanni Battista Montini in un discorso pubblico tenuto all’Ispi
(Istituto di studi di politica internazionale) sul profilo complessivo
dell’azione della Chiesa nel tempo della guerra e, in particolare, sulla
visione di «politica internazionale» propria del pontificato di Pio XII.
In quel testo si fissano alcune questioni che sono tornate ora a far
discutere intorno alla fisionomia non solo dell’azione, ma anche del
profilo culturale di Pio XII. Tra esse, per esempio, il tema
dell’Europa, su cui torneremo nelle pagine conclusive. Ciò perché il
tema era già allora contrassegnato da un’operazione di
ricostruzione, volta a legare l’azione concreta, il linguaggio, la fitta
rete di atti, ma anche di sistema, con le preoccupazioni del proprio
tempo e dunque con il «quaderno di lavoro» di Pio XII. Al centro
della riflessione, oltre alla guerra e alle scelte che allora si erano
compiute, c’era il profilo che l’Europa era chiamata ad assumere: le
sfide che la crisi europea obbligava a raccogliere e a caricare di
risposte.
Dunque, prima di tutto il profilo dell’azione di Pio XII.
La sua azione, precisava Montini, non era volta a «questa o
quest’altra preferenza politica, questa o quest’altra soluzione tecnica
•
•
•
•
•
dei problemi internazionali, […] ma all’affermazione di quei princìpi,
da cui l’ordine internazionale deve dipendere». La sua «è voce di un
sapiente, ma non è simile a quella di un professore di diritto
internazionale». E ciò perché la sovranità temporale è, qui stava la
premessa centrale della riflessione di Montini,
in funzione della sua sovranità spirituale su tutta la Chiesa; il che
rende la posizione del Papa nel concerto internazionale tutta
particolare; la rende, ad esempio, quasi irrilevante per le grandi
questioni puramente politiche ed economiche, interessante per le
questioni dei servizi statali (come le comunicazioni), importante
invece per le questioni d’indole morale, culturale, religiosa.
Il testo di riferimento a cui Montini allude è il radiomessaggio del
Natale 1941 in cui, a suo giudizio, Pio XII elenca i principali problemi
aperti la cui soluzione sembra costituire la piattaforma di un nuovo
riordinamento, una nuova «partenza» nelle relazioni internazionali.
Ovvero:
sicurezza delle singole nazioni;
rispetto delle minoranze nazionali;
migliore ripartizione delle fonti economiche e materie di uso
comune;
limitazione degli armamenti;
tutela della libertà religiosa.
Un assetto che, sottolinea nel testo dello stesso radiomessaggio,
è determinato dalla perdita progressiva di forza della cristianità sul
tempo presente, e al cui centro sta la progressiva perdita di forza del
messaggio cristiano. Una condizione, si dice, di «anemia religiosa,
quasi contagio che si diffonde, ha così colpito molti popoli di Europa
e del mondo e fatto nell’anime un tal vuoto morale, che nessuna
rigovernatura religiosa o mitologia nazionale e internazionale
varrebbe a colmarlo». Per concludere:
Chi potrà oggi meravigliarsi se tale radicale opposizione ai princìpi
della cristiana dottrina venne infine a tramutarsi in ardente cozzo
1.
2.
3.
di tensioni interne ed esterne, così da condurre a sterminio di vite
umane e distruzione di beni, quale lo lediamo e a cui assistiamo
con profonda pena? Funesta conseguenza e frutto delle
condizioni sociali ora descritte, la guerra, lungi dall’arrestarne
l’influsso e lo svolgimento, lo promuove, lo accelera e amplia, con
tanto maggior rovina, quanto più essa dura, rendendo la
catastrofe ancor più generale.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :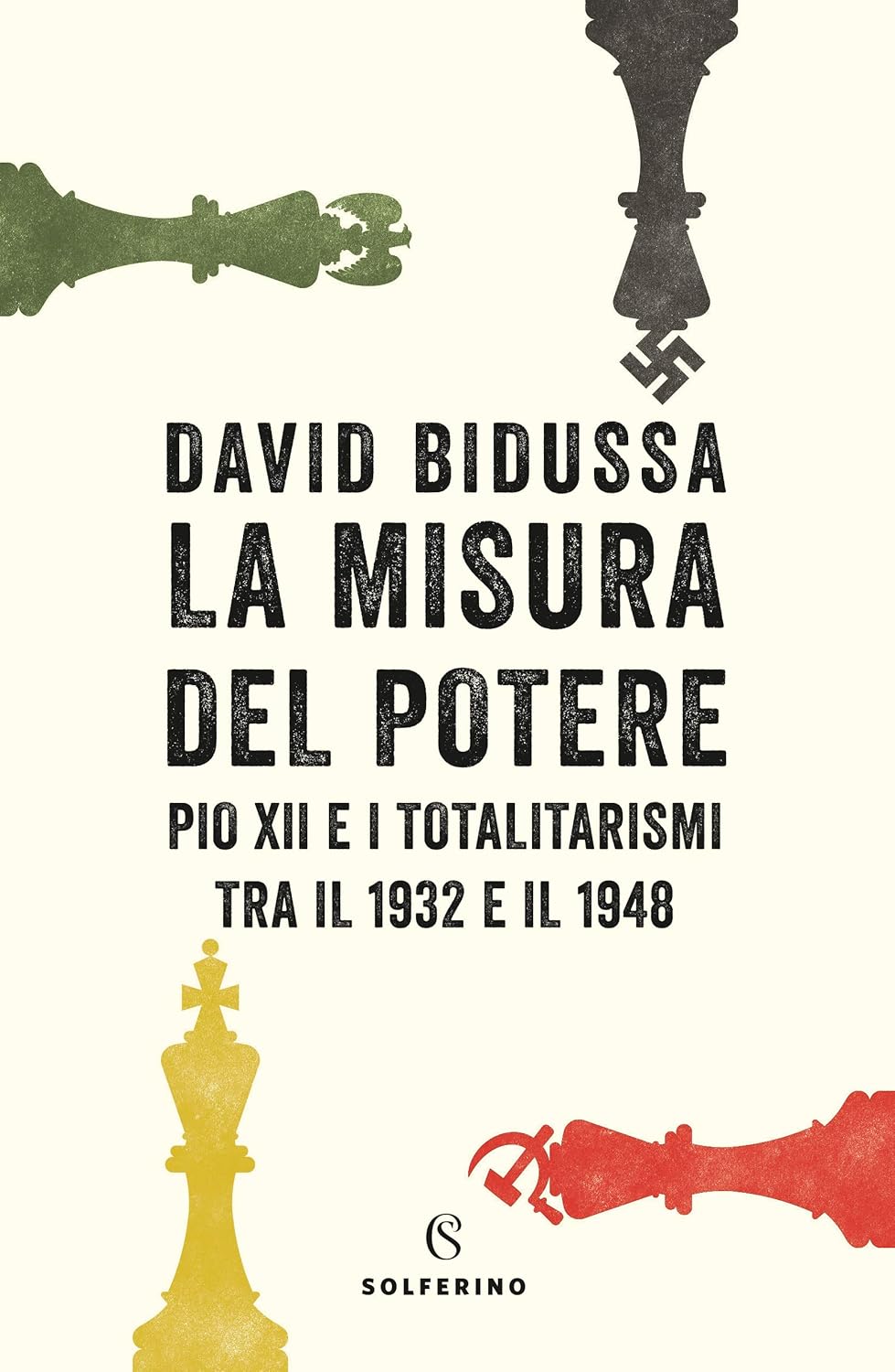






Commento all'articolo