La credibilità politica – Guido Gili
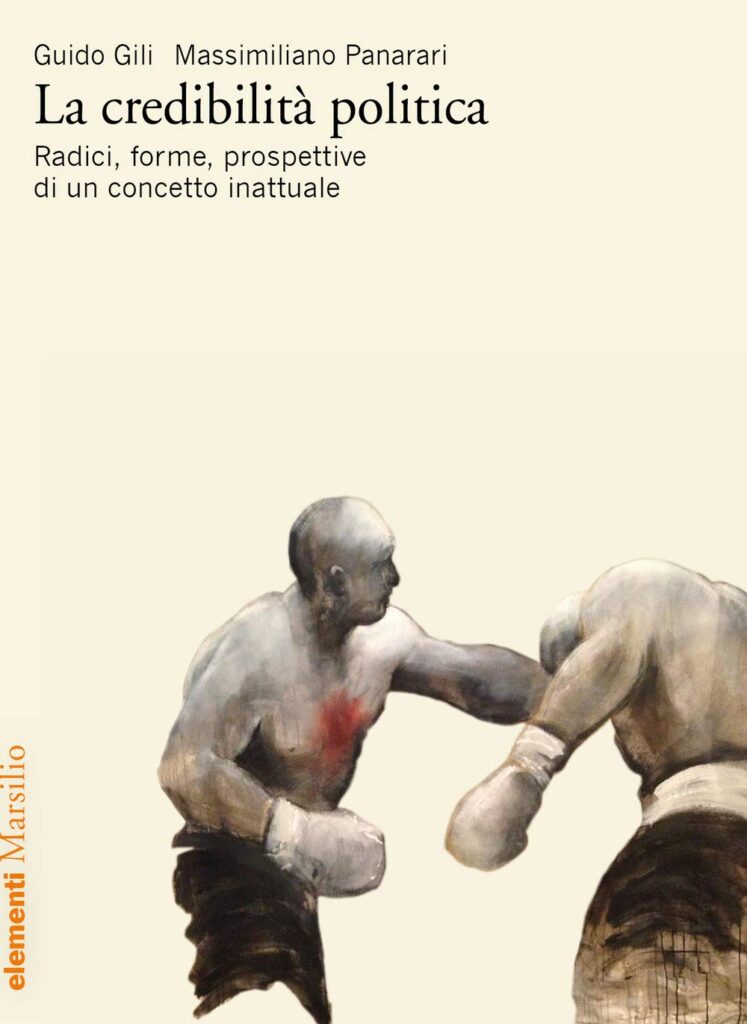
SINTESI DEL LIBRO:
La prima radice della credibilità è la competenza. Si crede a
qualcuno perché sa e per ciò che sa. È questa tipicamente la
credibilità dell’esperto, cioè di colui che dispone di una
conoscenza fondata dei fatti e dei problemi per cui può parlare,
come si suol dire, «a ragion veduta» o «con cognizione di causa».
Nella cultura occidentale moderna la figura esemplare
dell’esperto è lo scienziato, in quanto depositario di un sapere
basato sulla raccolta accurata di dati, sulla logicità del
ragionamento, sull’affidabilità delle conclusioni e sulla loro
generalizzabilità. Più in generale, la credibilità basata sulla
conoscenza e la competenza è quella su cui possono contare
anche l’insegnante e il medico, grazie allo studio e all’esperienza,
o l’investigatore e il giornalista, attraverso la loro ricerca della
verità. In termini più generali è la credibilità della persona «bene
informata»2.
Ma, accanto al sapere, la competenza comprende anche il saper
fare, cioè la capacità di applicare le conoscenze dando corso a
un’azione efficace. La superiorità degli esperti rispetto agli
inesperti non sta tanto nella quantità di conoscenze possedute
quanto nella capacità di utilizzarle efficacemente. Per questo è
fondamentale anche sapere assimilare utilmente nuove
informazioni. Per descrivere questa forma di competenza – e di
credibilità che ad essa si lega – si può fare riferimento, ad
esempio, alle figure dell’artigiano, dell’imprenditore o del
chirurgo. Ognuno di essi mette il suo sapere al servizio di un
saper fare: per l’artigiano significa dare forma a un oggetto utile e
bello; per l’imprenditore sapere individuare le migliori strategie
per imporsi sul mercato e per il chirurgo saper decidere ed
eseguire un intervento con successo.
Anche in politica è determinante sapere e saper fare. Tuttavia le
competenze dei politici e quelle degli esperti non coincidono.
Diversa è infatti la credibilità di cui dispongono, anche quando
esprimono giudizi che hanno una rilevanza pubblica.
Innanzitutto nella società occidentale moderna l’esperto si
caratterizza per una competenza ristretta e settoriale. Ciò è
dovuto alla crescente divisione del lavoro e allo sviluppo della
scienza e della tecnica, che hanno generato campi di competenza
sempre più limitati. In tal modo la competenza si restringe e si
specializza, viene riferita a un oggetto ben definito, a differenza di
quanto accadeva nelle società del passato dove l’essere sapiente o
erudito si rivolgeva, almeno come tensione, all’intera conoscenza
umana e coincideva con un ideale di perfezione morale. Senza
dubbio oggi nessuno, nemmeno i più capaci e colti leader politici,
può padroneggiare tutte le conoscenze storiche, geografiche,
economiche, giuridiche, mediche che sarebbero utili. Nondimeno
un leader politico deve essere in grado di abbracciare e integrare
conoscenze derivanti dai diversi ambiti del sapere. Rispetto
all’esperto, il politico può possedere una competenza meno
approfondita sui diversi campi specifici, ma essa deve essere più
generalizzata e, soprattutto, capace di sintesi. Quindi la
competenza di cui abbisogna assomiglia per certi aspetti di più a
quella del sapiente antico che a quella del moderno scienziato.
In secondo luogo l’esperto non è chiamato a decidere. Come
osserva giustamente Tom Nichols, accademico statunitense
specializzato in studi strategici in un recente volume intitolato
significativamente The Death of Expertise, una cosa è sapere,
un’altra è decidere. L’esperto può agire come «consigliere del
principe», ma non è chiamato a decidere. Né assume direttamente
la responsabilità delle decisioni. Il politico è chiamato invece a
decidere e ad assumerne la responsabilità, anzi questo è il
carattere primario del suo ruolo: colui che è chiamato a decidere
anche per gli altri e, non di rado, in presenza dell’opposizione e
della resistenza degli altri3.
Quindi la credibilità di cui gode (o non gode) l’esperto e quella di
cui gode (o non gode) il politico sono anch’esse assai diverse.
L’esperto può godere di una credibilità «specifica», cioè è
credibile in un particolare contesto o su un determinato tema, ma
non lo è necessariamente e allo stesso modo in un altro contesto o
su un diverso argomento. Un bravo chimico, ad esempio, può
essere assai credibile nel suo campo di studi, ma può rivelarsi del
tutto inaffidabile quando debba consigliare un buon film a un
amico. O può esprimere giudizi politici ed estetici rozzi e
superficiali. Quando un esperto si inoltra in campi che esulano
dalla sua più immediata e sicura competenza finisce per abusare
della fiducia del pubblico e si espone a brutte figure. Il fatto di
essere una persona intelligente e brillante, il che gli ha consentito
di affermarsi in un certo campo di studi o di attività, di per sé non
lo abilita a esprimere giudizi che siano altrettanto intelligenti e
validi in altri campi. O di ritenere di avere buone idee e soluzioni
su tutto.
La credibilità che il politico rivendica e di cui può godere (o non
godere) assume invece un carattere generalizzato: è attribuita alla
persona come tale e a ciò che rappresenta. Tra l’altro tale
credibilità, come vedremo, è un impasto di diverse radici e
dimensioni e non deriva dalla sola competenza, come accade per
l’esperto. Il caso di massima estensione della credibilità è
costituito dalla credibilità del leader carismatico. Se a un estremo
del continuun della credibilità vi è dunque la credibilità dello
specialista che sa tutto su un argomento o un campo particolare e
forse ristrettissimo (ad esempio, come ottenere una buona
produzione di fagioli), all’altro estremo si colloca la credibilità del
leader carismatico, che i seguaci ritengono capace di dare
risposte risolutive su tutto (anche su come produrre i fagioli).
Quali competenze?
In politica occorre dunque sapere e saper fare. Nonostante sia
innegabile che per avere successo in politica è necessario «saper
comunicare» e che la comunicazione costituisce ormai «l’ambito
principale di attenzione per chi vuole avvicinarsi alla politica»4, in
realtà la qualità fondamentale di un politico sta nel saper
prendere decisioni e, solo in secondo luogo, nel sapere anche
spiegare bene le ragioni di queste decisioni chiedendo un
consenso per realizzarle. Ciò non significa sminuire il valore delle
competenze e delle abilità comunicative, ma riconoscere il loro
ruolo effettivo. D’altra parte è senz’altro vero che potere
presentare figure alle quali è riconosciuta una sicura competenza
risponde anche a ragioni comunicative, cioè alla possibilità di
accreditarsi presso i cittadini elettori mostrando un’immagine di
serietà e di affidabilità.
In tal senso la competenza politica presenta tre dimensioni
principali, tra loro collegate.
La prima dimensione è saper individuare le questioni strategiche,
attraverso la conoscenza delle informazioni rilevanti per definirle,
analizzarle e affrontarle. Non sono solo l’orientamento ideologico
e gli scopi politici – cioè una questione di prospettiva – che
identificano e selezionano i problemi fondamentali, ma anche la
capacità di saper ascoltare e dare una forma alle istanze presenti
nella popolazione o in rilevanti settori della popolazione, anche se
queste appaiono spesso confuse, informi o solo parzialmente
delineate.
La seconda dimensione è saper individuare le possibili e
realistiche soluzioni a questi problemi valutando lucidamente il
maggior numero di fattori in gioco, quindi il rapporto costibenefici, le probabilità di successo, il ruolo e gli interessi dei
diversi soggetti coinvolti. Naturalmente, a seconda del contesto
storico-politico nel quale si agisce, possono anche variare i campi
nei quali «è importante dimostrare il proprio saper fare: in fasi di
crisi economica si richiedono ai politici capacità diverse da quelle
necessarie in momenti di conflitto militare»5.
La terza dimensione è infine l’abilità comunicativa. In questo caso
di solito ci si sofferma fin troppo sugli aspetti più superficiali
legati allo stile comunicativo e al modo più o meno accattivante e
persuasivo di proporsi al pubblico. Ma questa è solo la superficie,
sono semplici effetti di immagine. Più in profondità, vale il
principio che «un buon linguaggio [verbale e non verbale] può
essere il miglior vestito di un buon pensiero»6, non semplicemente
un vestito per coprire l’assenza di pensiero o pensieri ingannevoli.
Valgono anche per i politici le regole che il filosofo Paul Grice7 ha
indicato come essenziali per comunicare con successo nella vita
quotidiana: dire ciò che è necessario allo scopo, né troppo né
troppo poco (regola della quantità); essere veritieri e non dire ciò
per cui non si hanno prove adeguate (regola della qualità); essere
pertinenti, cioè «stare al tema» e non eludere le questioni
essenziali (regola della relazione); essere chiari e mirare al centro
dell’argomentazione (regola del modo). Qualcuno farà
giustamente notare che in politica accade più spesso che queste
regole siano violate che osservate, così come d’altronde accade
anche nelle relazioni quotidiane. Ciò è senz’altro vero, ma la
violazione di queste regole comporta dei gravi rischi.
Un ultimo aspetto chiave della competenza politica è la
tempestività nell’azione. Possiamo parlare, a questo proposito, di
kairos, cioè di senso del tempo. Questa qualità è fondamentale per
prendere le decisioni giuste al momento giusto, quando cioè
l’insieme dei fattori in gioco – la «fortuna» di Machiavelli –
presenta la congiuntura più favorevole, ma anche per scegliere
quando fare certi annunci o dichiarazioni senza sbagliare i tempi e
i modi della comunicazione.
Questo grappolo di competenze e di abilità è una sintesi di
conoscenza ed esperienza, che assume una forma particolare in
ogni leader politico. Sicuramente esse dipendono dalle
predisposizioni personali, cioè dalla particolare intelligenza di un
individuo, che è sempre una composizione unica di capacità
logiche e analitiche, di energia pratica nell’affrontare i problemi e
di intelligenza creativa nell’individuare nuove soluzioni (secondo
le tre dimensioni dell’intelligenza definite da Robert Sternberg8).
Queste disposizioni e qualità personali possono essere state
coltivate in un percorso di istruzione formale, ad esempio negli
studi scolastici e universitari, ma anche attraverso un
addestramento che deriva dall’esperienza e può essere il frutto di
una precedente socializzazione politica, ad esempio di un
percorso nel quale si assumono dapprima responsabilità a livello
locale o in ambiti settoriali per poi scalare i diversi gradini della
carriera politica mettendo a frutto e affinando le competenze
precedentemente maturate. In questo senso la competenza
politica si acquista anche (e soprattutto) facendo politica.
Ma quali conoscenze e competenze specifiche sono
particolarmente utili per saper affrontare i problemi e funzionano,
al tempo stesso, come fonte di credibilità e di legittimazione?
Serve innanzitutto un insieme di conoscenze generali che possano
supportare l’analisi e la decisione politica, ricavabili da diverse
discipline come la storia, il diritto e l’economia9. A dispetto della
convinzione di Nietzsche che conoscere la storia serva a poco per
la vita, in politica tale conoscenza serve invece a qualcosa. E
serve anche conoscere bene le leggi, in primo luogo quelle che
abilitano o delimitano la propria azione.
Nel bagaglio di competenze di un politico ha poi guadagnato
sicuramente un posto di rilievo la statistica poiché la conoscenza
dei problemi sembra tradursi oggi soprattutto nella padronanza
dei dati e dei numeri con cui questi problemi possono essere
delineati e quantificati. Anche in termini comunicativi, ogni
argomentazione o affermazione appare più convincente se assume
le vesti dell’oggettività dei numeri. Nelle interviste e nei faccia a
faccia televisivi diventa fondamentale saper sciorinare con
sicurezza e disinvoltura molti dati per sostenere le proprie tesi e
confutare quelle degli avversari. In ogni caso, incorrere in qualche
amnesia e imprecisione non impedisce a un politico di
sopravvivere ugualmente bene nell’agone politico e di essere
percepito come capace e competente. Ad esempio, quando nel
1994 iniziò il genocidio ruandese, il futuro segretario di Stato
Warren Christopher non aveva idea di dove si trovasse il paese
africano. E, nel corso di un comizio, il brillante senatore e
candidato alla Casa Bianca Barack Obama dichiarò di avere
visitato tutti i cinquantasette stati dell’Unione10. Anche quando
nel 1984 Ronald Reagan si presentò alle elezioni per il suo
secondo mandato, nel corso del primo faccia a faccia televisivo
con il suo avversario, il candidato democratico Walter Mondale,
mostrò parecchie incertezze e dimenticanze per cui i media
crearono il frame della «età del presidente», chiedendosi se un
ultrasettantenne potesse guidare lo Stato più potente del mondo,
e tutta la campagna elettorale finì per ruotare intorno a questo
tema. Nel secondo dibattito Reagan rovesciò questa cornice
interpretativa affermando ironicamente che non avrebbe
rimproverato al suo avversario, anch’egli non giovanissimo, la sua
inesperienza e, come è noto, vinse di nuovo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :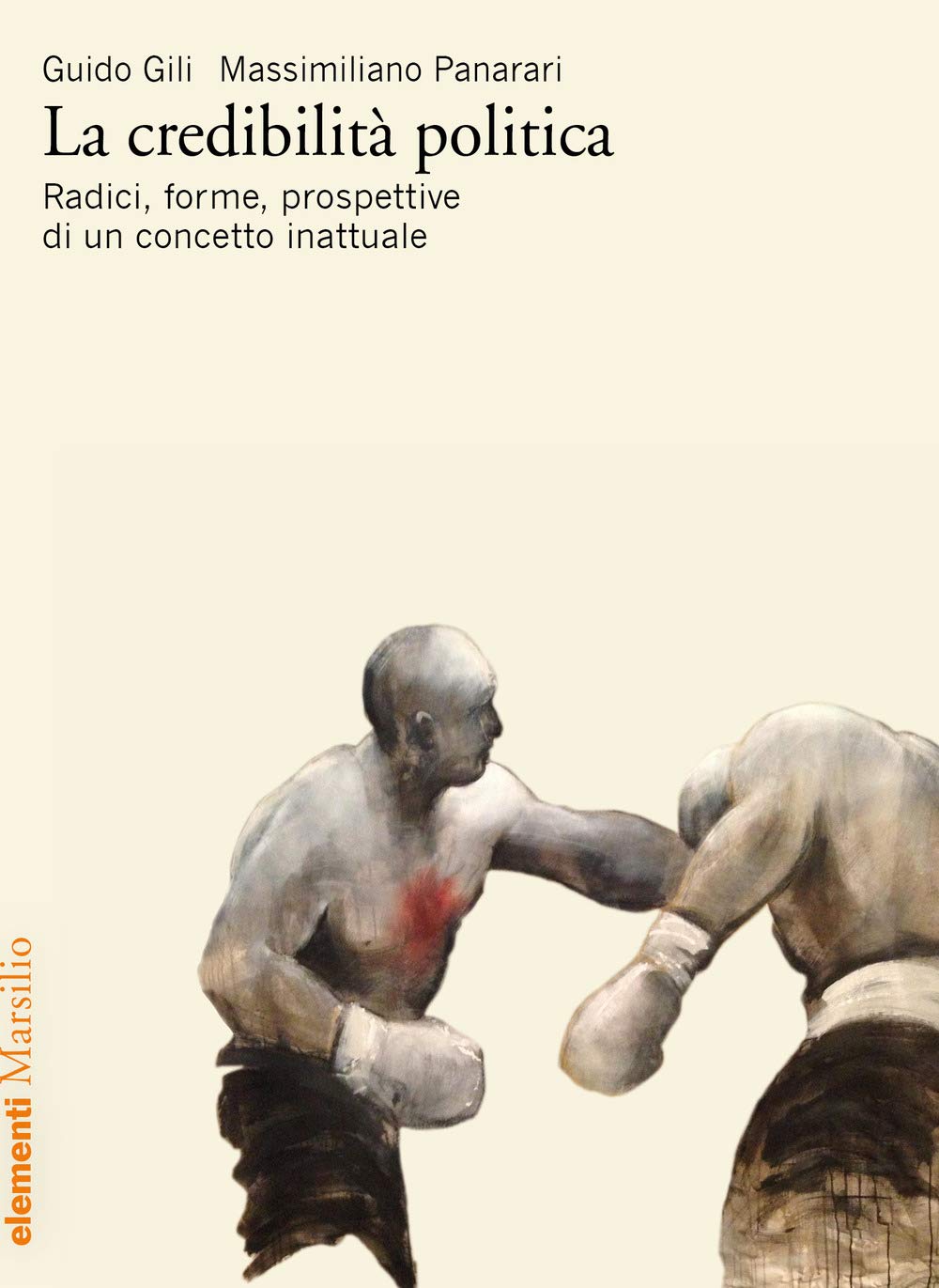






Commento all'articolo