Il romanzo del Novecento – Giacomo Debenedetti
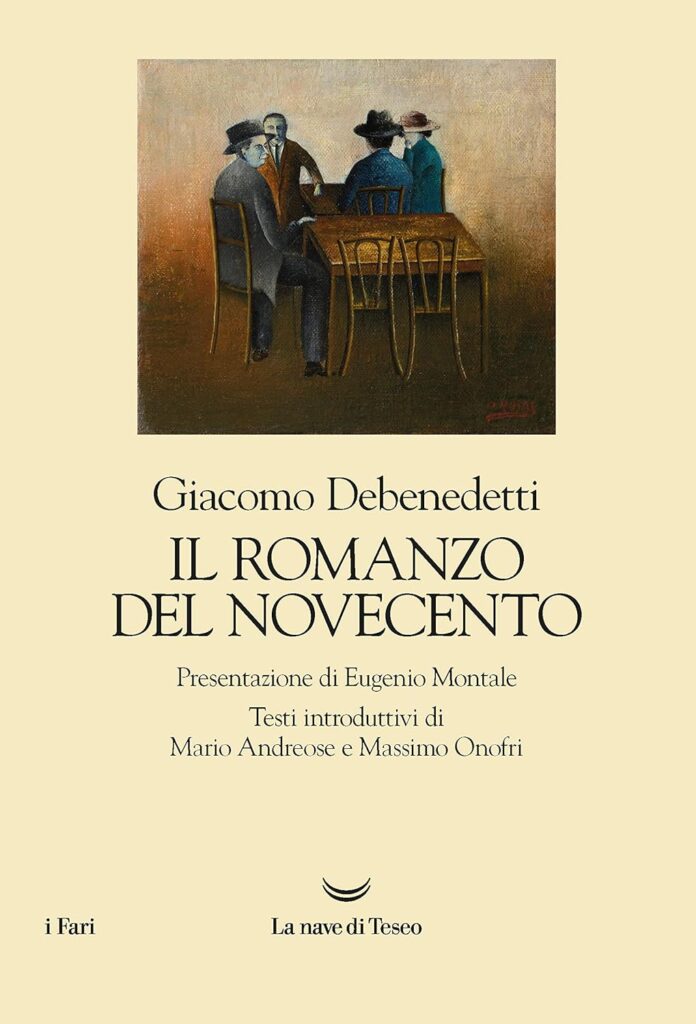
SINTESI DEL LIBRO:
Di comune accordo e in base a una specie di referendum indeo tra coloro
che avevano seguito il corso dell’anno passato sulla poesia abbiamo scelto
quest’anno di occuparci del romanzo italiano contemporaneo.
La nozione di contemporaneità è molto elastica, specie in fao di
leeratura, dove l’evoluzione, anche nei periodi più celeri e rivoluzionari,
è sempre relativamente lenta rispeo alle trasformazioni della storia,
considerata nei suoi aspei più direamente e immediatamente vissuti:
quelli politici e civili, guerre, paci, mutarsi di istituti e di regimi.
Anche le trasformazioni della scienza, specie ai nostri giorni, sono
molto più veloci che quelle delle arti. La scienza ci ha fai entrare, quasi
d’improvviso, nell’era cosmica, mentre in arte e in leeratura siamo
ancora espressi (nella misura in cui siamo d’accordo di sentirci espressi) da
produzioni legate a poetiche senza dubbio precedenti all’era cosmica. È
vero che certi critici e storici, soprauo della piura, ritengono che tra
scienza e arte non ci sia differenza di fase, cioè che scienza e arte
esprimano contemporaneamente, senza ritardi dell’arte rispeo alla
scienza, la stessa visione del mondo. E per esempio, il critico tedesco
Hamann, in un panorama della piura moderna,
1 sostiene che le date di
inizio dei movimenti che hanno condoo alla piura astraa e
all’informale coincidono con le date capitali delle grandi innovazioni
scientifiche, che hanno condoo all’era cosmica. Le prime origini della
piura cubista insomma, cadono suppergiù negli stessi anni, i primi di
questo secolo, in cui il fisico Planck formula la teoria dei quanta, Einstein
trasformando l’equazione di Michelson-Morley scrive le equazioni della
relatività e Freud porta la psicologia del profondo a quella tappa decisiva
che è rappresentata dal libro sull’interpretazione dei sogni. Sono altreanti
avvenimenti che sfacceano e significano, nei loro campi diversi e
rispeivi, quello che lo stesso Hamann chiama un nuovo sistema di
coordinate dell’uomo nel mondo, una nuova percezione che l’uomo ha
della struura e quindi un nuovo sentimento e giudizio del mondo, e del
proprio essere ed esserci nel mondo. E senza dubbio, nella misura in cui si
è davvero stabilito un nuovo sistema di coordinate, se ne debbono
riscontrare gli effei anche in leeratura, e tanto più nel romanzo. Cesare
Pavese, in una intervista raccolta nel suo libro sulla leeratura americana,
affermava di considerare i “racconti” (cioè la narrativa) “non come
descrizione ma come giudizi fantastici della realtà”.
Giudizio e fantasia: due aività streamente collegate e condizionate
dalla nostra concezione e sentimento del mondo. Dunque i romanzi se ha
ragione Pavese dovrebbero fortemente, specificamente rispecchiare il
mutato sistema di coordinate. Sarebbe, dunque, da considerarsi
contemporanea la narrativa che presenta sviluppi solidali, non solo con la
storia politica e civile, ma con la scienza. Ed è anche vero che, se
osserviamo le maggiori conquiste della narrativa europea (i novatori
Joyce, Kaa, per esempio, ma anche il conservatore Proust), troveremo
facilmente di che dar ragione ai sostenitori di un’avanguardia compaa e
simultanea di tue le produzioni umane, in tue le forme, compresa la
leeratura e quel genere leerario che è la narrativa. Ma, deo questo, la
realtà dei fai ci riporta alla constatazione che gli sviluppi della
leeratura, almeno nella sua media, sono relativamente più lenti che quelli
delle altre aività umane. Se non ne avessimo altre prove, il romanzo
italiano basterebbe a persuadercene, anche se negli ultimi anni sembra
essersi rapidamente allineato con la maggior narrativa internazionale,
almeno a giudicare dai successi che sta riscuotendo nelle traduzioni in
lingue straniere. esta lentezza di sviluppi rende più problematico il nostro compito di
fissare dei termini, delle date plausibili al periodo che ci proponiamo di
studiare. Alla stregua dei fai, dovremo subito renderci conto che è
impossibile stabilire che narrativa italiana moderna e contemporanea è
quella che rispecchia la nostra condizione di uomini italiani alla vigilia, e
poi all’inizio, di quella che, per brevità, continueremo a chiamare l’era
spaziale o cosmica. Potremo poi eventualmente, quando ci saremo
addentrati nell’analisi della narrativa italiana dei penultimi e degli ultimi
decenni, scoprirvi i riflessi di quest’epoca di trapasso e di inaugurazione:
ma saranno riflessi in qualche modo indirei e passivi, non
manifesteranno mai una presa di coscienza di tale trapasso. Una vera presa
di coscienza non si comincia a intravvedere, e solo sporadicamente,
isolatamente, che nell’interpretazione realistica degli Indifferenti di
Moravia, uscito nel 1929, e nella geniale intelligenza realistica dei romanzi
di Svevo, riscoperti proprio in quello stesso giro di anni (il caso Svevo
deflagra nel 1925). Più piena e diffusa, questa presa di coscienza si
manifesterà col neorealismo narrativo, o eventualmente con le reazioni a
questo neorealismo, nel secondo dopoguerra.
Ma, secondo la definizione datane dal romanziere francese Michel
Butor, uno dei più preparati e consapevoli esponenti della cosiddea école
du regard, un romanzo è “una risposta a una certa situazione della
coscienza”.
2 Ne deriverebbe che se il romanzo italiano, negli anni
precedenti a questi fenomeni, rivela una scarsa corrispondenza tra la
“realtà” che esso descrive e la realtà che lo circonda, il nostro
aeggiamento di fronte a questo romanzo dovrebbe essere
aprioristicamente negativo; e allora, a quale pro studiarlo? Tu’al più,
dovremmo considerare quella narrativa come una serie di fallimenti, di
ricerche a tastoni, nel buio, inconsapevoli di ciò che preparano: forse
persino incapaci di preparare il romanzo “presa di coscienza”, il romanzo
impiantato su adeguate e tempestive posizioni ideologiche, legate alla
storia e alla realtà circostante, comunque poi interpretino questa storia e
realtà, qualunque sia il loro colore. E viceversa sentiamo che, ad escludere
quei romanzi precedenti noi rifiuteremmo tuo un gruppo di opere che
hanno una ragion d’essere morale, umana ed estetica, e quindi anche
storica: ci ridurremmo a fare una storia del romanzo che risponderebbe a
un’unica definizione del romanzo, a una sola poetica del romanzo. Metodo
quanto mai errato, perché il nostro compito è di critici e non di
romanzieri: e se il romanziere può e deve operare in conformità a una
certa idea che egli si fa del romanzo, cioè a una certa e determinata
definizione e poetica del romanzo che corrisponde alla sua vocazione, a ciò
che egli ha da dire, una definizione e una poetica che per lui costituiscono
un a priori; il critico invece deve scoprire a posteriori, dall’esame delle
opere, quali siano le poetiche a cui esse hanno obbedito, e trovare le
ragioni positive di quelle varie poetiche, e semmai decidersi a sceglierne
una e a darle la palma solo quando si è persuaso che storicamente è la più
legiima, la più capace di determinare, agendo come concausa, le opere
che più compiutamente esprimono il tempo da cui sono nate, o stimolano
quel tempo, ne lievitano le aese, i presagi, le promesse, le forze e i
sentimenti più efficaci al suo divenire. Ecco perché non è ozioso questo
problema iniziale che ci siamo posti, e che consiste nel decidere qual è il
periodo che dobbiamo abbracciare nel nostro studio del romanzo italiano
contemporaneo.
Fissare i limiti di un periodo storico comporta sempre l’acceazione di
date convenzionali, e una convenzione non può difendersi se non per
motivi di opportunità e di comodità pratica. Ma è facile che altri
osservatori vedano in quella convenzione un arbitrio. Per esempio, è
opportuno, è comodo, e anche ragionevole, far cominciare la penultima
epoca storica, quella che fino a ieri pareva il segmento a noi più vicino
dell’età moderna, dalla rivoluzione francese. Ma quanti sintomi, quante
premesse, quanti fai già pienamente avverati dell’età borghese si
lasciavano fuori con quel taglio crudo che occorreva per stabilire il punto
di inizio nell’anno 1789? Storici rigorosi e documentati, insigne tra tui il
Tocqueville, hanno potuto dimostrare quanto quella data convenzionale
fosse arbitraria. So di ripetere un discorso molto risaputo; il fao che mi
senta costreo a ripeterlo dimostra le mie perplessità nello scegliere una
data di partenza per lo studio della narrativa italiana contemporanea. So
bene che la data che sceglieremo potrà parere arbitraria ad altri studiosi
della moderna narrativa italiana. Con questo puntiglioso inventario delle
difficoltà, con queste dichiarazioni sulla consapevolezza delle difficoltà che
dobbiamo superare, mi preparo a far riconoscere che l’arbitrio a cui
saremo costrei avrà, per lo meno, cercato di essere il meno “arbitrario”
possibile.
Per di più, esiste una contemporaneità come sentimento personale e
una contemporaneità come valutazione cronologica. È curioso che la
contemporaneità come sentimento sia più strea e rigorosa di quella
misurata in base a un criterio così preciso e oggeivo come può essere la
cronologia. È probabile che se voi interrogate voi stessi su quelli che
sentite sono i vostri contemporanei, in fao d’arte e di leeratura,
troverete come risposta i pochi nomi di coloro che aualmente sono i
protagonisti o i comprimari dell’odierna cronaca artistica e leeraria: in
fao di romanzieri, direte, per esempio, Faulkner o Sartre, Hemingway o
Moravia, Pavese o Butor, Pratolini o Andersch o Nabokov o Calvino o
Testori o chi altri vi verrà in mente. Non vi parrà di essere i
contemporanei, per esempio, di omas Mann o, tanto meno, di
D’Annunzio e di Panzini, di Kaa o di Musil o di Lawrence o di Dreiser o
di Joyce o di Proust. Eppure, quelli che vi guarderanno a distanza, tra
cent’anni, poniamo, e faranno della cronologia con quelle ampie
periodizzazioni che è normale istituire quando si osservano fenomeni a
sviluppo lento, come sono appunto l’arte e la leeratura, vi aribuiranno
una contemporaneità, che a voi sembra improbabile, anche con quei
maestri di ieri. alche tempo fa, nel corso di una polemica, Giuseppe De Robertis si
faceva premura di obiearmi che la parola contemporaneo, in italiano,
vuol dire anche coetaneo. Contemporanei, in questo senso, significherebbe
dunque, e in modo abbastanza preclusivo, coloro che operano nell’hic et
nunc di questi giorni e anni che aualmente stiamo vivendo, coloro
insomma che noi vediamo operare soo i nostri occhi e alla nostra
immediata presenza di oggi. Tuo questo ci fa concludere che, dovendo
studiare un fenomeno leerario contemporaneo, la data di arrivo non
lascia dubbi: è la più vicina possibile, l’oggi che continuamente si sposta
avanti nel succedersi degli oggi, che andiamo araversando lungo il
cammino della vita.
Problematica è sempre la data di partenza. Non sempre si riesce a
trovare il fao caraeristico, singolare, che segni nella continuità del
tempo, il distaccarsi di un periodo dall’altro. Per la poesia, la cosa ci era
stata abbastanza possibile:
3 un punto, fissato convenzionalmente nella
durata della nostra poesia e nell’intrecciarsi delle opere e delle poetiche,
finiva col prendere una certa consistenza, col diventare un punto reale,
insomma col presentarsi come un momento preciso, a partire dal quale
qualche cosa era cambiato. el punto era determinato dall’uscita
dell’antologia Poeti d’oggi, composta da Papini e Pancrazi, che venne fuori
nell’anno 1920. Dicevamo: quell’antologia inizia un periodo, in quanto
svincola la poesia italiana dalle successive diature di un poeta egemone,
di un “primo poeta d’Italia”, si fosse chiamato Carducci, o Pascoli, o
D’Annunzio. ell’antologia arrivava persino a prescindere drasticamente
dal fao che un “primo poeta d’Italia” c’era ancora, vivo e operante, nella
persona di Gabriele D’Annunzio; in luogo di quelle diature,
quell’antologia instaurava la libera concorrenza e rivalità dei poeti, per
quel momento minori, dei poeti senza aureola di vati o di geni; aveva l’aria
di inaugurare la libera democrazia dei poeti.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :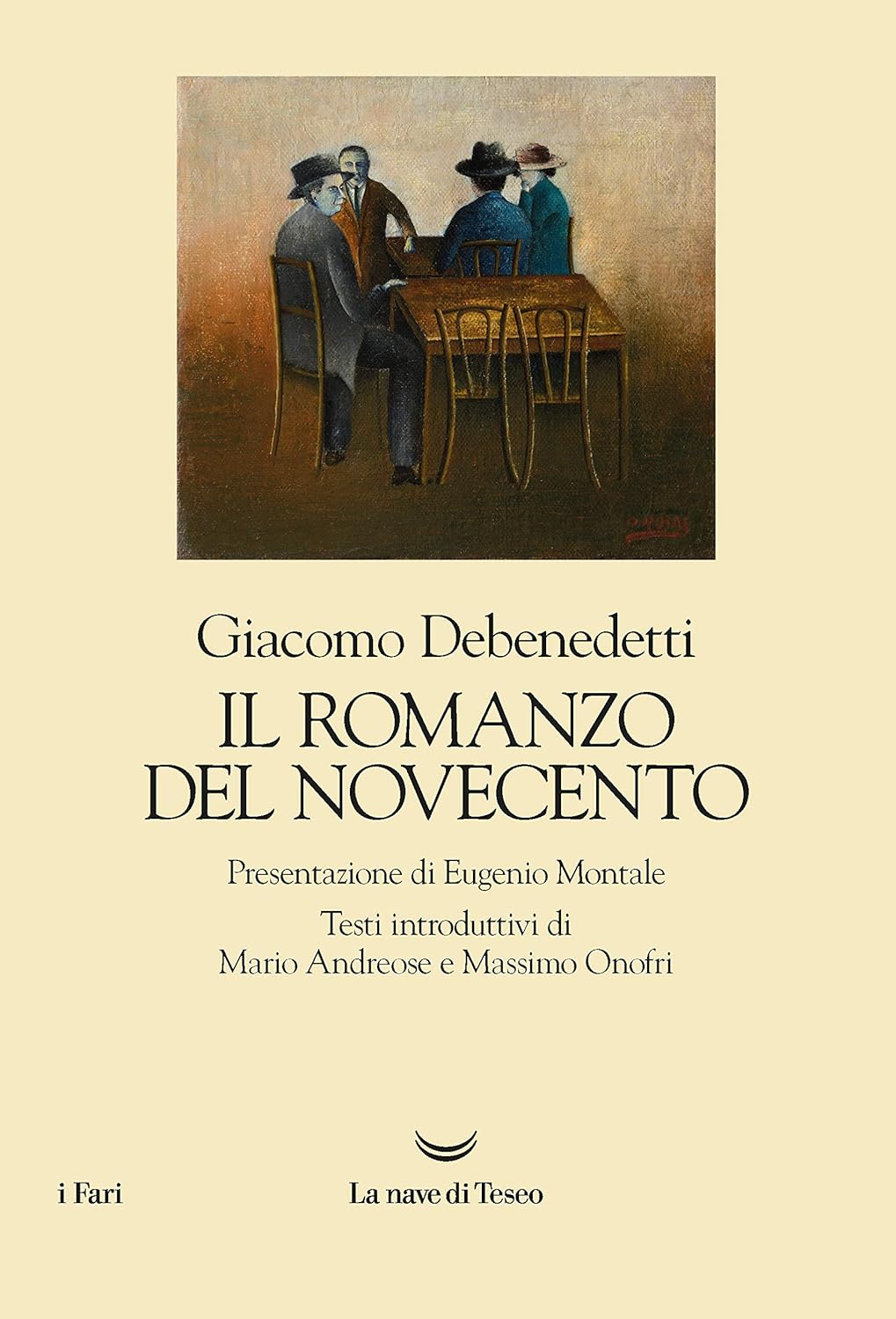






Commento all'articolo