I vaccini fanno bene – Perché dobbiamo credere nella scienza per difenderci da virus e batteri – Guido Forni
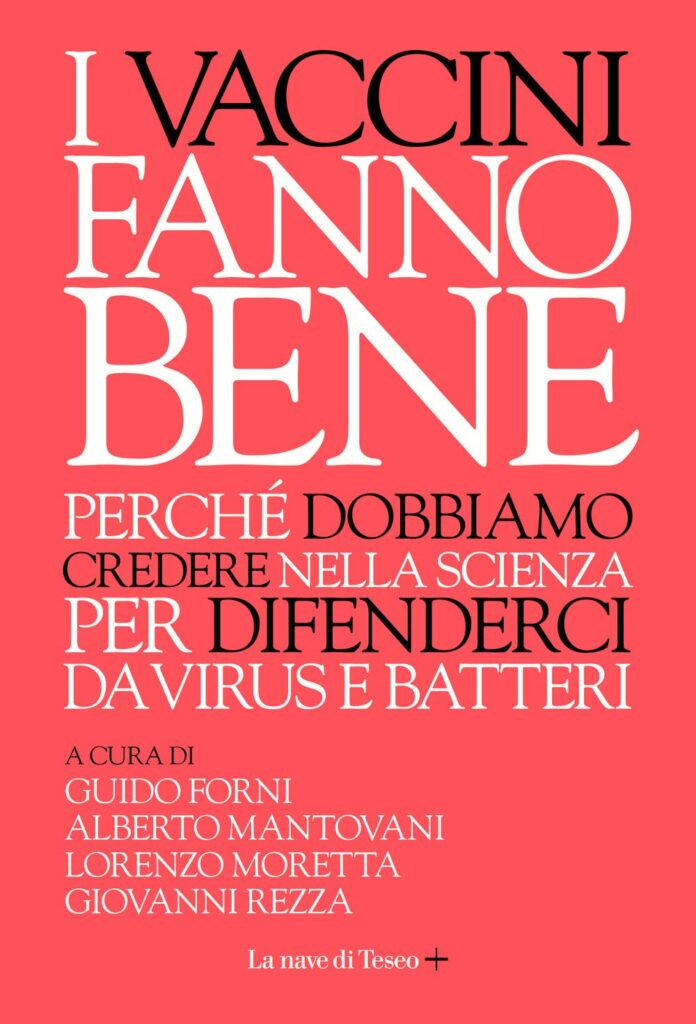
SINTESI DEL LIBRO:
Da 100 anni a questa parte l’aspettativa di vita è notevolmente
cambiata, passando da circa 40 a 80 anni per gli uomini e da 40 a
84 anni per le donne. Alla radice di questo notevole mutamento ci
sono fattori diversi, dall’acqua potabile agli antibiotici,
all’alimentazione. Tra questi, il contributo dei vaccini è certamente
stato fondamentale. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS/WHO), i vaccini salvano 5 vite nel mondo ogni
minuto, 7.200 ogni giorno. E consentiranno, nel decennio che stiamo
vivendo, di aver evitato oltre 25 milioni di morti (RAPPUOLI E VOZZA,
2013; MANTOVANI, 2016).
Insieme alle misure di risanamento ambientale, i vaccini sono il
principale strumento di sanità pubblica per la prevenzione e il
controllo delle malattie infettive. Come evidenziato dall’analisi di dati
epidemiologici raccolti in tutte le nazioni e da una serie enorme di
pubblicazioni scientifiche, i vaccini sono l’intervento medico a basso
costo che risulta maggiormente efficace nel ridurre il carico di
malattia e morte nel mondo. Grazie ai vaccini, oggi per ricordare che
cosa sia un’epidemia di poliomielite o di difterite dobbiamo leggere
Philip Roth, Mark Twain o Italo Svevo.
Come verrà discusso in questo libro, i vaccini sono uno strumento
di prevenzione utile non solo per il singolo, ma per tutta la comunità:
l’immunizzazione di un alto numero di persone contro una
determinata malattia impedisce al microbo di trasmettersi,
proteggendo i non vaccinati (immunità di gregge, o meglio di
comunità). Senza i vaccini tornerebbero a colpirci virus e batteri da
tempo debellati (come appunto poliomielite e difterite), e non
avremmo un efficace scudo contro malattie che, prima o poi,
dovremo affrontare.
Il nostro rapporto con i microbi (virus, batteri, parassiti…) è, infatti,
in costante evoluzione, e la cronaca ci ricorda di continuo quanto sia
instabile il nostro equilibrio con l’ambiente microbico che ci circonda.
Negli ultimi anni ci siamo trovati a fare i conti con minacce gravi,
come il virus Ebola e Zika o la diffusione della Dengue a causa dei
mutamenti climatici. Purtroppo, come si è visto recentemente con il
SARS-CoV-2, non è possibile prevedere a priori la minaccia che virus
e batteri nuovi rappresentano o rappresenteranno per noi e per il
nostro sistema immunitario. Allarmante da questo punto di vista è lo
scenario costituito dall’aumento impressionante di batteri resistenti
ad antibiotici. Di nuovo, i vaccini e le armi immunologiche in generale
possono svolgere un ruolo centrale nell’affrontare minacce vecchie e
nuove.
Fondamentali, dunque, sono sia l’impegno a livello mondiale sul
fronte del controllo e della sorveglianza delle infezioni, sia la ricerca
scientifica, in particolare lo studio dei meccanismi con cui i microbi
creano malattia e lo studio del sistema immunitario. L’obiettivo finale
è mettere a punto nuove armi contro i microbi, prime fra tutte i
vaccini.
Nuove sfide si presentano all’orizzonte per i vaccini. Fra queste, lo
sviluppo di vaccini mucosali, da assumere per bocca o inalandoli
attraverso il naso, in grado di prevenire l’ingresso dei microbi
attraverso quella che è la loro principale porta d’entrata: le mucose.
Proprio qui si trovano cellule specializzate nel dare i segnali
d’allarme che fanno partire la risposta immunitaria appropriata a
livello delle mucose e la produzione di anticorpi IgA. Riuscire ad
attivare questo specifico tipo d’immunità consentirebbe perciò di
prevenire l’entrata dei microbi nel nostro corpo. Senza considerare
che, nei Paesi più poveri, fare a meno della somministrazione
parentereale costituirebbe un grande vantaggio per rendere la
pratica della vaccinazione meglio trasferibile a tutti.
Indispensabile, inoltre, la sfida della messa a punto di vaccini che
attivino risposte nei confronti di virus subdoli come l’HIV (Human
Immunodeficiency Virus), che s’insedia all’interno del sistema
immunitario stesso. Ancora, la sfida scientifica forse più importante è
lo sviluppo di vaccini terapeutici e non più solo preventivi. Ad
esempio contro il cancro è necessario mettere a punti vaccini basati
sull’identificazione e il riconoscimento, da parte del sistema
immunitario, di strutture presenti sulla cellula tumorale, vaccini che
siano capaci di scatenare o riattivare una risposta che ostacoli
efficacemente la crescita neoplastica. Si tratta di una frontiera della
ricerca perché, in generale e non solo contro il cancro, non siamo
capaci di utilizzare i vaccini nella terapia delle malattie, una sfida e
una speranza su cui si sta lavorando nel nostro Paese così come in
tutto il mondo. La strada è ancora lunga ma le prospettive sono
aperte.
Infine, ma non ultima, la condivisione è un’ulteriore sfida legata ai
vaccini. Il fatto che queste armi così efficaci non siano utilizzate per
chi ne ha più bisogno – nelle nazioni più povere del mondo dove
ancora non tutti hanno accesso ai vaccini più elementari –
costituisce una situazione di grave ingiustizia sociale e delle più
grandi frustrazioni di chi studia e lavora nel settore dell’immunologia
e della vaccinologia (HOTEZ ET AL., 2016).
Lo scopo di questo volume e del documento dell’Accademia
Nazionale dei Lincei è di mettere a disposizione della comunità i
pilastri sui quali si fondano lo sviluppo e l’epidemiologia dei vaccini,
oltre che di condividere le sfide della ricerca, in immunologia e in
vaccinologia.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :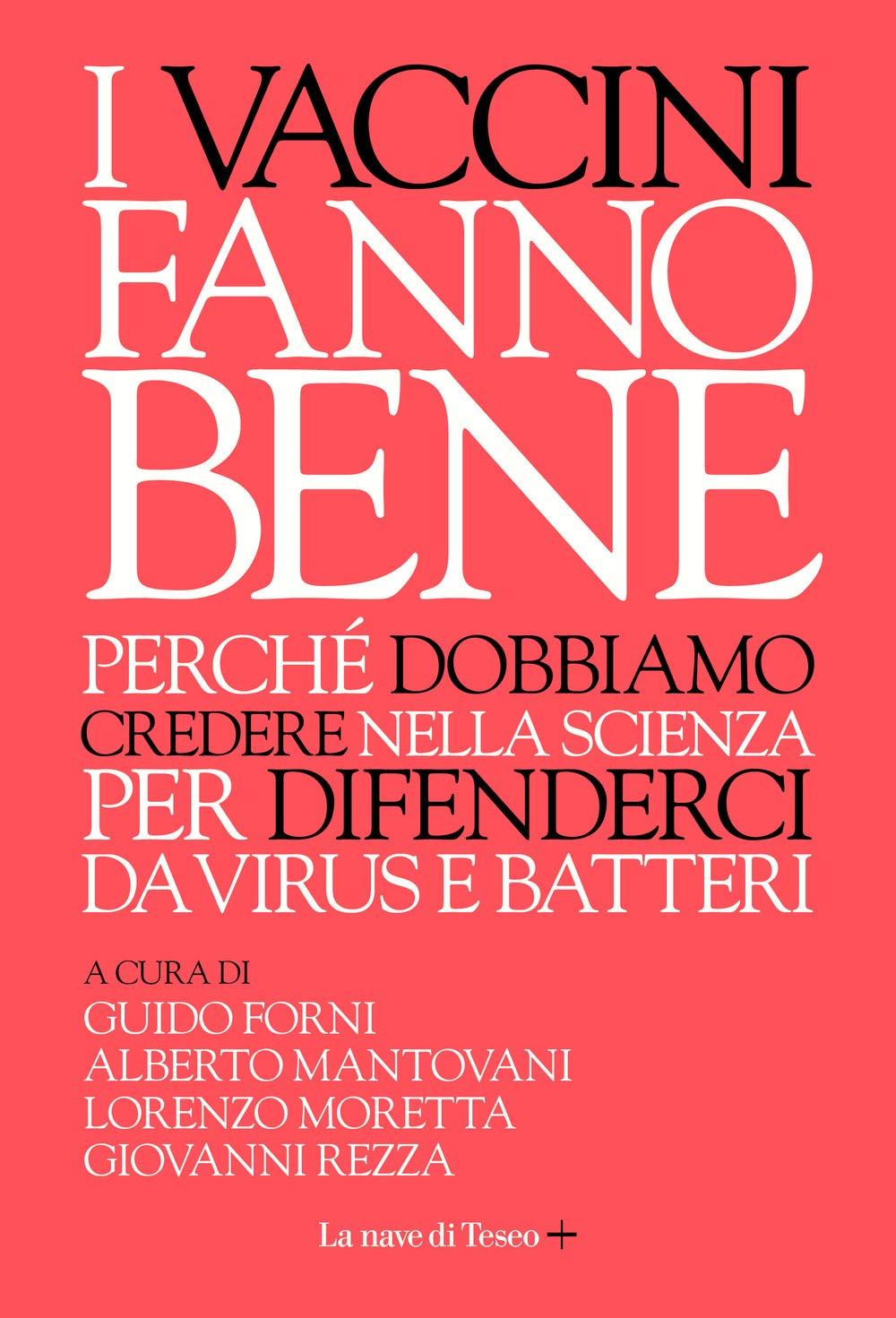




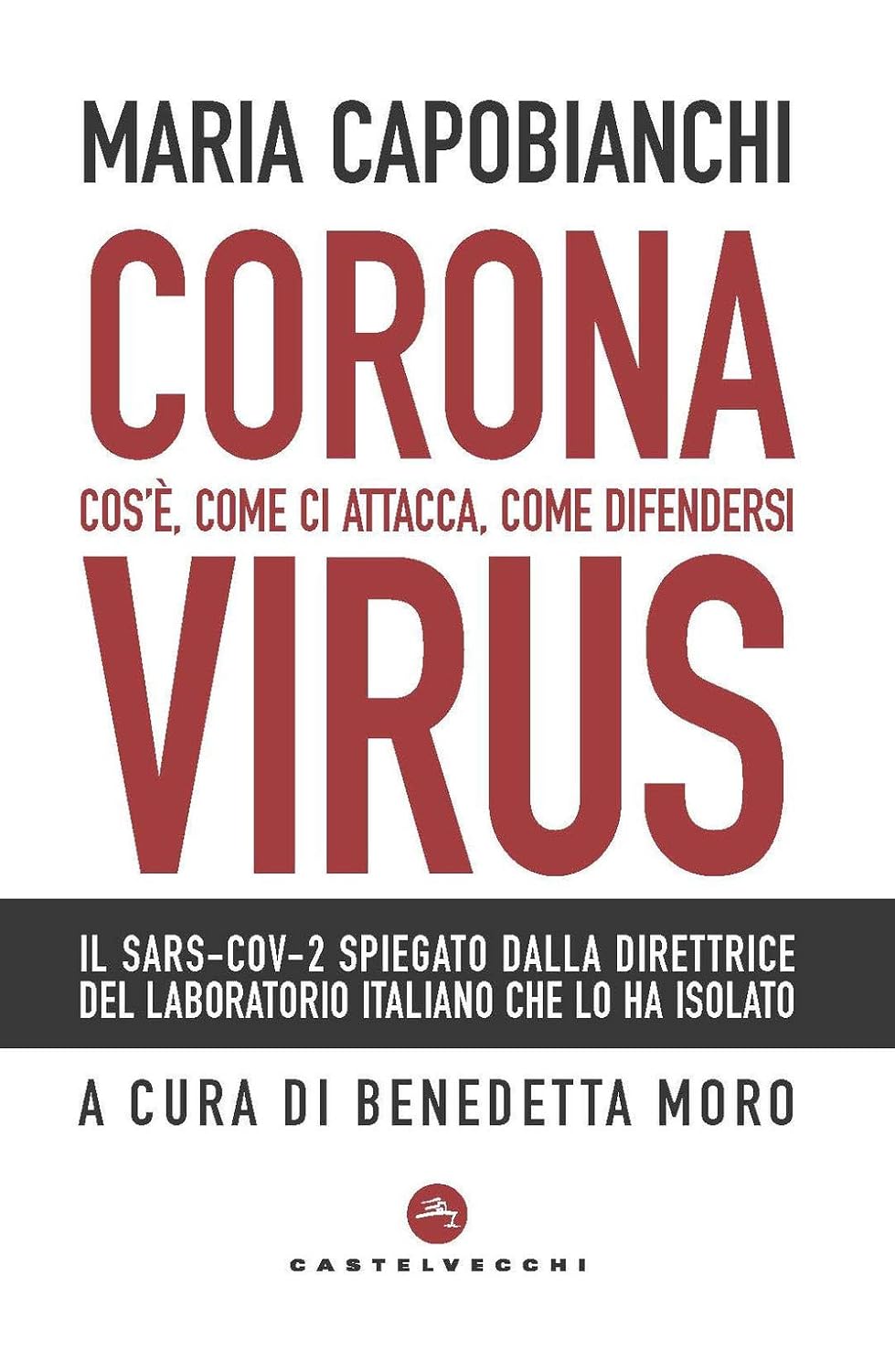
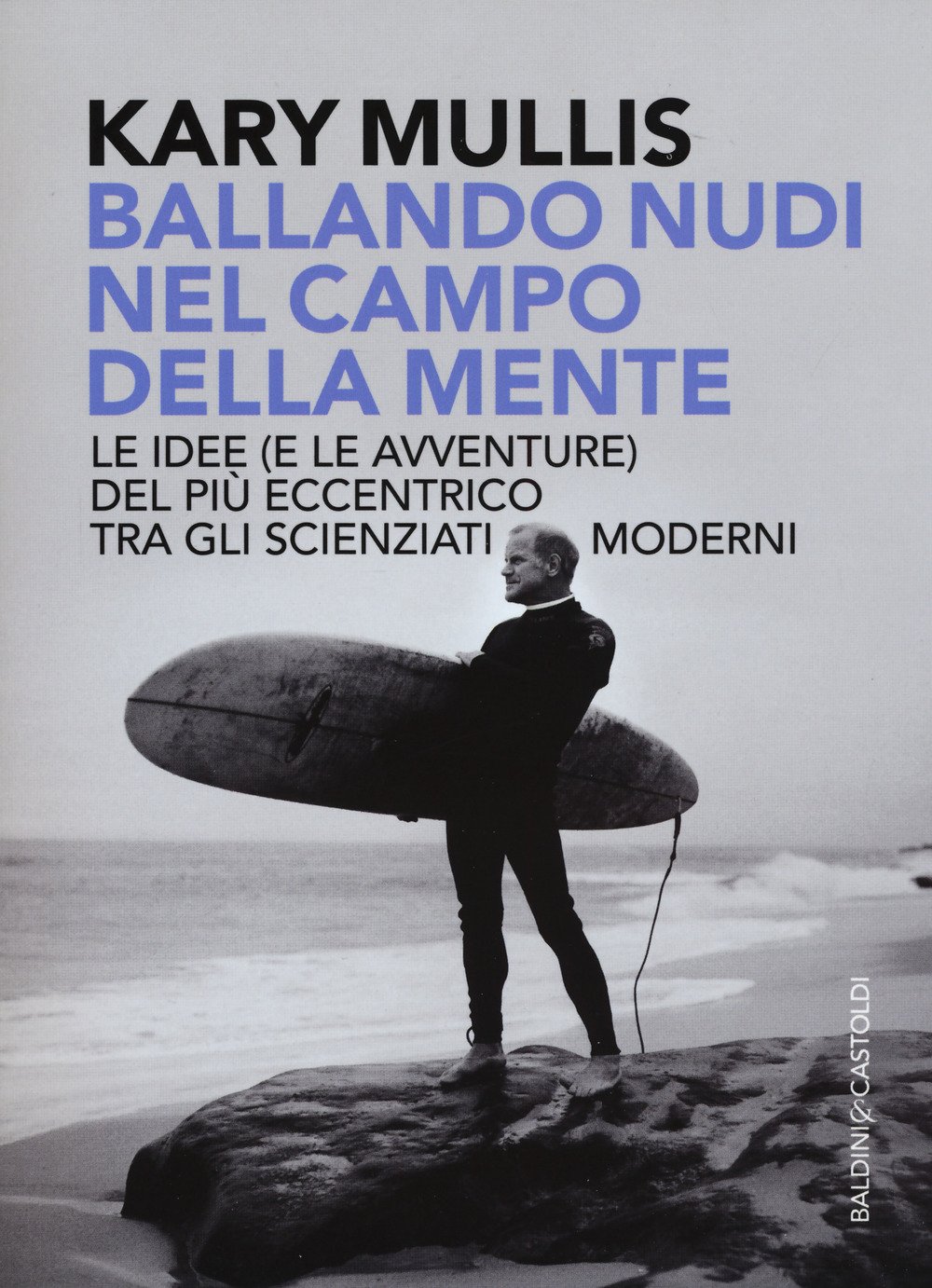
Commento all'articolo