Fede e modernità – Karen Armstrong
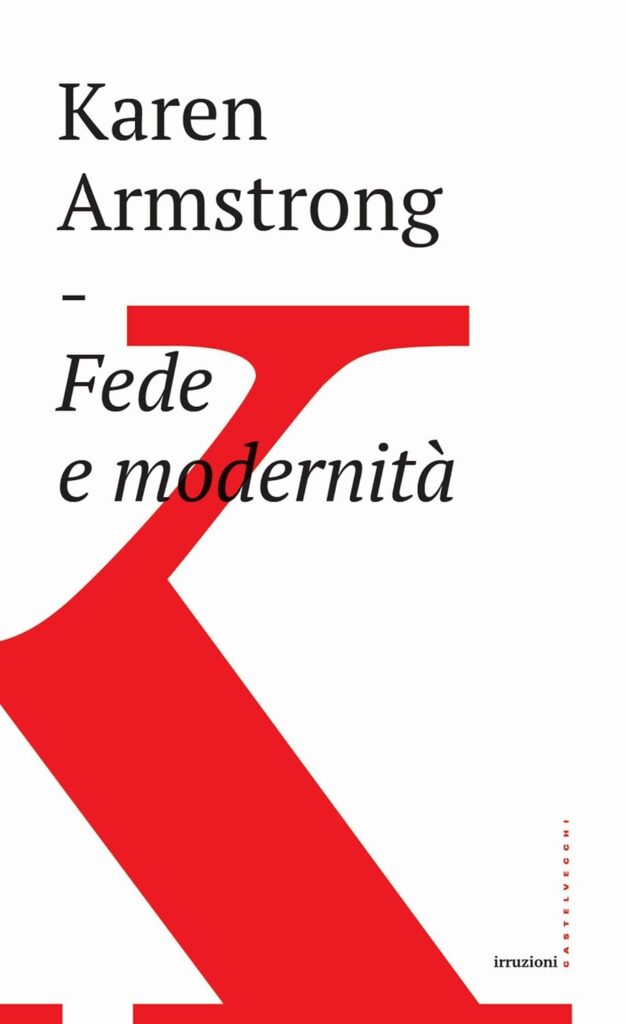
SINTESI DEL LIBRO:
Nel mondo occidentale, è considerata essenziale per la vita della fede una
forte credenza nelle verità obiettive della religione, viste come fatti
incontestabili e dimostrabili. Quando le persone chiedono a qualcuno se sia
religioso o meno, spesso domandano: “Lei crede?” come se l’accettare
alcune proposizioni del credo fosse la principale attività religiosa. Infatti la
fede è equiparata alla credenza, ma quest’equazione ha origini recenti. In
principio il significato della parola “fede” era affine a “fiducia”, come
quando affermiamo di avere fiducia in un amico o in un ideale. La fede non
era una posizione intellettuale, bensì una virtù: grazie ai miti e alla religione
è stata coltivata la convinzione che la vita avesse un significato e un valore
ultimo, nonostante tutte le prove sconcertanti che dimostravano il
contrario. La parola latina credo (tradotta adesso come ‘io credo’) sembra
derivare dall’espressione cor dare: ‘donare il proprio cuore’. La parola
dell’inglese medievale beleven significava ‘amare’. Quando i cristiani
dissero: credo in unum Deum non stavano affermando il loro credo
nell’esistenza di una singola divinità, ma stavano offrendo le loro vite a Dio.
Quando sant’Anselmo di Canterbury pregò nell’XI secolo: Credo ut
intelligam (‘Ho fede per poter capire’)
1 non si stava sottomettendo
ciecamente alle dottrine della religione nella speranza che un giorno, se
avesse rinunciato alla propria coscienza critica, queste incredibili asserzioni
avrebbero avuto senso per lui. La sua preghiera dovrebbe essere in realtà
tradotta in: “Offro me stesso così che io possa capire”. Il significato del
dogma gli sarebbe stato svelato solo se avesse vissuto una vita pienamente
cristiana, abbracciando davvero la mitologia e i rituali della sua religione.
Questo comportamento è estraneo alla modernità. Oggi le persone, prima
di vivere una vita religiosa, sentono il bisogno di analizzare intellettualmente
in autonomia le affermazioni metafisiche. E questo è tipico della pratica
scientifica: bisogna stabilire un principio prima di poterlo applicare. Ma
non è questo il modo in cui la religione ha tradizionalmente funzionato.
Nel mondo moderno la fede ha iniziato a significare l’accettazione delle
verità dottrinali come fatti oggettivi. Quando le persone ritengono di non
essere convinte delle così dette “prove” dell’esistenza di Dio, pensano di
aver perso la propria fede. Le dottrine della religione sembrano false,
perché non possono essere dimostrate dal punto di vista logico ed empirico.
La nostra modernità occidentale ci ha condotti verso una nozione di verità
del tutto differente, e di conseguenza non riusciamo ad essere religiosi come
i nostri antenati. La nostra società scientificamente orientata ha perso il
senso del simbolico, che è alla base di tutte le fedi pre-moderne. Dal punto
di vista della tradizione, secondo cui ogni realtà terrena era una copia del
suo archetipo celeste, il simbolo era inseparabile dalla realtà trascendente
cui indirizzava la nostra attenzione. La somiglianza implicava la presenza,
nello stesso modo in cui il figlio di un amico defunto porta con sé il padre
nella stanza in cui entra e, al tempo stesso, ci rende nuovamente consapevoli
della nostra perdita, della distanza che ci separa dal morto e ci fa sentire la
sua mancanza. Per la fede tradizionale, Cristo era presente in questo modo
nei simboli eucaristici del pane e del vino. Quando i protestanti stabilirono
che l’eucarestia fosse solo un simbolo, essenzialmente separato da Cristo, si
delineò lo spirito moderno.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :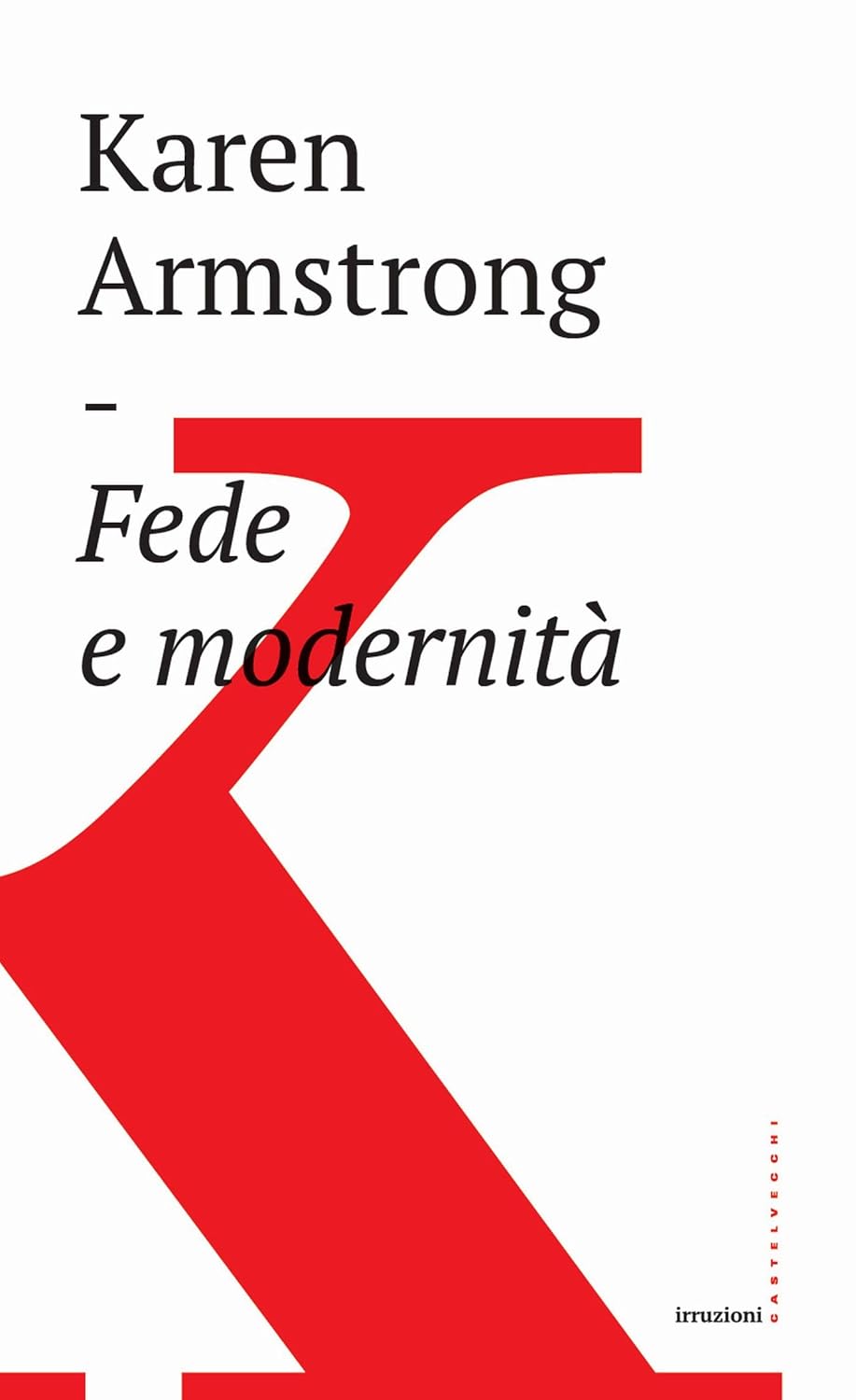






Commento all'articolo