Fariña – La porta europea della cocaina – Nacho Carretero
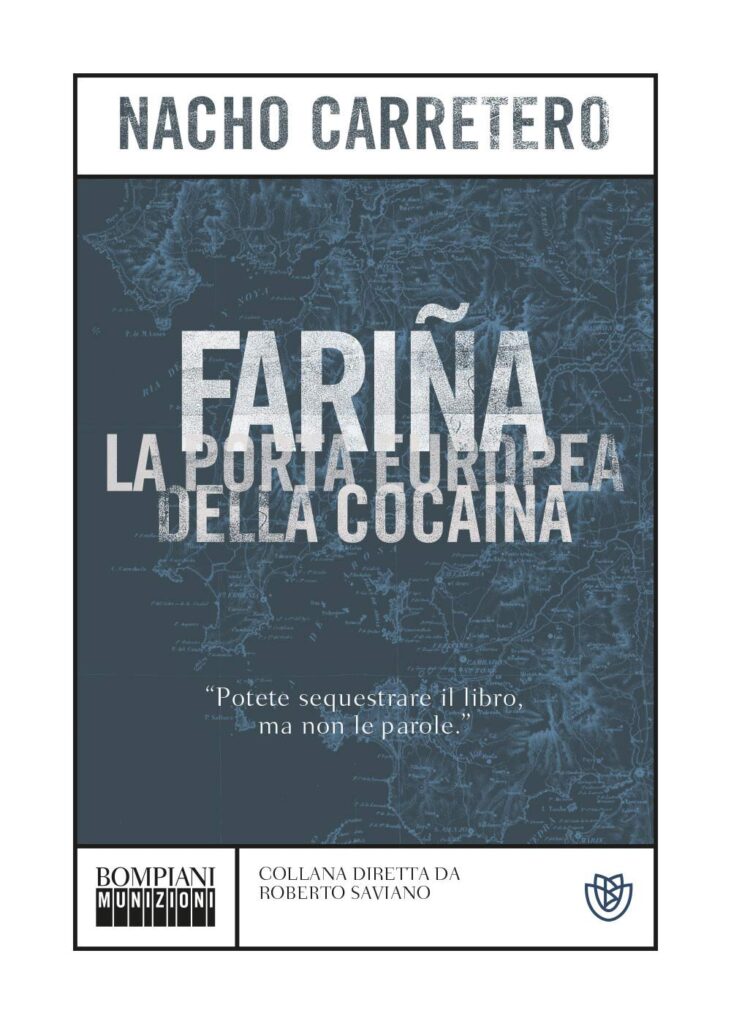
SINTESI DEL LIBRO:
Scorrendo la carta geografica con il dito, come farebbe un
bambino delle elementari, non si direbbe. Eppure la Galizia ha 1498
chilometri di costa. Più dell’Andalusia o di tutte le isole Baleari. Se si
osserva la cartina con attenzione, ci si rende conto che la costa
galiziana rifugge la linea retta. Si accartoccia ostinatamente in
anfratti e cavità ideali per nascondere agli sguardi l’andirivieni delle
imbarcazioni. È un monologo di scogliere e promontori, tra i quali è
facile naufragare. Uno dei suoi tratti è chiamato, non a caso, Costa
della Morte. Ed è proprio qui che comincia questa storia.
I paesi e i villaggi della zona, che sorgono quasi tutti al riparo dal
vento e dalla furia del mare, hanno avuto tra loro scarsi contatti, se si
eccettuano le rivalità tra le confraternite di pescatori e
mariscadores.
1 La remota ubicazione di questi paesini ha inoltre
determinato una fonetica e un accento particolari, spesso non facili
da comprendere. Il fiore all’occhiello di questa zona è il capo di
Finisterre: confine della Terra per i romani, imbarcadero di Caronte
per i greci, chilometro zero del Cammino di Santiago per i cristiani e
stupendo promontorio sospeso sull’Atlantico per qualsiasi turista,
estrema propaggine di un litorale impervio, perfetto per scaricare
qualsiasi tipo di mercanzia senza dare nell’occhio.
Questa zona della Galizia, che va pressappoco dalla Coruña fin
oltre Finisterre, ha sempre vissuto del mare: della pesca e del
commercio marittimo, ma anche delle merci trasportate dalle navi di
passaggio lungo le sue coste, che spesso attraccavano nei porti
principali della regione, come Corme, Laxe, Muxía o Camariñas;
sempre che non venissero prese d’assalto prima di arrivare in porto
o non affondassero.
Quantificare le navi andate a picco in Galizia è uno sforzo
destinato anch’esso al naufragio. Dal Medioevo a oggi, solo nella
zona della costa della Morte, i casi documentati sono 927. Pochi,
secondo la gente del posto. Sull’argomento esiste un dettagliato libro
che s’intitola Costa da Morte, un país de sueños y naufragios, in cui
l’autore, lo studioso Rafael Lema, stila un esaustivo elenco di tutti i
fatti più incredibili accaduti lungo questa costa.
Verso la fine del XIX secolo, per esempio, la nave inglese
Chamois s’incagliò vicino a Laxe e, secondo la leggenda, fu
raggiunta da un abitante del paese che uscì in mare con la sua
barca per prestare soccorso all’equipaggio. Una volta arrivato alla
nave, l’uomo offrì il suo aiuto al comandante, che, credendo che gli
venisse domandato il nome della nave, rispose: “Chamois.” Si
verificò allora un surreale cortocircuito fonetico: il mariñeiro intese a
sua volta che l’imbarcazione trasportasse buoi (bois, in galiziano), e
diede subito l’avviso. In pochi minuti, coltelli e falci alla mano,
centinaia di persone accorse dal paese e determinate a impadronirsi
dei buoi presero d’assalto la nave sotto lo sguardo attonito
dell’equipaggio inglese.
In quegli stessi anni anche il Priam diede in una secca, in questo
caso nei pressi di Malpica, e il suo carico di orologi d’oro e d’argento
finì tra le correnti che lo depositarono sulla spiaggia: sparì nel giro di
poche ore. Sulla battigia comparve anche un pianoforte a coda, e la
gente, pensando che fosse una cassa gigante piena di orologi, lo
fece a pezzi a colpi di machete. In vita loro non avevano mai visto
nulla che assomigliasse a un pianoforte.
C’è poi la storia del Compostelano che, pur non essendo
strettamente legata a un naufragio, merita senza dubbio un accenno.
Il bastimento entrò nella ria2 di Laxe con una manovra perfetta per
poi incagliarsi, quand’era ormai prossimo alla costa, in un banco di
sabbia nei pressi della spiaggia di Cabana. Quando la gente del
paese entrò nella nave, vi trovò solo un gatto: nessuna traccia
dell’equipaggio.
Il 1890 fu l’anno del Serpent, una delle peggiori tragedie marittime
di cui i galiziani abbiano memoria. I cinquecento membri
dell’equipaggio che morirono nel naufragio della nave inglese
giacciono sepolti nel cosiddetto “cimitero degli inglesi”, un pittoresco
camposanto circondato da uno spettacolare paesaggio di spiagge e
promontori. Vent’anni prima una sorte analoga era toccata al
Captain, che affondò di fronte al capo di Finisterre disseminando
quattrocento cadaveri lungo la costa.
Ma l’orrore dei naufragi non sempre si è manifestato ai galiziani
sotto forma di corpi affogati. Nel 1905, il Palermo, carico di
fisarmoniche, andò a picco vicino a Muxía. La leggenda vuole che
quella notte si alzasse dal mare una musica spettrale che terrorizzò
gli abitanti del paese.
Macchine da cucire, stoffe, tappeti e pezzi di ricambio per
automobili riempivano invece la stiva del Nil, che nel 1927 s’incagliò
non lontano da Camelle. Non appena ne ebbe notizia, l’armatore
dispose un presidio di sorveglianza alla nave per proteggerne il
carico. A nulla servì: nel giro di qualche giorno la gente del paese
fece incetta di tutta la merce. Si dice che il Nil trasportasse anche
casse di latte condensato, che, da quelle parti, nessuno aveva mai
visto. Il latte condensato venne così scambiato per vernice e
utilizzato per imbiancare le case del paese: l’invasione di mosche
che ne seguì assunse la portata di un flagello biblico.
Al 1596, ben oltre la portata della memoria collettiva locale, risale
il terribile naufragio di venticinque navi dell’Armada spagnola,
abbattute da una tempesta perfetta. Più di millesettecento persone
morirono in mare. Le cronache dell’epoca descrivono uno spettacolo
raccapricciante: ovunque cadaveri, relitti, l’eco delle grida dei
naufraghi in balia delle onde e, a illuminare la scena, il bagliore dei
lampi.
La lista, insomma, è lunghissima. Tanto che, sulla costa della
Morte, il tempo si misura in naufragi: l’anno del Casón (che costrinse
i cittadini di Muxía a evacuare il paese nel dubbio che la nave
trasportasse prodotti chimici nocivi), l’anno del Prestige, del Serpent.
E così via: una nave, una croce sul calendario.
Ramón Vilela Ferrío, più noto come Moncho do Pesco, è un
vecchio pescatore di percebes3 di Muxía. “Da bambini andavamo
agli scogli in costume da bagno e maglioncino. Se l’onda ti tirava
dentro, era finita. Oggi, con le mute, è meno pericoloso, anche se
ogni anno muore qualche pescatore.” Nella confraternita di Moncho,
negli anni settanta, andavano a percebes circa trenta persone, delle
quali, oggi, ne restano vive solo quattordici. “Qui la vita è sempre
stata molto difficile. A noi mancava persino il pane. Potevamo
ingozzarci di frutti di mare, però non c’era altro. Incredibile, no? È
stato un periodo durissimo.” Moncho, ormai in pensione, ha visto con
i suoi occhi decine di naufragi. “Da queste parti è una cosa normale,”
dice. “Dalle navi romane al Prestige, qui affonda di tutto.” Ride. Poi
aggiunge: “Mia nonna mi raccontava sempre di come tagliavano le
dita ai marinai annegati per prendersi anelli e orologi.” Tutto vero: i
cadaveri dell’equipaggio del Revendal, dell’Irish Hood e del Wolf of
Strong – tutte e tre navi inglesi e tutte e tre naufragate lungo la costa
della Morte nel XIX secolo – furono trovati sulla spiaggia con gli arti
amputati, tanto per fare un esempio.
Menzione a parte meritano i raqueiros, pirati di terra che
disorientavano le navi e le assaltavano: la tattica consisteva
nell’accendere fuochi sulla riva o legare torce alle corna dei buoi, per
poi appostarsi in punti strategici delle scogliere della costa della
Morte. Non appena un’imbarcazione si arenava, la abbordavano
senza pensarci due volte. Poiché la maggior parte delle vittime era
inglese, queste storie approdarono presto sull’isola di sua maestà. E
fu infatti una scrittrice britannica, Annette Meaking, amica della
regina di Spagna Vittoria Eugenia, che, terrorizzata dai fatti che le
venivano riferiti, battezzò quell’angolo di mondo coast of Death,
ovvero, appunto, costa della Morte. Le notizie dei continui saccheggi
che flagellavano le navi britanniche giunsero nel giro di poco tempo
anche ai principali giornali inglesi e, dalle loro pagine, rimbalzarono
fino alla stampa di Madrid, che fece suo il nome coniato dalla
scrittrice. Il problema era così sentito che Londra chiese al governo
spagnolo di adottare misure contro “questa mafia di pirati”.
“Ma non si trattava di una mafia. Non era un’organizzazione di
pirati sistematicamente dedita alla razzia delle navi. Questa teoria
non ha alcun fondamento storico,” precisa lo studioso Rafael Lema,
cercando di mettere un po’ d’ordine in un argomento che si presta
come pochi altri ad alimentare leggende e racconti spesso
impossibili da verificare. Secondo Lema, si dovrebbe parlare
piuttosto di episodi isolati, assalti sporadici. Insomma, l’aura epica
che circonda alcune di queste storie di naufragi è senz’altro
discutibile, ma rende comunque l’idea di una società, un’economia e
un mondo sviluppatisi per secoli grazie alla razzia e al traffico delle
merci depredate.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :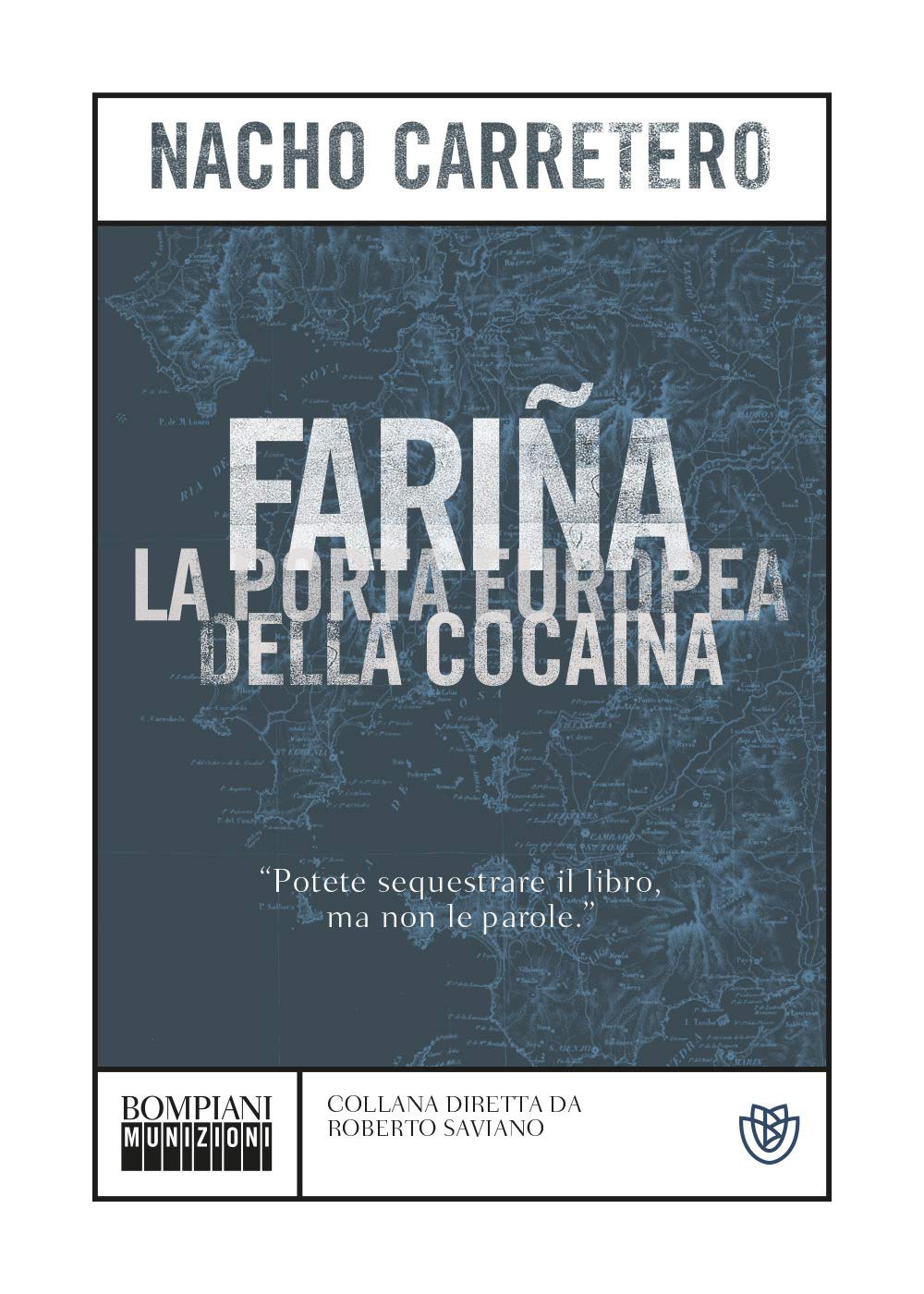






Commento all'articolo