Fai meno vivi di più -Niksen e altri consigli per imparare l’arte del dolce far niente – Annemiek Leclaire
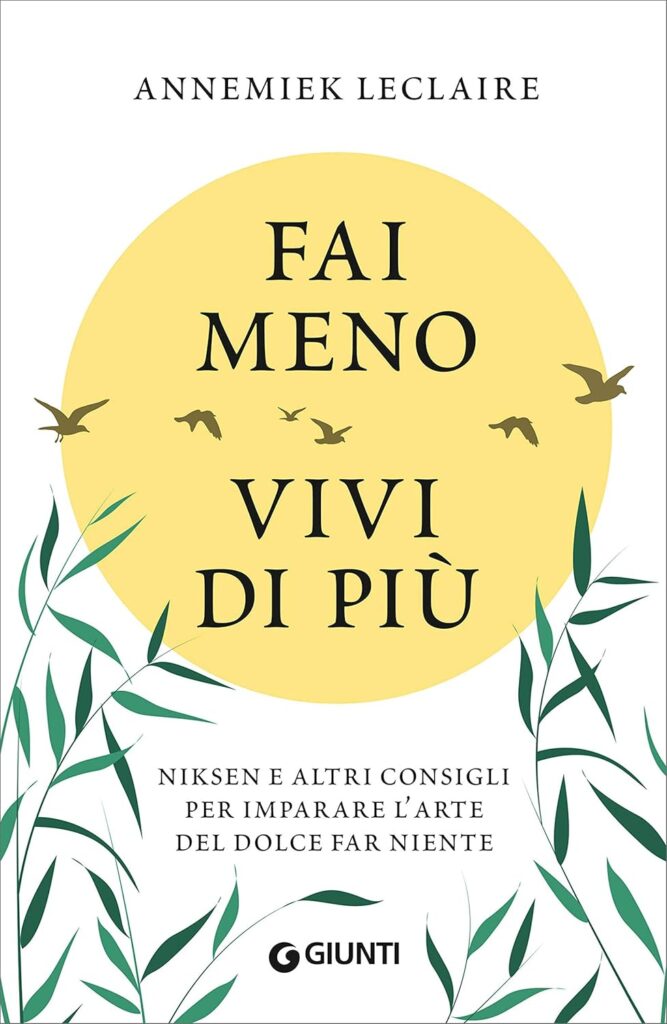
SINTESI DEL LIBRO:
Amo i buoni propositi, stabilire priorità, pianificare e compilare to-do
list, ma smetterò di farlo. Non c’è abbastanza vita. Come scrive Just
van Es in Weg uit het moeten (Via dal dovere): «Ciò che conta non
può essere trasformato in un metodo».1
Da ormai più di vent’anni mi occupo come giornalista della «vita in
sé», sono sempre alla ricerca di saggezza che possa essere tradotta
in regole di vita pratiche, in buone abitudini da coltivare, e negli anni
sono riuscita a intessere nelle mie giornate le cose che reputo
importanti, facendole diventare dei rituali. Sono figlia della cultura del
«volere è potere», figlia di genitori che hanno fatto carriera senza
studiare, per di più cresciuta nella nuova città di Lelystad, una dei
primi abitanti di uno dei primi quartieri. Sono una donna nuova.
Quello della crescita personale era un concetto chiave per la mia
famiglia e il mio giro di amici.
Ultimamente, quando mi sveglio, non sono più impaziente di iniziare
la giornata, ma vedo davanti a me solo una sfilza infinita di doveri. Mi
alzo con una sensazione di nervosismo, anche se non è in ballo
niente di particolare. La crescente avversione nei confronti di una
tabella di marcia zeppa di obblighi viene rafforzata da quello che
succede dietro alle facciate delle case che mi circondano. Vedo vite
blindate, vedo gente che se la passa apparentemente bene piegata
dal peso del «devo», vedo persone benestanti e intelligenti esaurirsi
a causa di obblighi in parte autoimposti. E sebbene alcuni gruppi
siano più sensibili allo stress di altri, la pressione attraversa tutta la
società. Gli adolescenti si lamentano delle agende piene di impegni
e così i pensionati, che invece dovrebbero avere tutto il tempo del
mondo.
Il dovere è radicato nella cultura. Grazie alla generazione
precedente siamo riusciti a liberarci da Chiesa e patriarcato, ma in
compenso ora ci lasciamo pungolare da un manager interiore che
grida continuamente: «Non è abbastanza, fai di più, compra di più,
lavora di più!». È questo il paradosso con cui, secondo il filosofo
culturale fiammingo Kris Pint, ci scontriamo continuamente: siamo
liberi di dare forma alla nostra vita ma allo stesso tempo, in una
società così basata sulle prestazioni, ci sentiamo spesso infelici e
oppressi.
Con «dovere» non mi riferisco alla disciplina mirata al rendimento, o
ai disagi insiti nell’ambizione. Ciò che mi disturba è essere
intrappolati in quel fare quotidiano quasi nevrotico, il cui
adempimento non bilancia la fatica e risulta in un’annoiata
irrequietezza.
Lo psicologo del lavoro inglese Tony Crabbe mi ha spiegato come
funziona questa dissennata irrequietezza: se metti da parte
abbastanza spesso qualcosa che è veramente importante per te,
avviene la rimozione di tutto ciò che un tempo era fonte di piacere e
di energia. E quando poi si presenta un momento tranquillo, non sai
più che cosa fare. Viene a crearsi una sensazione di vuoto da
riempire con un’irrequietezza ancora più vana: un giro su Facebook,
un attimo su LinkedIn. Crabbe lo chiama quick fix e associa alla
depressione l’impoverimento emotivo che ne consegue.
Kris Pint lo riassume così nel libro De wilde tuin van de verbeelding
(Il giardino selvatico dell’immaginazione): «Sentiamo di dover dare
continuamente prova di noi stessi e questo fa sì che abbiamo
sempre troppe cose da fare e troppo poco tempo per ciò che,
tuttavia, consideriamo veramente importante. In linea di principio
produciamo e consumiamo esclusivamente per migliorare la nostra
vita, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che tutto questo non
porta a vivere bene, e che ci scontriamo con dei limiti».2
La sensazione di dovere, di essere sempre «accesi», viene dalla
convinzione di dover lavorare su noi stessi fino allo sfinimento. C’è
sempre quella vocina: puoi essere un genitore migliore, mangiare
più sano, essere più sportivo, più creativo, avere una casa più bella,
lavorare meglio, prenderti più cura della terra, essere un cittadino
migliore e più informato, fare di più per gli altri… se solo dessi il
massimo.
L’ideologia del volere è potere ha raggiunto anche il campo
dell’educazione dei figli. Curo una rubrica settimanale sull’argomento
per il quotidiano NRC Handelsblad e la domanda che sta alla base di
tutti i dilemmi dei genitori è: sto facendo bene? Nelle famiglie di oggi
l’asticella è alta. Dopo un pasto ponderato e ultrasano, i genitori
sovraccarichi passano ancora qualche ora con i figli a studiare
matematica o francese e a ogni gara sportiva sono a bordo campo,
pronti a incitarli. Nel 2018 ho intervistato alcune donne anziane sulla
generazione più giovane. La morale è stata: «Voi volete tutto. Noi
eravamo contente di poter lavorare e a tavola mettevamo
semplicemente qualcosa da mangiare. Per voi dev’essere tutto
perfetto: fisico perfetto, vestiti perfetti, casa perfetta, pasti perfetti».
Tutto quel dovere a loro sembrava un po’ soffocante.
A partire dagli anni settanta, il decennio in cui sono nata, si è fatta
strada l’idea che sia possibile realizzare il nostro «intero potenziale».
«La convinzione protestante dell’imperfezione umana ha lasciato
spazio nella nostra società alla fede nella perfezione umana» ha
affermato lo psicologo delle religioni Rein Nauta, quando l’ho
intervistato sulla vocina accusatoria.
È l’ideologia del volere è potere che ci spinge, tramite una costante
autoeducazione, a realizzare un’immagine ideale: un processo
continuo di sviluppo e di crescita a partire dal nostro corpo per
arrivare alla carriera. E magari pensiamo che tutto questo provenga
da dentro di noi, ma secondo Kris Pint si tratta piuttosto di un ruolo
imposto dalla società che ci affibbia l’immagine dell’«individuo attivo,
sportivo e flessibile, sempre pronto ad affrontare nuove sfide:
un’immagine che non a caso corrisponde esattamente a quella del
lavoratore e consumatore ideale».3
Nella seconda parte del secolo scorso la laicizzazione è andata di
pari passo con la crescita della realizzazione personale. La visione
religiosa del mondo, in cui uomini e donne assumevano una
posizione predefinita, ha subito un forte scossone, le colonne
portanti sono crollate. I metodi contraccettivi hanno liberato la donna.
L’accessibilità dell’istruzione superiore ha offerto a chiunque potesse
e volesse studiare la possibilità di sottrarsi alla povertà e di trovare
un lavoro adeguato. La figlia del panettiere poteva diventare
chirurgo, quella del maestro di paese una commercialista ricca
sfondata. All’epoca l’emancipazione dev’essere stata per molti
un’enorme liberazione.
Il movimento dello human potential, una corrente psicologica
proveniente dagli Stati Uniti, ha avuto una grande influenza a partire
dagli anni settanta. Andare a fondo con la terapia doveva liberare
l’individuo da un adeguamento obbligato ai genitori e alla società.
Era l’epoca in cui nascevano i libri di autoaiuto, e i lettori che si
ponevano domande esistenziali cercavano meno rifugio nella
religione e più nella psicologia, che offriva consapevolezza e
sostegno. Libri come Te stesso al cento per cento di Wayne Dyer
fecero credere a milioni di persone che vivere bene fosse a portata
di mano, se solo avessero lavorato per ottenerlo.
L’identità moderna non ha preso forma in un ambiente sottovuoto.
Negli anni ottanta è nata una figura di uomo «neoliberale»: un
individuo autonomo che, in qualità di capo dell’impresa «io», era
sempre in competizione con gli altri per massimizzare il proprio
profitto. Questo ha creato non solo una società basata sulle
prestazioni, ma anche sulla presentazione. Saper fare bene
qualcosa non basta, dice il filosofo Peter Venmans in Discretie,
essay over een vergeten deugd (Discrezione, saggio su una virtù
dimenticata), dobbiamo soprattutto venderci bene. Per farlo servono
caratteristiche di estroversione come assertività, indipendenza e
riuscire a mettere se stessi prima di tutto.
Ne è scaturito un nuovo nervosismo: un tempo chi nasceva in una
situazione sociale svantaggiata non aveva scampo. Doveva
accettare la realtà dei fatti. Adesso è vero il contrario. Sfruttando
possibilità come lo studio e il lavoro puoi diventare chi vuoi. Non ci
sono limiti a quello che si può influenzare, ma sono anche
aumentate le colpe di cui farsi carico. Solo tu sei responsabile di ciò
che ti succede. Un’avversità diventa quindi un fallimento personale.
Avevi la possibilità di fare diversamente, ma non ci sei riuscito.
L’assenza di successo e riconoscimento non è dunque causata da
semplice sfortuna, ma viene vissuta come un affronto all’io. Nauta la
definisce una «ferita narcisistica, la patologia dell’individualismo».
L’immagine che abbiamo di noi stessi è diventata subordinata ai
nostri piccoli successi personali, rendendoci insicuri e stressati: visto
che il modo in cui ci vediamo dipende dalle nostre prestazioni, non
possiamo mai essere sicuri di noi stessi, dopotutto sono sempre gli
altri ad attribuirci un valore di mercato. «Non c’è da stupirsi» dice
Kris Pint «che il burnout, assieme allo stress e alla depressione,
sembri essere diventato la malattia occidentale per eccellenza. Tutta
quell’impotenza, quel gigantesco senso di colpa! Invece di
addossare la colpa all’individuo se qualcosa va storto, sarebbe più
sensato prendere atto del fatto che c’è qualcosa che non quadra in
questa fiducia collettiva nell’homo oeconomicus, che può stabilire da
solo i propri valori e fa sempre le scelte razionali giuste.»4
Secondo Pint, nel corso della storia gli uomini hanno ragionato su se
stessi in maniere sempre diverse. Oggi tentiamo di costringerci a
soddisfare lo scomodo ideale dell’homo oeconomicus neoliberale
credendo di essere «manager della nostra vita», ma naturalmente
non ci riusciamo. Pint auspica un «modo di essere più ampio»:
«Dobbiamo ribellarci attivamente all’immagine che ci viene imposta
di noi stessi».5
Anche Damiaan Denys, direttore del reparto di Psichiatria dell’AMC
di Amsterdam (Centro medico accademico), neuroscienziato del
Nederlands Herseninstituut (Istituto olandese di neuroscienze) e
presidente della Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (Società
olandese di psichiatria), ha notato questa incerta tensione verso il
«meglio» e il «di più». Secondo lui dobbiamo essere perfetti come
un iPhone 10. «La laicizzazione ha fatto sì che non abbiamo più una
bussola morale interiore a guidarci. Al suo posto, ci siamo creati
un’immagine ideale sulla base di quelle che pensiamo essere le
aspettative che gli altri hanno su di noi» afferma. Si tratta di immagini
incostanti e mutevoli, impossibili da soddisfare. «Sono immagini che
ci arrivano da un mondo irreale in quanto virtuale. Online o sulle
riviste patinate non c’è più neanche una foto che non sia ritoccata
con Photoshop. Così continuiamo a sentirci eternamente in difetto»
dice. «E questo naturalmente fa sì che viviamo una vita molto
inquieta.»
Proprio come Tony Crabbe e Kris Pint, Denys riconosce come
questa sensazione di inadeguatezza venga «annullata in maniera
superficiale»: facciamo binge watching su Netflix, beviamo…
«vogliamo essere distratti velocemente, ci piace assentarci dal
mondo». Preferirebbe vederci investire il tempo nella «ricerca di un
significato personale», per definire la direzione che vogliamo
seguire. Dice Denys: «Io stesso dedico molto tempo a raccogliere
letteratura e conoscenze per stabilire cosa trovo o meno sensato
nella mia vita. E sì, è qualcosa che costa molte energie mentali, non
si trova in una app».
Il dovere si basa soltanto su un’illusione imposta, è un errore di
pensiero, è qualcosa che esiste solo nella nostra testa? Secondo
Rein Nauta, no. Molto tempo fa, nel 2000, l’ho intervistato sul tema
del senso di colpa in un mondo laicizzato. A suo avviso, in una
società basata sulle prestazioni i sensi di colpa e di vergogna
riguardavano principalmente il sentirsi in difetto rispetto all’immagine
ideale che abbiamo di noi. Le persone diventavano vulnerabili,
poiché una forte ambizione è accompagnata dalla consapevolezza
di fallire costantemente, e un eccesso di dipendenza
dall’approvazione e l’ammirazione degli altri è associato alla
mancanza di tempo e di disponibilità per il prossimo. Nauta definì
«spaventosi» i tentativi di controllare l’insicurezza con corsi di
crescita personale e coaching, «perché sono legati alla stessa
onnipresente mentalità efficientista che ne è stata in primo luogo la
causa».
Quasi diciannove anni dopo quella conversazione chiedo
nuovamente a Nauta, ormai pensionato, come possiamo
comportarci nei confronti di questo senso del dovere e della
conseguente sensazione di non farcela. Secondo lui la società
efficientista è diventata ancora più imperativa. E l’asticella è alta in
ogni campo. «L’altra volta parlavamo di colpa e vergogna» dice «ora
sono in ballo sopravvivenza e burnout. Erano bei tempi, nel 2000,
tutto era possibile e, se non riuscivi a ottenere qualcosa, dipendeva
da te. Ma la libertà di allora è acqua passata. La tua generazione si
trova in una morsa. La pressione lavorativa è alta, oggi ti porti il
lavoro a casa, i posti di lavoro sono scarsi, i contratti sempre più
spesso temporanei, l’esistenza è più insicura. Non puoi dire
semplicemente di no, perché ci sono molte persone che vogliono il
tuo posto. Quindi non è solo che vuoi rendere, devi rendere.»
Secondo lui si sono aggiunti molti più obblighi, a partire dai figli.
Quando i suoi figli erano piccoli, a lui non era richiesto così tanto.
Non dovevi stare a bordo campo mentre tuo figlio giocava a calcio o
a hockey, potevi dedicare quel tempo a rilassarti: incontravi amici,
andavi a bere qualcosa con loro. Al giorno d’oggi i genitori
accompagnano i figli dappertutto, nota. «Certo, l’hai voluto tu, ma
tutto sommato è un sacco di roba da fare ed è difficile sottrarsi.»
Non prendiamoci in giro, mette in guardia lo psicologo delle religioni.
«Qual è l’alternativa al “dovere”? Lavorare due giorni e rimanere a
casa gli altri tre? È davvero un’opzione per persone ambiziose con
un mutuo da pagare? No, devi continuare, non devi mollare. E sì,
arranchi perché non puoi fare tutto contemporaneamente. Arranchi
con i figli, arranchi con il lavoro. Quella di oggi è un’esistenza molto
rischiosa, con troppa carne al fuoco. O riesci a rimanere in piedi in
questa situazione così difficile oppure ti becchi un burnout.»
«Dov’è la consolazione?» gli chiedo, un po’ scossa.
«La consolazione sta nel fatto di non essere gli unici a trovarsi in
quella terribile morsa e a non poterne uscire. L’autocompassione sta
nel realizzare che “non sono libero”.» Secondo Nauta, quindi, la
naturale continuazione della tradizione del volere è potere sarebbe
riflettere su come comportarsi nei confronti delle tensioni, seguendo
magari un programma di mindfulness ed esercizi di gratitudine o un
corso su «Come diventare meno perfezionista». Ma anche questi
sono a loro volta degli obblighi. No, dice, e propone l’esatto opposto:
«Una presa di coscienza radicale: non sono libero, eppure di tanto in
tanto mi fermo, semplicemente non faccio determinate cose»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :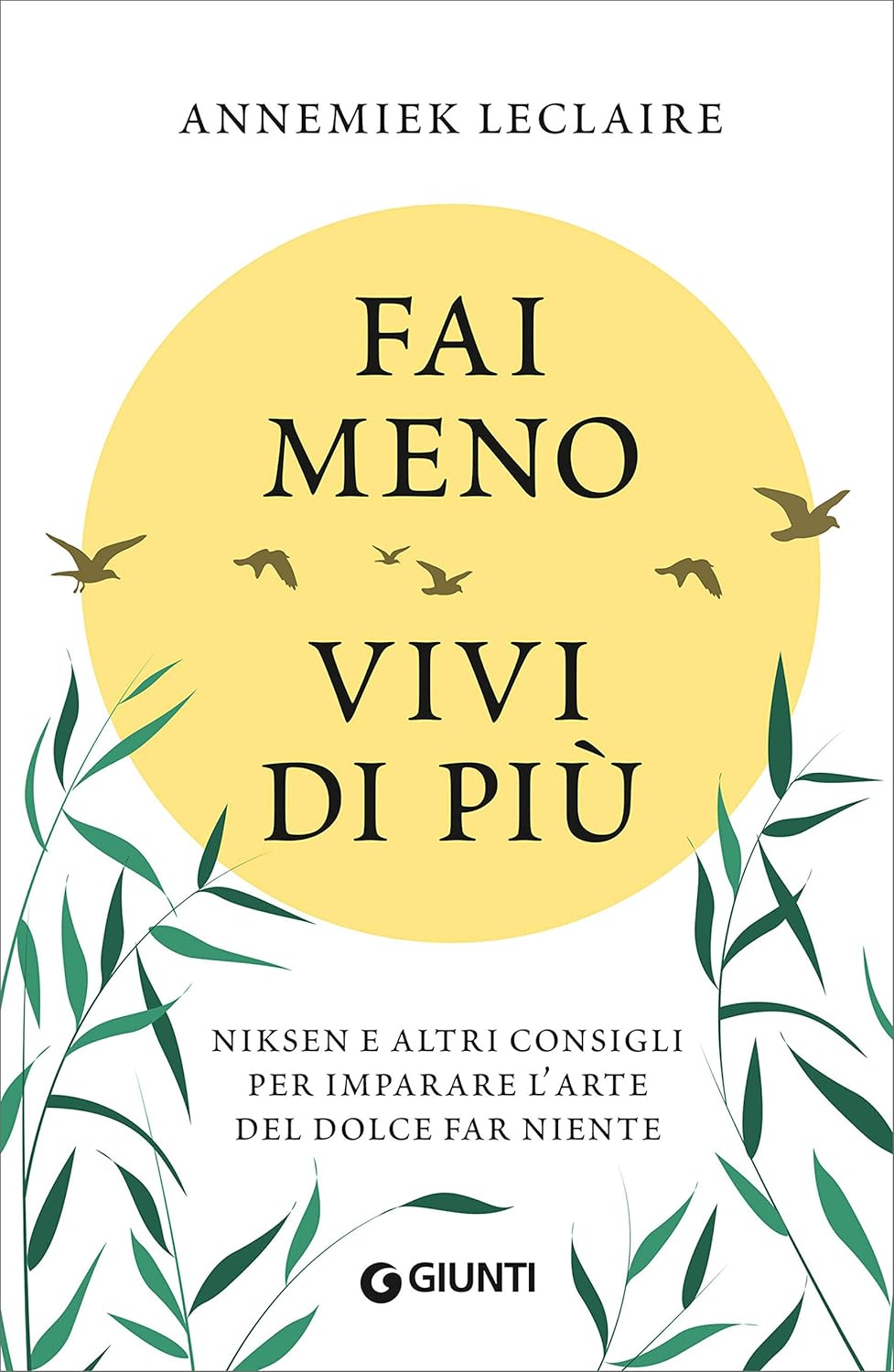






Commento all'articolo