Diritto allo specchio – Gustavo Zagrebelsky
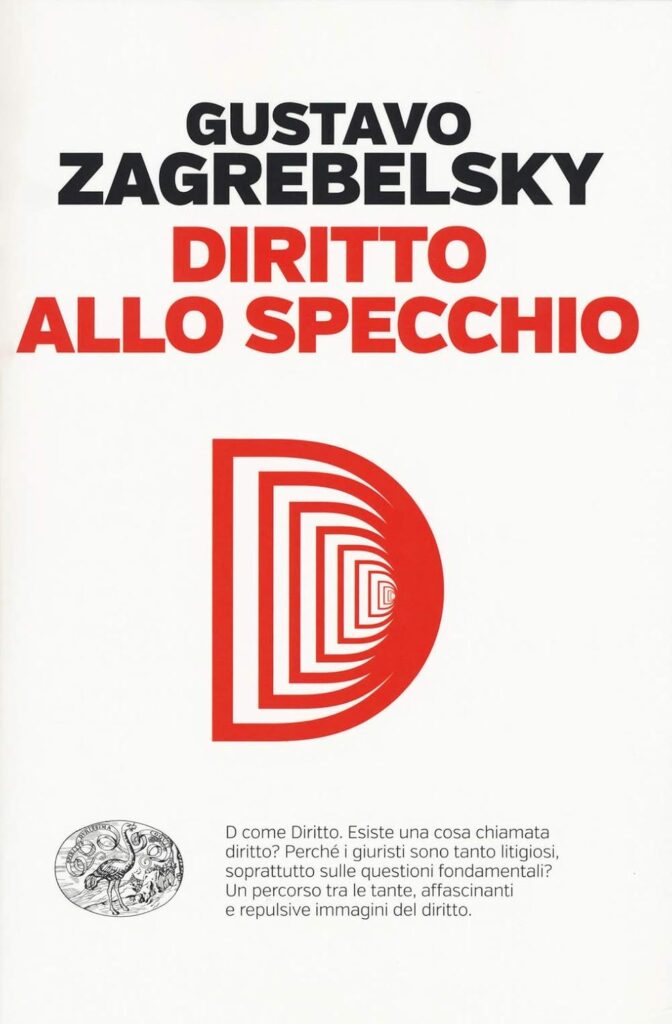
SINTESI DEL LIBRO:
Finora, nel Prologo, abbiamo parlato del diritto in rapporto con la
società. Che cosa si possa intendere per “società” potrebbe essere il
tema di un intero gruppo di lezioni, tante ne possono essere le
concezioni, le esemplificazioni, le critiche che a partire dalle une si
rivolgono alle altre. Ma ciò non rientra nel nostro piano e, tanto
meno, nelle mie competenze. Qui, possiamo accontentarci di una
nozione intuitiva come per esempio questa: un insieme ordinato di
coesistenze che formano una convivenza stabile nel tempo. La
distinzione coesistenze-convivenza è ricca di significati su cui si
potrebbe esercitare la nostra riflessione. Ma dobbiamo lasciarla in
sospeso perché, invece, qui ci tocca domandarci in che cosa
consiste quell’oggetto della scienza che è la scienza giuridica, cioè il
diritto. La risposta non è unica, ma triplice, a seconda che lo si
guardi dal punto di vista delle norme naturali, delle norme storicosociali, delle norme statuite dal legislatore. Dai tre punti di vista
anzidetti nascono tre grandi “scuole” della scienza giuridica: il
giusnaturalismo, la scuola sociologica e il positivismo giuridico.
Ognuna di esse colloca le “fonti del diritto” in qualcosa di diverso,
cioè “ha le sue fonti”: la natura, i rapporti sociali, la legge.
I. Giusnaturalismo.
1. Diritto naturale.
Il diritto naturale di cui si occupa quella corrente di pensiero che
chiamiamo giusnaturalismo è indubbiamente una risorsa cui spesso
si ricorre per appagare il bisogno di sicurezza (si noti: stiamo
parlando non di diritti umani o diritti naturali, cioè di di quelli che i
giuristi chiamano «diritti soggettivi», ma di «diritto oggettivo», cioè
delle norme giuridiche). Di fronte a veri o presunti arbitrî e, perfino, ai
veri e propri delitti compiuti in nome delle tradizioni sociali o, piú
spesso, con l’avallo della legge fatta dagli uomini, che cosa è piú
rassicurante di una legge obbiettiva, sempre uguale e valida per tutti,
la legge che vediamo impressa in quella realtà esterna in cui siamo
immersi, la legge di natura, per l’appunto, che gli uomini non
possono alterare e corrompere a loro piacimento, se non al rischio
del loro stesso male? Che cosa c’è di piú confortante, ma anche deresponsabilizzante, che il poter dire: non dipende da me, da noi;
dipende dalla natura ch’io, tu, nemmeno noi tutti insieme possiamo
cambiare? Deresponsabilizzante perché esonera dall’assumersi il
compito e il peso di cercare che cosa sia piú o meno giusto per noi,
ma massimamente obbligante nei confronti della ferrea legge di
natura che non è lecito cambiare. Diffusa è la contrapposizione tra
ciò che è naturale e sta fuori di noi, e ciò che è artificiale e procede
da dentro di noi. Questa contrapposizione sembra formare la
struttura mentale originaria degli esseri umani che condiziona il
rapporto tra loro e il mondo. Ciò che sta fuori è fermo, intero, vero,
giusto. Ciò che sta in noi è variabile, parziale, fallace, sempre a
rischio d’ingiustizia. La natura non sbaglia mai; è negli artifici degli
esseri umani che s’annida l’errore.
La filosofia, tuttavia, ha distrutto la possibilità di ragionare cosí
semplicemente, anzi semplicisticamente. Già in Aristotele c’è
l’affermazione che la natura dell’uomo è l’artificio. Ma piú della
filosofia, è il tempo attuale, il tempo in cui la “natura” e perfino la
natura dell’essere umano può essere il prodotto del suo “artificio” –
potenza della genetica; il tempo in cui il dentro e il fuori di noi, il
soggetto e l’oggetto insieme si confondono; il tempo in cui la
sopravvivenza della natura richiede la mobilitazione di tante energie
artificiali a sua difesa e rende vana quella distinzione. Ciò non di
meno, continuiamo a ragionare cosí: anzi, ci aggrappiamo ancor di
piú a quella distinzione, come a un’assicurazione. Forse, ne
abbiamo un bisogno “naturale”, per non cadere preda della vertigine
di un soggetto – l’essere umano – che, al tempo stesso, è o sta
diventando oggetto di se stesso; un soggetto avvolto e sprofondato
cosí in un circolo vizioso esistenziale. Il pensiero religioso vede in ciò
la bestemmia dell’uomo che vuole farsi Dio, cioè imitare l’unico che,
secondo un’interpretazione del libro dell’Esodo (3,1-6), può dire di
«essere colui che è», in forza solo della potenza della sua essenza.
Colui che vuol essere quello che è in forza di se stesso è l’uomo-dio,
cosí ben rappresentato dal tragico e paradossale ingegner Kirillov in
I demoni di Fëdor Dostoevskij, il quale, per dare prova di totale
libertà intesa come signoria sulla propria esistenza, si faceva
padrone della sua vita e della sua morte suicidandosi 1
.
C’è il paradosso per nulla stupefacente che, proprio quando è
diventato insostenibile a causa della caduta dei confini reciproci, il
binomio natura-artificio sia stato riscoperto, per trovare in esso la
norma delle azioni umane, una norma che assegna al “naturale” il
primato sull’“artificiale”, sinonimo di inganno, abuso, adulterazione.
Tale primato, tuttavia, ha bisogno d’una fondazione; deve rispondere
a un “perché?” Perché ciò che è naturale vale piú di ciò che è
artificiale? La risposta è una sola: perché la natura è il regno
dell’ordine giusto e l’ordine è giusto perché è voluto dagli dèi o da
Dio, o è esso stesso dio, come credono coloro che si ispirano allo
spinoziano deus sive natura. Il diritto naturale, cosí concepito, è un
atto d’umiltà dell’essere umano nei confronti del sovrumano. Il
sovrumano è stato per secoli il terreno delle religioni che si facevano
interpreti della volontà divina nell’ordine delle cose umane. A partire
dal Seicento, tuttavia, l’autorità delle Chiese è stata contestata come
cattiva interprete dell’ordine delle cose e combattuta in nome del
deismo e del razionalismo: l’ordine predicato dagli ecclesiastici che
sostituiscono alla parola di Dio la loro o, semplicemente, la rivestono
arbitrariamente dell’autorevolezza ch’essi pretendono per sé da una
loro presunta investitura divina, fu considerato un raggiro, un
inganno al servizio dell’ignoranza e dell’oscurantismo. Il culmine
della denuncia fu raggiunto quando diversi testi di larga circolazione
(e d’incerta attribuzione) denunciarono Mosè, Gesú il Cristo e
Maometto, insieme ai loro epigoni, come colpevoli di «impostura» 2
.
Non si trattò, peraltro, dell’abbandono dell’idea del carattere
naturale del diritto. Si trattò della contestazione dell’autorità che da
questa nozione derivava. Si trattò non d’una distruzione, ma d’una
usurpazione a favore dello spirito laico e della ragione illuminata
degli esseri umani, affrancati dai dogmi chiesastici. Il diritto naturale
diventò cosí «diritto di ragione», insofferente nei confronti della
tradizione e basato sulla sovranità non piú di Dio, ma del pensiero
critico di cui soprattutto i filosofi si riservano il deposito: la filosofia al
posto della teologia. Immanuel Kant, con il suo «sapere aude» tratto
dalla prima Epistola di Orazio e rivolto a tutti gli appartenenti al
genere umano, può essere il nome di riferimento.
Il nucleo essenziale comune d’ogni giusnaturalismo è l’esistenza
d’un ordine giusto nelle cose umane, ma l’autorità di chi se ne
assume la rappresentanza può cambiare ed effettivamente allora
cambiò sede: dai concili e dai sinodi ecclesiastici alle società
filosofiche. I “lumi” presero il posto dei “dogmi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :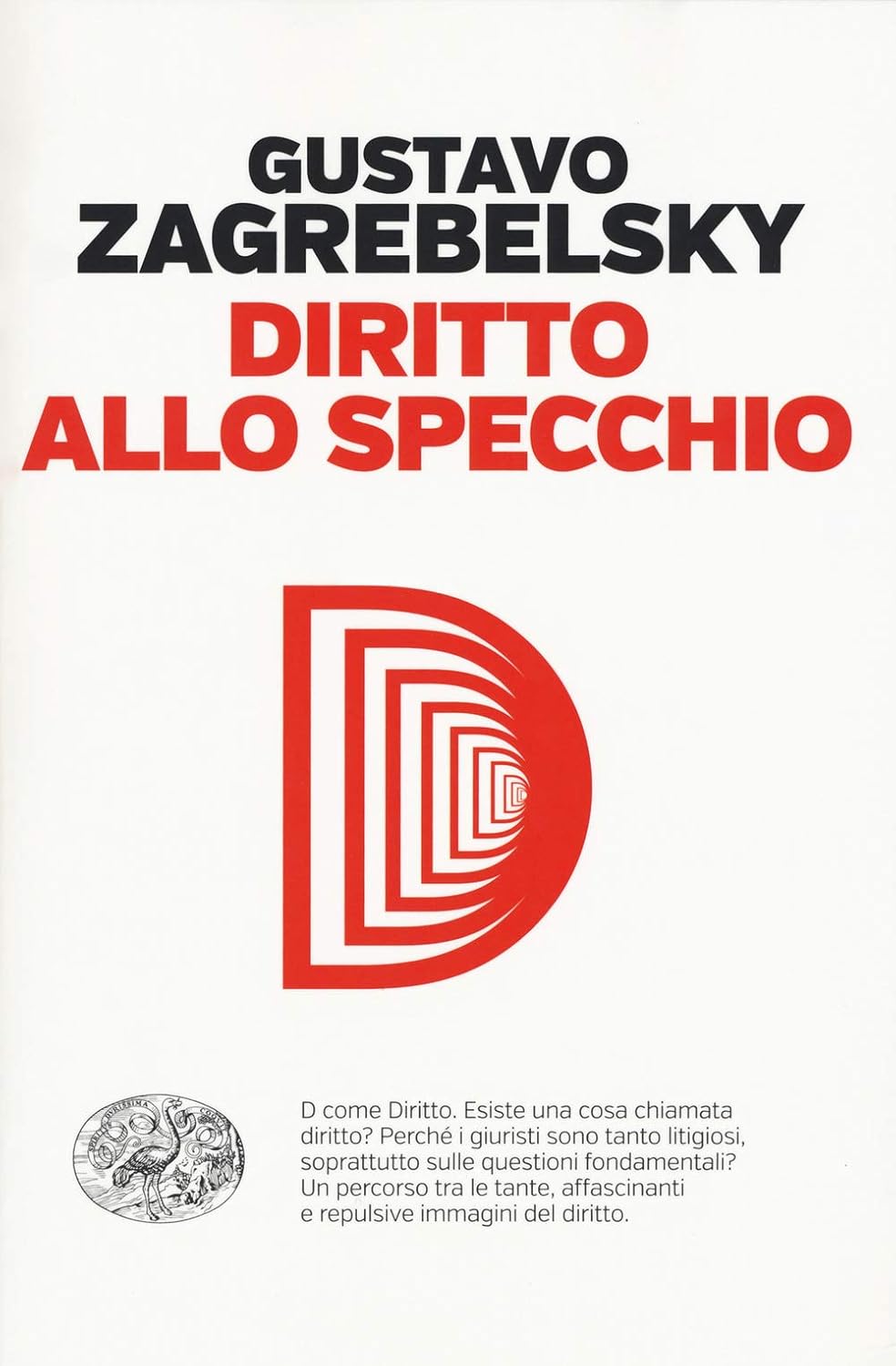





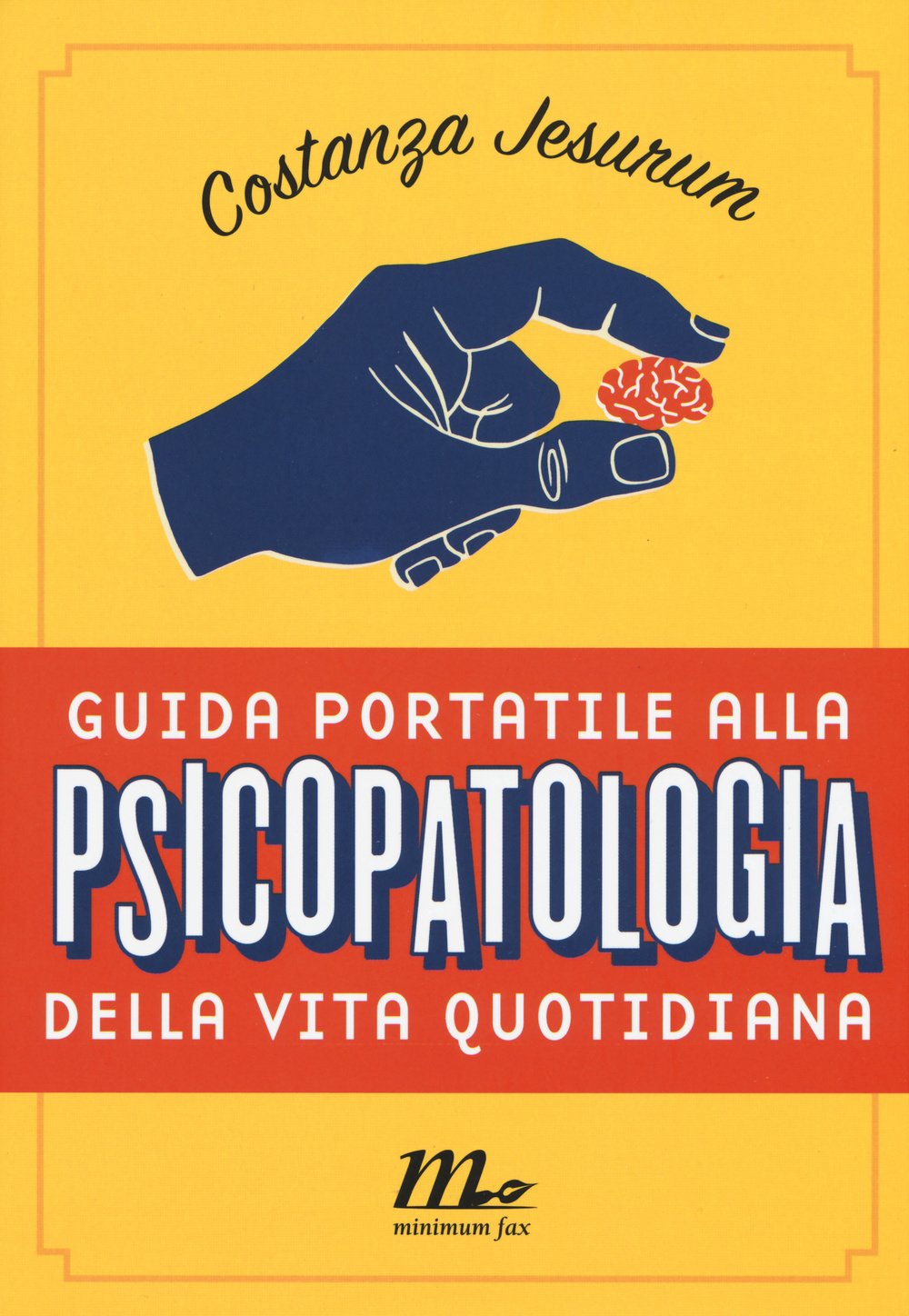
Commento all'articolo