300 ricette da 300 calorie – Per mangiare sano tutti i giorni e controllare il peso, senza rinunciare al gusto – Francesca Ghelfi
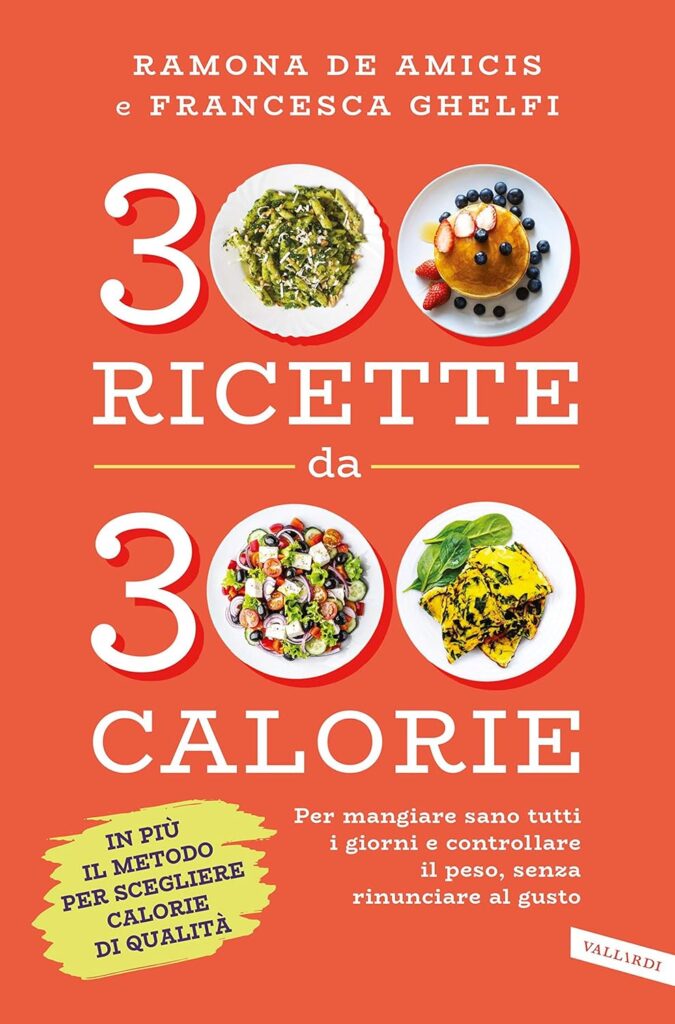
SINTESI DEL LIBRO:
La prima domanda a cui vogliamo rispondere è proprio questa, e il
motivo è perché per anni al concetto di dieta veniva abbinato il solo
concetto di calorie, ossia di energia, sia quella introdotta con gli
alimenti sia quella consumata con l’attività fisica. Infatti, alla base
della composizione corporea (la proporzione di massa grassa e
massa magra di cui siamo fatti) c’è il bilancio calorico della giornata:
se esso è positivo, quindi introduciamo più calorie di quante ne
spendiamo, aumentiamo di peso; al contrario, se è negativo,
perdiamo peso.
Sì: «A carnevale ogni scherzo vale…»
Il fabbisogno energetico è la quantità di energia introdotta con gli
alimenti (misurata in calorie, kcal) necessaria a compensare il
consumo energetico di un individuo. Risponde, cioè, alla domanda:
«Quante calorie dovete assumere?»
Le calorie di cui una persona ha bisogno sono strettamente
dipendenti dal dispendio energetico, ossia da «quante calorie
vengono consumate». Il dispendio energetico, e, di conseguenza, il
fabbisogno energetico dipendono da diversi fattori:
il metabolismo basale, pari alle kcal che il corpo consuma in
condizioni di digiuno e riposo per tutte le attività legate alla
sopravvivenza (respiro, battito cardiaco, funzioni vitali), ed è pari
al 60-70% del dispendio energetico totale, escludendo gli stati
fisiologici straordinari (per esempio, la gravidanza) o patologici;
il metabolismo cinetico, ossia le kcal che l’organismo
consuma per muoversi e per svolgere attività sportiva più o
meno intensa, e che rappresenta il 15-30%;
la termogenesi indotta dagli alimenti, ossia le kcal che il corpo
consuma per digerire e assorbire i nutrienti introdotti con gli
alimenti, e che rappresenta il 5-15%, e viene perciò trascurata
nel calcolo del fabbisogno energetico.
Per stabilire il fabbisogno calorico ci sono diverse formule che
tengono in considerazione fattori quali l’età, il sesso e il peso, che
influenzano fortemente il fattore principale del dispendio energetico,
cioè il metabolismo basale.
Per far sì che un individuo mantenga un peso e una composizione
corporea nella norma, presupposto essenziale per un buono stato di
salute generale, è necessario che il bilancio calorico tra le entrate
(fabbisogno) e le uscite (dispendio) si mantenga in equilibrio, ossia
che le calorie assunte siano in pareggio con quelle bruciate.
Quando, invece, il bilancio calorico è positivo, state quindi
assumendo più calorie rispetto a quelle consumate e questa energia
in eccesso sarà conservata dall’organismo per sintetizzare nuovi
tessuti, prevalentemente tessuto adiposo se siete sedentari e/o
tessuto muscolare se siete più attivi. Si ha, quindi, un conseguente
aumento di peso.
Contrariamente, se il bilancio calorico è negativo, quindi state
assumendo meno calorie di quelle bruciate, l’organismo compensa
ricavando energia dai propri tessuti e, quindi, brucerà inizialmente il
tessuto adiposo e il tessuto magro successivamente, per sopperire
alla richiesta di calorie. Per rendere più comprensibile il concetto
possiamo fare un esempio pratico. Se volessimo perdere 1 kg in due
settimane, e questo kg perso fosse costituito principalmente da
tessuto adiposo (circa l’85%) e meno da tessuto magro, sarebbe
necessaria una riduzione di circa 7000 kcal in 15 giorni, pari a un
deficit calorico giornaliero di 500 kcal rispetto al proprio fabbisogno
calorico.
La restrizione calorica è molto studiata negli ultimi decenni perché
l’obesità e le malattie legate all’obesità, in gran parte derivanti
dall’urbanizzazione e dai cambiamenti comportamentali, sono ora di
importanza globale. Inoltre, si è scoperto che una ridotta assunzione
di calorie giornaliere, specie se a intermittenza, alternata cioè a
giorni di bilancio calorico positivo, innesca una serie di eventi
complessi ma protettivi, tra cui l’attivazione di elementi di risposta
allo stress, l’attivazione del sistema immunitario e l’equilibrio
ormonale. Tutto questo perché «obbligare» il corpo a utilizzare le
proprie masse per sopperire alle richieste energetiche fa sì che il
corpo stesso attui una serie di adattamenti utilizzando i tessuti che
meno gli servono come fonte di energia, ovvero il tessuto adiposo, e
concentrandosi a mantenere e migliorare il funzionamento dei tessuti
«utili», cioè la massa muscolare, la massa ossea e gli organi. Ma,
durante una restrizione calorica, l’organismo utilizza principalmente
un tipo di tessuto adiposo piuttosto che un altro. Infatti, l’organismo è
costituito da due tipi di grasso:
il grasso sottocutaneo, localizzato tra la pelle e il muscolo
sottostante, principalmente sugli arti, sui fianchi e sui muscoli
addominali, tipico delle donne e dell’obesità ginoide, «a pera»;
il grasso viscerale, chiamato anche intra-addominale, perché
situato al di sotto dei muscoli addominali, nello spazio tra gli
organi interni come fegato, intestino e reni, tipico degli uomini o
delle donne in post-menopausa e dell’obesità androide, anche
chiamata «a mela».
Quest’ultimo, a differenza del primo, sembra essere il tipo di grasso
più pericoloso per la salute perché il più attivo, in quanto produce
una serie di ormoni che interagiscono con gli organi limitrofi. È infatti
più connesso con il rischio cardiovascolare, l’insulino-resistenza, il
diabete di tipo 2, varie complicanze metaboliche e l’arteriosclerosi. È
tuttavia più sensibile alla lipolisi, cioè al processo metabolico che
prevede il catabolismo o la mobilizzazione dei grassi depositati, ed è
per questo che durante un ridotto apporto di calorie, per una dieta
ipocalorica, o un aumentato consumo di calorie per aumentata
attività fisica, è il primo a ridursi.
Per tutte queste ragioni il bilancio calorico tra calorie ingerite e
calorie consumate è necessario affinché il corpo si mantenga in
equilibrio tra i diversi compartimenti corporei (grasso sottocutaneo,
grasso viscerale e massa magra, quest’ultima composta da ossa,
organi, muscoli.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :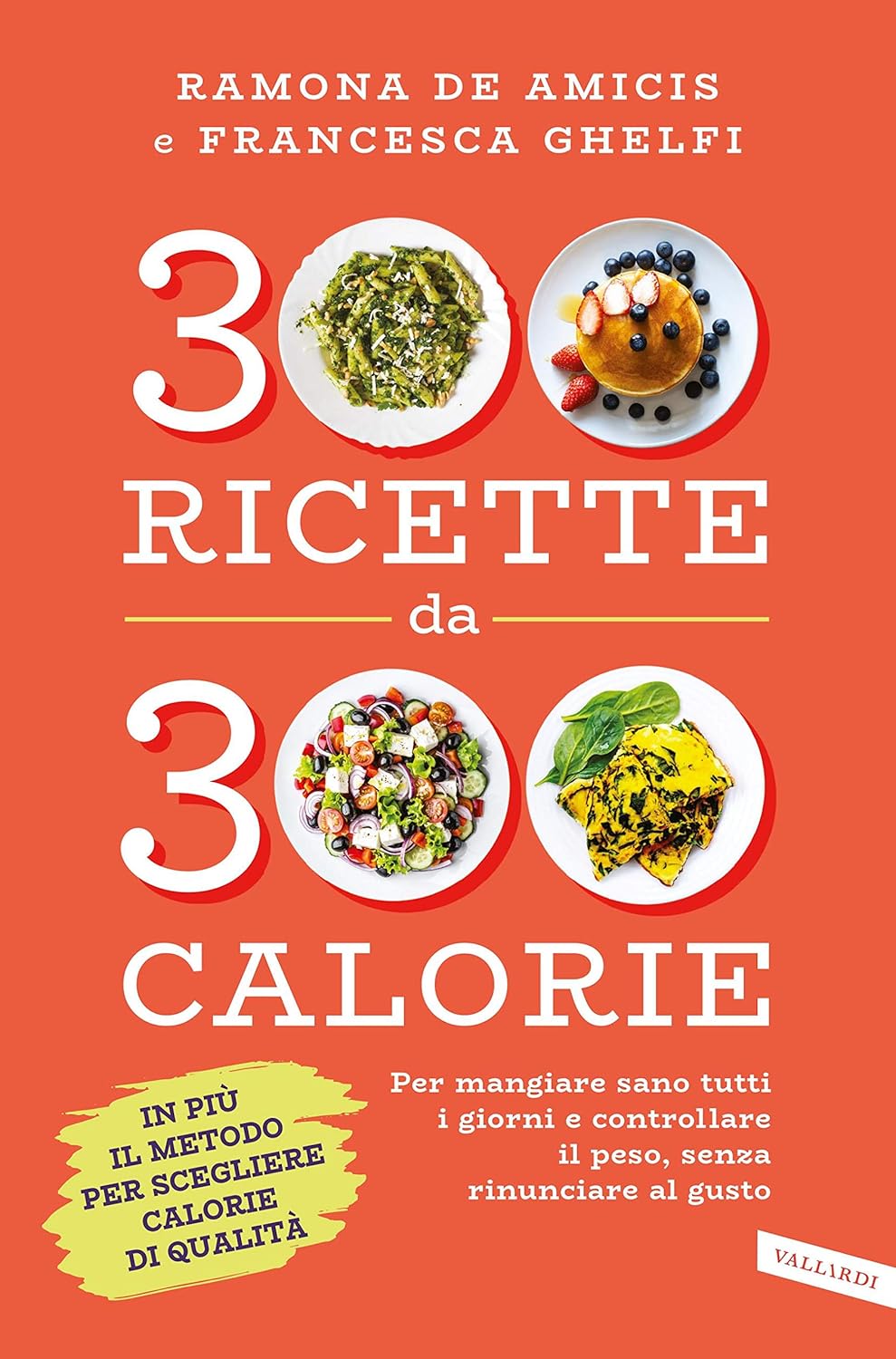




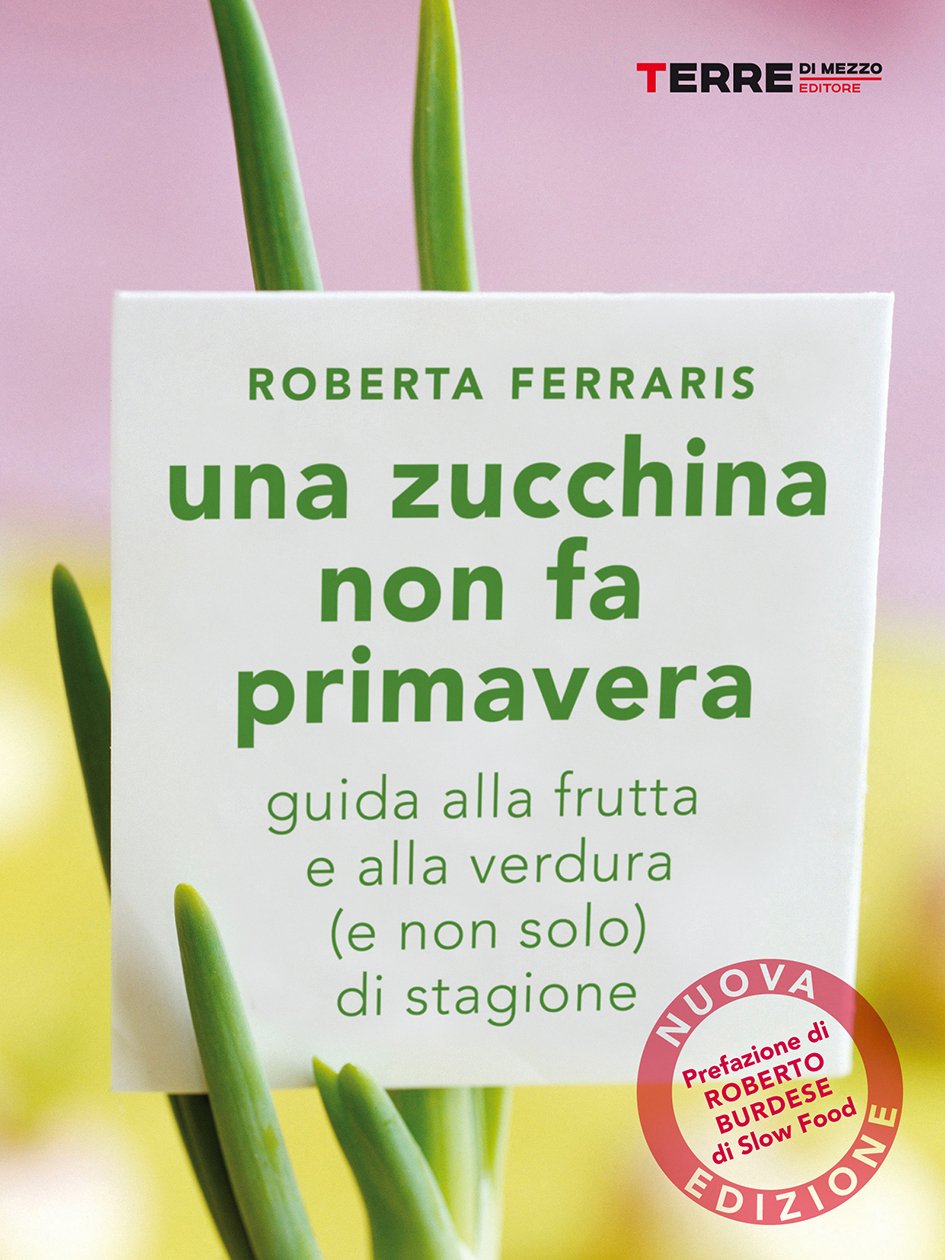
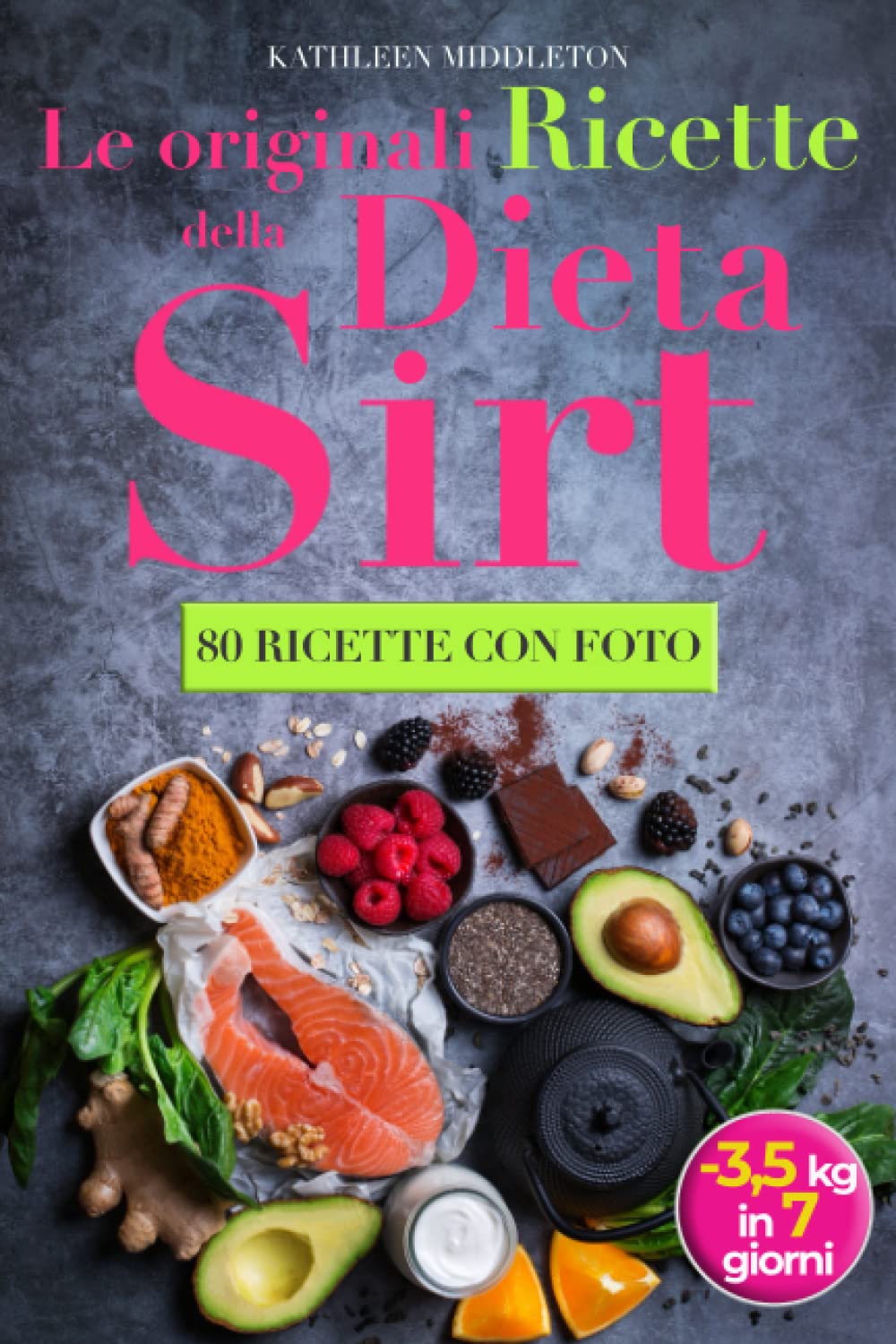
Commento all'articolo