La strategia della tensione. Servizi segreti, partiti, golpe falliti, terrore fascista, politica internazionale: un bilancio definitivo – Aldo Giannuli

SINTESI DEL LIBRO:
La difficile ricerca di un nuovo ordine mondiale
Le radici della strategia della tensione stanno nella «pace mancata» del 1945.
Spieghiamoci meglio: alla fine di ogni grande conflitto si stabilisce un ordine
mondiale destinato a durare per qualche tempo, dettato dai vincitori e subito dai
vinti; ad esempio, dopo la guerra dei Trent’anni ci fu la pace di Vestfalia che
inaugurò, appunto, l’ordine vestfalico i cui principi sono durati sino alla seconda
guerra mondiale, anche se si sono succedute diverse gerarchie nei rapporti di
forza nei cicli egemonici via via emersi.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale occorreva ricostruire l’ordine
mondiale tenendo conto di novità importanti emerse come quella dei «grandi
spazi» che rendeva insufficiente il principio della sovranità degli stati nazionali.
Ma, al contrario di quanto accade normalmente, la seconda guerra mondiale
terminò con dei vinti (Germania, Giappone, Italia) ma senza nessun vincitore
assoluto e c’erano ottime ragioni per cui i vincitori si considerassero
reciprocamente non meno nemici di quelli appena abbattuti. C’erano tutte le
ragioni per cui il conflitto appena concluso riprendesse fra i vincitori. L’unica
vera ragione che lo impediva era che, dopo una carneficina costata quasi 50
milioni di vite umane e distruzioni senza precedenti, nessuno si sentiva in grado
di riprendere le ostilità. Neppure gli USA, che avevano avuto molte meno
vittime degli altri e non avevano subito la guerra sul proprio suolo, avrebbero
potuto fare una scelta del genere, vuoi per l’ostilità dell’opinione pubblica a una
simile prospettiva, vuoi per le ragioni economiche che imponevano la ricerca
vitale di mercati di sbocco in quel momento inesistenti. Ne seguì una sorta di
«pace armata», un equilibrio precario in attesa di uno sbocco definitivo. Il
«bipolarismo» di cui spesso si parla, come di una epoca sostanzialmente stabile
durata quasi mezzo secolo, fu, almeno sino al 1975, un equilibrio di fatto ma per
nulla riconosciuto come definitivo da nessuno dei suoi contendenti maggiori.
Una vulgata storica largamente condivisa indica nella conferenza di Jalta la
nascita del nuovo ordine basato sul bipolarismo dei due blocchi – quello
occidentale e liberoscambista e quello orientale e socialista – con i rispettivi
confini.
È un mito fra i più persistenti, ma che ha scarsa rispondenza nella realtà
storica e suggerisce una falsa immagine di «certezza» dei confini,
reciprocamente accettati; quel che impedisce di capire le reali dinamiche
politiche del tempo. 1
L’importanza della conferenza di Jalta è grandemente sovrastimata:
Nella storia delle conferenze diplomatiche di guerra, si tende di solito a considerare
come episodio centrale e risolutivo la Conferenza di Jalta, del gennaio-febbraio 1945.
Sebbene questo incontro abbia suscitato un maggiore interesse storiografico e
maggiori polemiche, esso deve l’alone di leggenda da cui è circondato, più alle
circostanze in cui esso si tenne, alla vigilia della fine della guerra, che alla sua
effettiva centralità rispetto ai problemi della creazione del sistema post-bellico. Da
tale punto di vista, la massa dei problemi affrontati a Teheran e il numero delle
decisioni adottate o anche solo adombrate, ma trasformate successivamente in
deliberazioni formali, è tale da consentire l’affermazione che il primo vertice dei tre
maggiori alleati di guerra fosse contemporaneamente anche il più importante. 2
In effetti, Jalta fu solo uno dei punti di passaggio di un percorso iniziato
dopo l’attacco nazista all’URSS (22 giugno 1941).
Alexander Werth 3 sostiene che la guerra fredda ha avuto un importante
precedente in una «prima guerra fredda», iniziata nel 1917 con l’accerchiamento
dell’URSS da parte di tutte le potenze occidentali. E tale situazione durò sin
quando l’attacco tedesco all’URSS non spinse gli inglesi a saldare con essa
un’alleanza contro il comune nemico.
Si pose così il problema del nuovo ordine mondiale dopo la fine della guerra
ed esso venne affrontato, per la prima volta, durante la conferenza di Mosca
(ottobre 1943), nella quale Churchill e Stalin abbozzarono i nuovi equilibri:
Mancando ogni suggerimento concreto dagli Stati Uniti, conclusero un accordo ove si
specificava – cosa abbastanza mostruosa – in percentuali il grado d’influenza che
ciascuno avrebbe avuto nei Balcani; l’influenza sovietica in Romania, Bulgaria e
Ungheria avrebbe raggiunto la cifra del 75-80%; la Gran Bretagna e la Russia si
sarebbero divise, a parità, la Jugoslavia, mentre la Grecia sarebbe stata posta
interamente sotto l’influenza britannica. 4
Gli inglesi perseguivano l’antico disegno di una pace basata sul
bilanciamento di poteri nel continente, e i russi aspiravano alla sicurezza da
attacchi esterni garantita da una cintura di paesi alleati. Si trattava, per entrambi,
di una visione tradizionale delle relazioni internazionali, basata su rispettive
zone di influenza politico-militare che gli Stati Uniti non condividevano.
Pochi mesi dopo, fra novembre e dicembre, si svolse la conferenza di
Teheran con la partecipazione, di Churchill, Stalin, e Roosevelt, l’incontro
internazionale più importante della guerra, durante il quale Roosevelt fece
qualche concessione all’idea di zone di influenza nei Balcani, ma solo in termini
molto contenuti e secondari.
Infatti, mentre per russi e inglesi la definizione delle rispettive zone di
controllo era il fondamento del nuovo ordine mondiale, per gli americani aveva
solo una funzione complementare per garantire la pace, mentre il ruolo più
importante era affidato alle Nazioni Unite.
Gli inglesi accettarono che i russi si espandessero in Europa orientale e la
fine dell’isolamento della Russia. In compenso, i sovietici resero manifesta la
loro intenzione di rinunciare alla rivoluzione mondiale, raccomandando al PCI e
al PCF di non tentare alcuna rivoluzione socialista 5 e dimostrandosi freddissimi
verso quei partiti comunisti – come gli jugoslavi, i greci e gli albanesi – che non
intendevano allinearsi a tali indicazioni.
La convergenza anglo-russa era destinata a scontrarsi con la visione dei
rapporti internazionali degli americani.
Nella prima metà del Novecento, la politica estera USA oscillò fra
l’isolazionismo e l’universalismo.
L’universalismo, tradizionalmente forte fra le classi colte della costa
orientale e i vertici finanziari di Wall Street, era egemone nel Dipartimento di
Stato.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
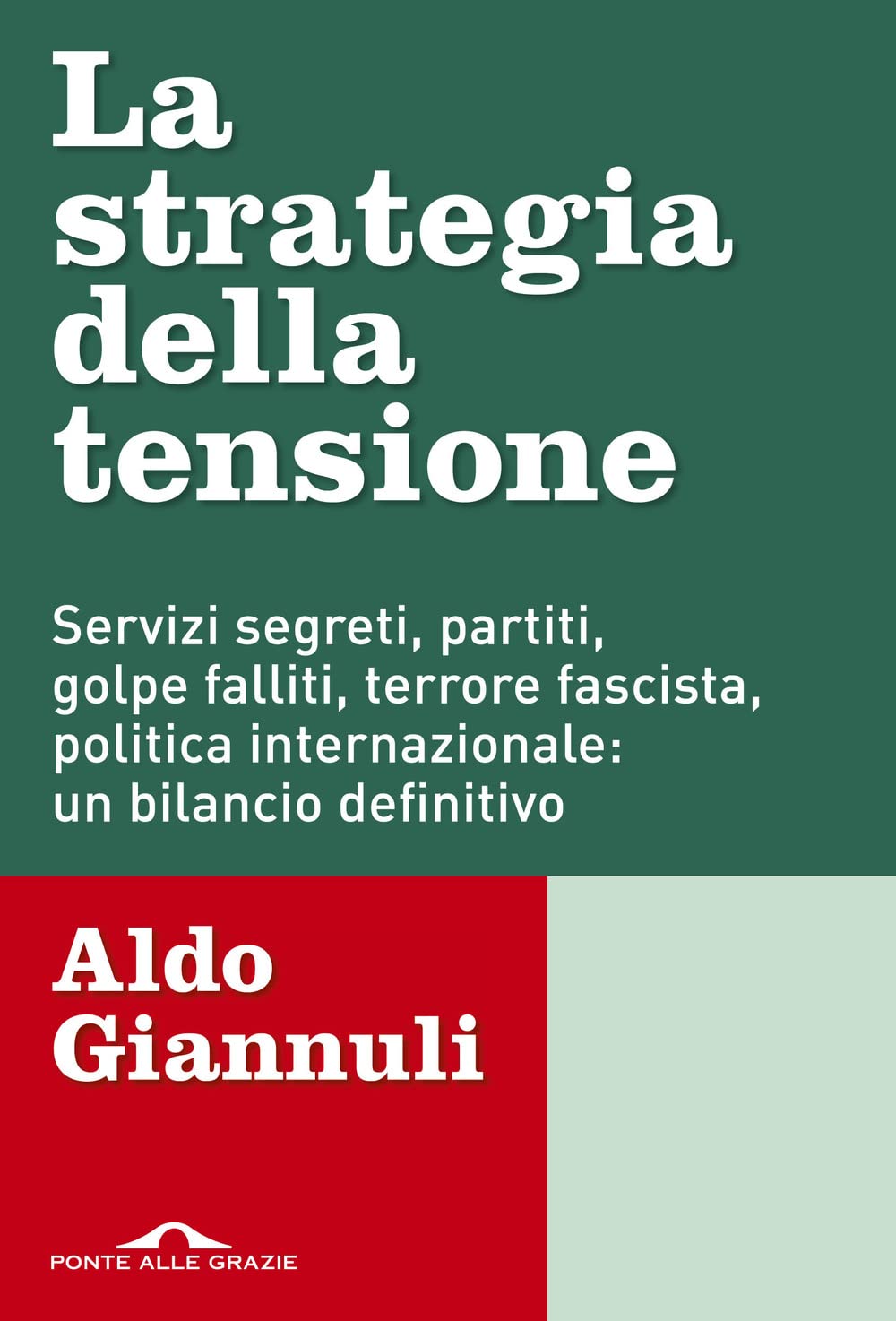






Commento all'articolo