Storia di un corpo – Daniel Pennac
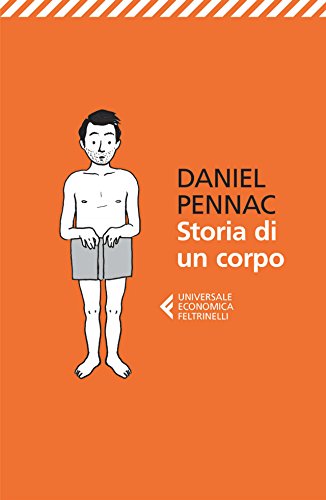
SINTESI DEL LIBRO:
Uno scherzo stupido fatto da Grégoire e dal suo amico Philippe alla
piccola Fanny mi ha ricordato la scena originaria di questo diario, il trauma
da cui è nato.
Mona, che adora fare piazza pulita, ha ordinato un grande falò di roba
vecchia risalente perlopiù all’epoca di Manès: sedie sbilenche, pagliericci
ammuffiti, un vecchio carretto, pneumatici fuori uso, in sostanza un
gigantesco e pestilenziale autodafé. (Il che, tutto sommato, è meno triste delle
cose messe in vendita sul marciapiede davanti a casa.) Ne ha affidato
l’incarico ai ragazzi, che hanno deciso di rimettere in scena il processo a
Giovanna d’Arco. Sono stato distolto dal mio lavoro dalle urla della piccola
Fanny, reclutata per fare la parte della santa. Per tutta la giornata Grégoire e
Philippe le hanno vantato i meriti di Giovanna, di cui Fanny, dall’alto dei
suoi sei anni, non aveva mai sentito parlare. Le hanno magnificato a tal punto
i pregi del paradiso che all’approssimarsi del sacrificio lei batteva le mani
saltando dalla gioia. Ma quando ha visto il rogo dove avevano intenzione di
gettarla viva è corsa da me urlando. (Mona, Lison e Marguerite erano uscite.)
Le sue manine si sono aggrappate a me come artigli terrorizzati. Nonno!
Nonno! Ho provato a consolarla con dei “su, su”, “è tutto finito”, dei “non è
niente” (altro che niente, era una cosa gravissima, ma non ero al corrente di
quel progetto di canonizzazione). L’ho presa sulle ginocchia e ho sentito che
era umida. Peggio, se l’era proprio fatta addosso, se l’era fatta sotto dal
terrore. Il cuore le batteva a un ritmo spaventoso, aveva il fiato corto.
Stringeva così forte le mandibole che temevo stesse per avere le convulsioni.
Le ho fatto un bagno caldo. E lì mi ha raccontato, a spizzichi, fra gli ultimi
singhiozzi, il destino che le avevano riservato quei due cretini.
E torno così alla creazione di questo diario. Settembre 1936. Ho dodici
anni, quasi tredici. Sono scout. Prima ero lupetto, con uno di quei nomi di
animali venuti di moda dopo il Libro della giungla. Adesso sono esploratore,
è importante, non sono più lupetto, non sono più piccolo, sono grande, sono
un grande. È la fine delle vacanze estive. Partecipo a un campo scout nelle
Alpi. Siamo in guerra con un altro gruppo che ci ha rubato il guidone, la
nostra bandiera. Dobbiamo andare a riprenderlo. La regola del gioco è
semplice. Ciascuno di noi porta il fazzolettone sulla schiena, infilato nella
cintura dei pantaloncini. Ciò vale anche per i nostri avversari. Quel fazzoletto
lo chiamiamo “la promessa”. Non solo dobbiamo tornare dall’incursione con
il nostro guidone, ma anche con il maggior numero di promesse. Le
chiamiamo anche scalpi, e li appendiamo alla cintura. Chi ne prende di più è
un guerriero temibile, è un “asso della caccia”, come quegli aviatori della
Grande Guerra che decoravano le carlinghe di croci tedesche man mano che
abbattevano aerei nemici. Insomma, giochiamo alla guerra. Siccome non
sono molto forte, perdo la promessa all’inizio delle ostilità. Sono caduto in
un’imboscata. Due nemici mi immobilizzano a terra, un terzo mi strappa via
la promessa. Mi legano a un albero perché non sia tentato di riprendere a
combattere. E mi lasciano lì. In mezzo al bosco. Attaccato a un pino la cui
resina mi si incolla alle gambe e alle braccia nude. I miei nemici se ne vanno.
Il fronte si allontana, a tratti sento qualche voce sempre più tenue, poi più
niente. Il grande silenzio dei boschi piomba sulla mia immaginazione. Quel
silenzio pieno di tutti i rumori possibili: gli scricchiolii, i fruscii, i sospiri, i
versi, il vento fra gli alberi... Penso che tra poco spunteranno le bestie,
disturbate dai nostri giochi. Non i lupi, ovvio, io sono grande, non credo più
ai lupi che mangiano gli uomini, no, non i lupi, ma magari i cinghiali. Che
cosa fa un cinghiale a un ragazzino legato a un albero? Probabilmente niente,
non se lo fila. Ma se è una femmina, accompagnata dai piccoli? Comunque
non ho paura. Mi limito a pormi gli interrogativi che sorgono in una
situazione in cui tutto è da scoprire. Più sforzi faccio per liberarmi, più la
corda si stringe e la resina mi si appiccica alla pelle. Chissà se si indurirà.
Una cosa è certa, non riuscirò a slegarmi, gli scout sono esperti nei nodi
inestricabili. Mi sento molto solo ma non penso che non mi ritroveranno più.
So che è un bosco frequentato, incontriamo spesso persone che vengono a
raccogliere mirtilli e lamponi. So che quando saranno concluse le ostilità
qualcuno verrà a liberarmi. Anche se i miei avversari mi abbandonano qui, la
mia pattuglia noterà la mia assenza, avvertiranno un adulto e sarò liberato.
Quindi non ho paura. Mi metto il cuore in pace. Il mio ragionamento domina
senza problemi tutto ciò che il contesto propone all’immaginazione. Una
formica mi sale sulla scarpa, poi sulla gamba nuda, e mi fa un po’ di
solletico. Questa formica solitaria non avrà ragione della mia ragione. In sé,
la reputo inoffensiva. Anche se mi pizzica, anche se mi entra nei
pantaloncini, poi nelle mutande, non è un dramma, saprò sopportare questo
dolore. Nei boschi capita di essere pizzicati dalle formiche, è un dolore
conosciuto, tollerabile, è pungente e passeggero. È questo il mio
atteggiamento, serenamente entomologico, finché lo sguardo non mi cade sul
formicaio vero e proprio, a due o tre metri dal mio albero, ai piedi di un altro
pino: un enorme tumulo di aghi di pino brulicante di una vita nera e feroce,
un mostruoso brulichio immobile. Quando vedo la seconda formica
arrampicarsi sul sandalo perdo il controllo della mia immaginazione. Adesso
il problema non è essere pizzicato, sarò coperto da quelle formiche, divorato
vivo. L’immaginazione non mi raffigura la cosa in dettaglio, non penso che le
formiche mi saliranno lungo le gambe, mi divoreranno il sesso e l’ano o si
introdurranno dentro di me attraverso le orbite, le orecchie, le narici, mi
mangeranno dall’interno avanzando dagli intestini e dalle altra cavità, non mi
vedo come un formicaio umano legato a quel pino e intento a vomitare dalla
bocca morta colonne di operaie che mi trasportano una briciola dopo l’altra
nel lo spaventoso stomaco brulicante su se stesso a tre metri da me, non mi
raffiguro questi supplizi, ma sono tutti nell’urlo di terrore che adesso caccio,
con gli occhi chiusi, la bocca immensa. È un grido di aiuto che deve coprire il
bosco, e il mondo al di là di esso, uno stridore che frantuma la voce in mille
aculei, e tutto il corpo urla con la voce del bambino che sono tornato a essere,
gli sfinteri urlano smisuratamente come la bocca, e me la faccio sulle gambe,
lo sento, ho i pantaloncini pieni, e la diarrea si mischia alla resina
amplificando il mio terrore perché l’odore, penso, l’odore ecciterà le
formiche, attirerà altri animali, e nelle grida di aiuto mi si sbriciolano i
polmoni, sono coperto di lacrime, di saliva, di moccio, di resina e di merda.
Eppure capisco che il formicaio non si cura di me, ma continua sordamente a
lavorare per conto proprio, a occuparsi delle sue svariate piccole incombenze,
e che a parte quelle due formiche vagabonde, le altre, che sono forse milioni,
mi ignorano completamente, lo vedo, lo sento, lo capisco anche, ma è troppo
tardi, lo spavento è più forte, ciò che si è impadronito di me non tiene più
conto della realtà, è tutto il mio corpo a esprimere il terrore di essere divorato
vivo, terrore originato solo dalla mia mente, senza la complicità delle
formiche, tutto questo confusamente lo so, certo, e più tardi quando il
reverendo Chapelier - si chiamava Chapelier - mi domanderà se credevo
davvero che le formiche mi avrebbero divorato, risponderò di no, e quando
mi dirà di confessare che era tutta una commedia, risponderò di sì, e quando
mi chiederà se mi sono divertito a terrorizzare con le mie urla i gitanti che poi
mi hanno slegato risponderò non lo so, e non ti sei vergognato di farti
riportare davanti ai compagni tutto scagazzato come un neonato, risponderò
di sì, tutte domande che mi fa lavandomi con la canna, togliendo il grosso
con la canna, senza nemmeno levarmi i vestiti, che sono un’uniforme, ti
rammento, l’uniforme degli scout, ti rammento, e ti sei domandato per un
attimo che cosa avrebbero pensato degli scout quei due gitanti? No, scusi, no,
non ci ho pensato. Ma dimmi la verità, quella commedia però ti ha divertito,
no? Non mentire, non dirmi che non ci hai preso gusto! Ci hai preso gusto,
vero? E non credo di aver saputo rispondere a questa domanda perché non
ero ancora entrato in questo diario che per tutta la vita successiva si
riproponeva di distinguere il corpo dalla mente, di proteggere d’ora in poi il
corpo dagli assalti dell’immaginazione, e l’immaginazione dalle
manifestazioni intempestive del corpo. E che cosa dirà tua madre? Hai
pensato a cosa dirà tua madre? No, no, non ho pensato alla mamma, e mentre
mi faceva questa domanda mi sono reso conto che l’unica persona che non
avevo chiamato mentre gridavo era la mamma, la mamma era l’unica che non
avevo chiamato.
Mi espulsero. La mamma venne a prendermi. L’indomani cominciai il
diario scrivendo: Non avrò più paura, non avrò più paura, non avrò più paura,
non avrò più paura, non avrò mai più paura.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo