Shantaram – G. David Roberts
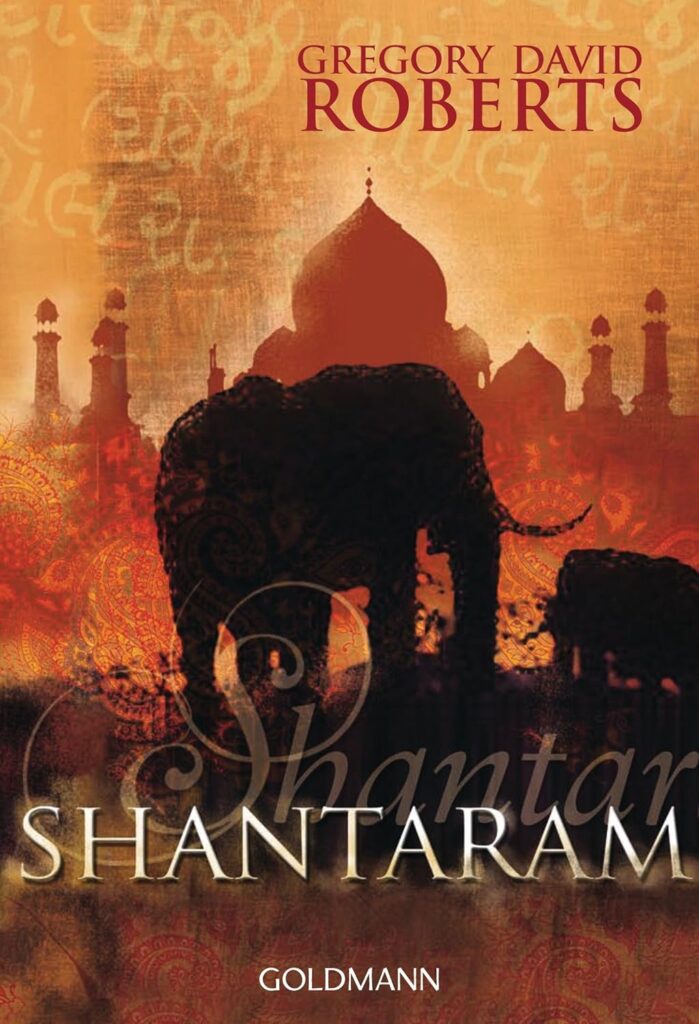
SINTESI DEL LIBRO:
Ho impiegato molto tempo e ho girato quasi tutto il mondo per
imparare quello che so dell'amore, del destino e delle scelte che si
fanno nella vita. Per capire l'essenziale, però, mi è bastato un istante,
mentre mi torturavano legato a un muro. Fra le urla silenziose che
mi squarciavano la mente riuscii a comprendere che nonostante i
ceppi e la devastazione del mio corpo ero ancora libero: libero di
odiare gli uomini che mi stavano torturando oppure di perdonarli.
Non sembra granché, me ne rendo conto. Ma quando non hai altro,
stretto da una catena che ti morde la carne, una libertà del genere
rappresenta un universo sconfinato di possibilità. E la scelta che fai,
odio o perdono, può diventare la storia della tua vita.
Nel mio caso è una lunga storia, con tanti personaggi. Sono stato
un rivoluzionario che ha soffocato i propri ideali nell'eroina, un
filosofo che ha smarrito l'integrità nel crimine, un poeta che ha perso
l'anima in un carcere di massima sicurezza. Scappando di galera - ho
scavalcato il muro principale, fra due torrette di guardia armate di
mitragliatrici - sono diventato l'uomo più ricercato del mio paese. La
buona sorte mi ha tenuto compagnia per mezzo mondo, e mi ha
seguito fino in India. Sono entrato nella mafia di Bombay, ho fatto il
trafficante d'armi, il contrabbandiere, il falsario. Mi hanno messo in
catene in tre continenti, mi hanno preso a botte, bastonato, privato
del cibo. Sono andato in guerra. Sono fuggito sotto il fuoco nemico. E
sono sopravvissuto, mentre altri intorno a me morivano. Uomini
quasi sempre migliori di me. Uomini migliori le cui vite sono state
frantumate da un errore, spazzate via da un istante sbagliato d'odio,
amore o indifferenza. Li ho seppelliti, ed erano tanti. Troppi. Il
dolore delle loro storie e delle loro vite è entrato a far parte della mia
esistenza. Ma la mia storia non parte da quegli uomini, né dalla
mafia: inizia dal primo giorno a Bombay. Il destino ha calato la mia
carta in quella città. La fortuna ha distribuito le carte che mi hanno
portato a Karla Saaranen. E io ho cominciato a giocarla, quella mano,
fin dal primo momento in cui ho guardato i suoi occhi verdi.
Insomma, questa storia inizia come tante altre: una donna, una città
e un pizzico di fortuna.
La prima cosa che mi colpì di Bombay, il giorno del mio arrivo, fu
l'odore diverso dell'aria. Lo sentii ancor prima di vedere o udire
qualsiasi altra cosa dell'India, fin da quando percorsi il corridoio
ombelicale che collegava l'aereo all'aeroporto. Nel mio primo minuto
a Bombay quell'odore mi emozionò e mi riempì di gioia - ero appena
scappato di prigione, ed era come rinascere al mondo - ma al
momento non lo identificai, non ne ero in grado. Ora so che è il dolce
aroma impregnato di sudore della speranza, che è l'opposto dell'odio;
so che è l'aroma acre e soffocante dell'avidità, che è l'opposto
dell'amore. È l'aroma di dei, demoni, imperi e civiltà che risorgono e
decadono. È l'azzurro aroma di pelle del mare, onnipresente
nell'Island City, ed è l'aroma di sangue e metallo delle macchine.
Fiuti il trambusto, il sonno e i rifiuti di sessanta milioni di animali, in
gran parte topi ed esseri umani. Fiuti lo struggimento, la lotta per la
vita, i fallimenti cruciali e gli amori che creano il nostro coraggio.
Fiuti diecimila ristoranti, cinquemila templi, chiese e moschee,
fiuti un centinaio di bazar dove si vendono profumi, spezie, incenso,
fiori appena colti. Karla un giorno lo chiamò il peggiore buon
profumo al mondo. Aveva ragione, naturalmente. Karla aveva un
modo tutto suo di avere ragione sulle cose. Oggi quando torno a
Bombay è quella prima sensazione della città - l'odore, innanzitutto -
a darmi il benvenuto, a dirmi che sono tornato a casa.
L'altra cosa che mi colpì fu il calore. Bastarono cinque minuti di
coda lontano dall'aria condizionata dell'aereo e i vestiti mi si
appiccicarono alla pelle, zuppi di sudore. Il cuore mi batteva forte per
il gran caldo. Ogni respiro era una piccola vittoria rabbiosa. Più tardi
capii che quel sudore da giungla non cessa mai, perché l'afa dura
notte e giorno. L'umidità soffocante di Bombay trasforma tutti in
anfibi che respirano acqua nell'aria; impari a conviverci: ti piace o te
ne vai. È la gente. Gente dell'Assalii, jat e panjabi; gente del
Rajasthan, del Bengala e del Tamil Nadu; gente da Pushkar, Cochin e
Konarak; caste guerriere, bramini e intoccabili; hindu, musulmani,
cristiani, buddhisti, parsi, jain, animisti; pelli chiare e scure, occhi
verdi, dorati, bruni e neri; le forme e i volti diversi di quel bizzarro
assortimento, di quell'incomparabile bellezza che è l'India.
E ora c'era un nuovo arrivato nella moltitudine di Bombay. I
migliori amici del contrabbandiere sono il "mulo" e il "cammello". I
muli superano le ispezioni alla frontiera per conto del
contrabbandiere. I cammelli sono i turisti inconsapevoli, che il
contrabbandiere sfrutta per passare la frontiera. Quando usano
passaporti e carte d'identità false i contrabbandieri si camuffano
mescolandosi ai compagni di viaggio - i cammelli - che ignari li
portano al sicuro, senza dare nell'occhio, attraverso aeroporti e
dogane.
A quei tempi non sapevo nulla di tutto ciò. Imparai l'arte del
contrabbando molto più tardi, anni dopo. In quel primo viaggio in
India ero guidato dall'istinto, e l'unico bene che contrabbandavo era
la mia persona, la mia fragile e perseguitata libertà. Usavo un falso
passaporto neozelandese; avevo sostituito io la foto sul documento, e
non era un lavoro perfetto. Ero sicuro che sarebbe bastato a superare
un controllo di routine, ma sapevo che se qualcuno si fosse
insospettito e avesse fatto verifiche in Nuova Zelanda il trucco
sarebbe stato scoperto in un batter d'occhio.
Durante il viaggio da Auckland all'India, girando per l'aereo in
cerca del gruppo giusto di neozelandesi, scovai una piccola comitiva
di studenti al loro secondo viaggio nel Subcontinente. L'incitai a
raccontarmi le loro esperienze e chiesi qualche dritta per il viaggio,
incoraggiai una vaga amicizia e feci in modo di rimanere accanto a
loro durante i controlli all'aeroporto. I vari funzionari indiani
pensarono che facessi parte di quella comitiva rilassata e innocua, e
mi degnarono soltanto di un controllo distratto.
Mi feci largo fra la folla. Fuori dall'aeroporto il sole picchiava
forte. Ero inebriato dall'euforia della fuga: un altro muro scavalcato,
un'altra frontiera superata, un altro giorno e un'altra notte per
scappare e nascondersi. Ero evaso quasi due anni prima, ma quando
sei un fuggiasco impari che devi continuare a scappare, notte e
giorno. E anche se non ero del tutto libero - in fuga non si è mai del
tutto liberi - ogni novità portava speranza ed eccitazione: un nuovo
passaporto, un nuovo paese, nuove rughe di spavento ed emozione
sul mio giovane volto, sotto gli occhi grigi.
Rimasi sul marciapiede, sotto la cupola azzurra e arroventata del
cielo di Bombay, il cuore terso e avido di promesse come una mattina
di monsone nei giardini di Malabar.
«Signore! Signore!» sbraitò qualcuno alle mie spalle. Una mano
mi strinse il braccio. Mi fermai. Tesi ogni muscolo, pronto a lottare, e
controllai la paura. "Non scappare. Niente panico". Mi voltai.
Davanti a me c'era un ometto. Indossava una sudicia divisa marrone
e aveva in mano la mia chitarra. Più che piccolo era minuscolo: un
nanetto dalla testa grossa, sul volto l'espressione di allarmata
innocenza tipica della sindrome di Down.
«La tua musica, signore. Stavi perdendo la tua musica, giusto?»
Era davvero la mia chitarra, dovevo averla dimenticata accanto al
nastro che trasporta i bagagli. Non riuscii a capire come quell'ometto
facesse a sapere che era mia. Sorpreso e sollevato sorrisi, e lui mi
ricambiò con la perfetta sincerità che noi, poiché la temiamo,
definiamo ingenuità. Mi passò la chitarra, e notai che aveva le mani
palmate come le zampe di un uccello acquatico. Estrassi qualche
banconota dalla tasca e gliele offrii, ma lui indietreggiò impacciato.
«Niente soldi. Siamo qui per aiutare, signore. Benvenuto in
India», disse, e scomparve a passetti rapidi nella foresta di corpi sul
marciapiede. Comprai un biglietto per il centro con il Veterans' Bus
Service, gestito da militari in congedo dell'esercito indiano.
Osservai il mio zaino che veniva issato sul tetto di un bus e gettato
su una pila di bagagli con violenza precisa e incurante, e decisi di
tenere la chitarra con me. Presi posto sulla fila di sedili in fondo al
bus, dove mi raggiunsero due viaggiatori dai capelli lunghi. Il bus si
riempì rapidamente di indiani e stranieri, per lo più ragazzi che
viaggiavano nel modo meno costoso possibile.
Quando il bus fu quasi pieno, l'autista si voltò sul sedile, ci
squadrò minaccioso, schizzò un vivido getto di succo di betel dalla
portiera aperta e annunciò la partenza imminente. «Tin hai, chalo!»
Il motore ruggì, la marcia s'innestò con un gemito e un tonfo e
partimmo a una velocità preoccupante tra la folla di facchini e pedoni
che evitavano di pochi millimetri la nostra traiettoria arrancando,
scattando o scostandosi di lato. Il bigliettaio, ritto sul gradino più
basso del bus, li malediva con studiata animosità.
Il viaggio dall'aeroporto alla città iniziò su un'autostrada ampia e
moderna, fiancheggiata da alberi e cespugli. Assomigliava al
paesaggio ordinato e razionale intorno all'aeroporto di Melbourne, la
mia città natale. L'ingannevole familiarità mi diede una sensazione di
compiaciuta tranquillità, ma poi la strada si strinse e il contrasto fu
talmente violento da sembrare quasi un effetto calcolato. Le molte
corsie dell'autostrada si ridussero a una sola, gli alberi scomparvero,
e la prima apparizione degli slum mi strinse il cuore in una morsa di
vergogna.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :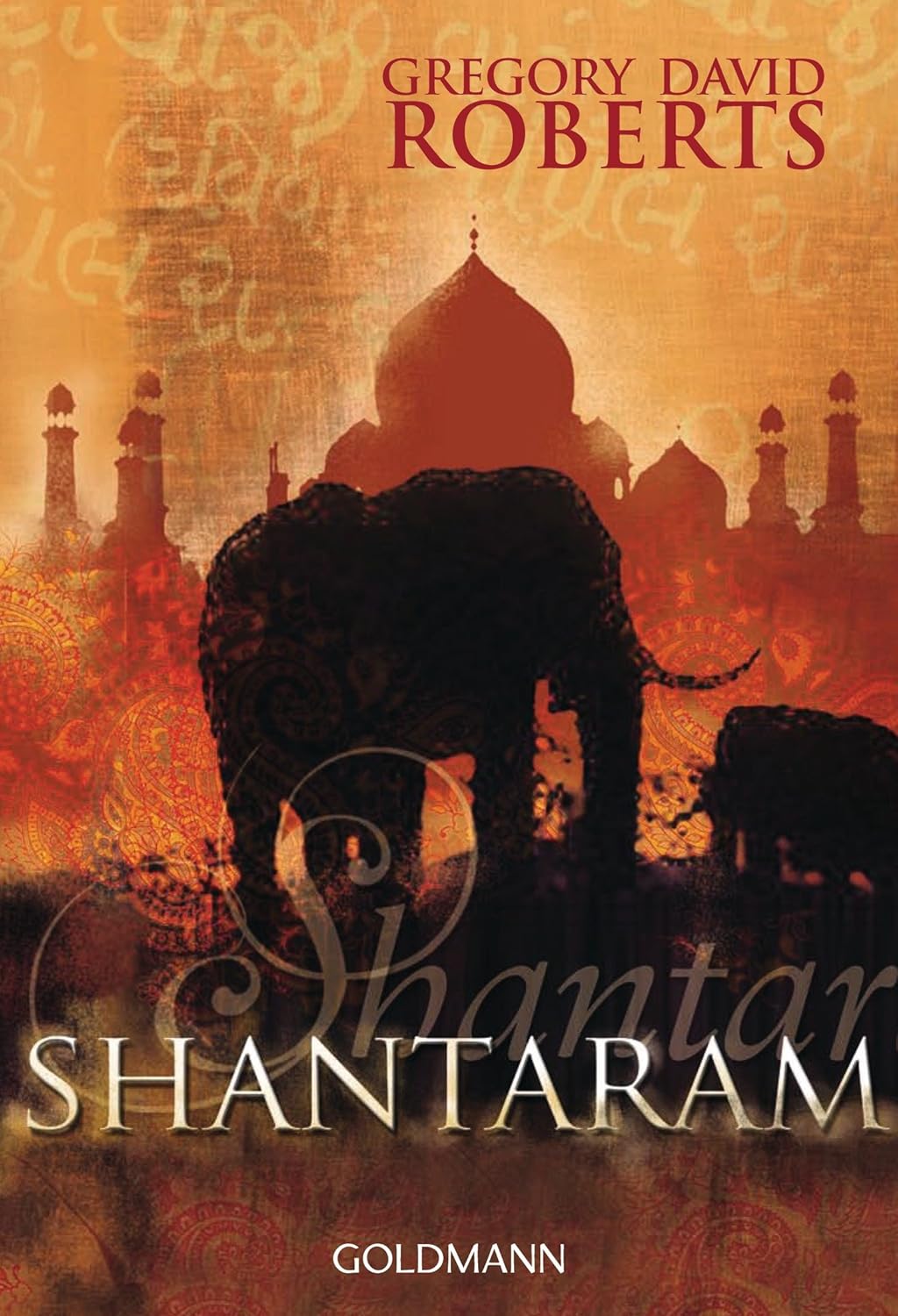






Commento all'articolo