Racconti dell’errore – Alberto Asor Rosa
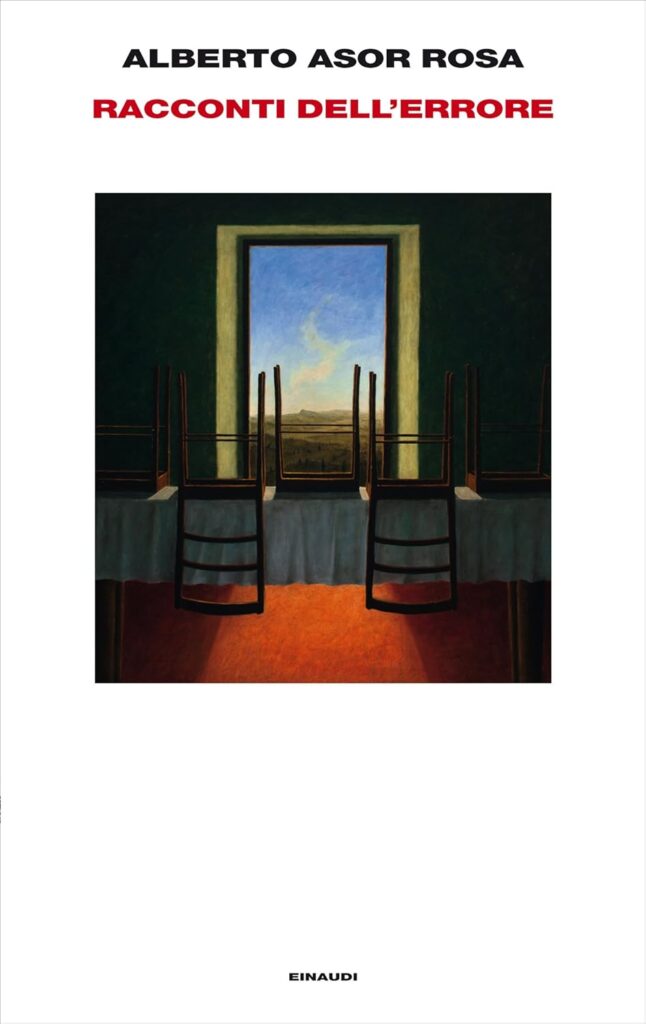
SINTESI DEL LIBRO:
Esiste una vita che si può definire impenetrabile alle influenze esterne?
Forse si. Basta cercarla in quelle esistenze fondate sull'errore, inteso come
allontanamento sistematico dalle regole della società o della natura.
Aristide pensa di dover morire in ogni istante della sua vita, e ha pianificato
la sua intera esistenza intorno a uno di questi potenziali momenti fatali.
Tonino invece non crede che invecchierà mai, fino a che un incontro casuale
gli restituisce il peso di tutti gli anni che ha sulle spalle. Tommaso non
immaginava che l'amore esistesse al di fuori dei libri: la poesia greca sarà lo
strumento per recitare in pubblico i suoi sentimenti...
Anche le vite tenute in scacco dalla paura, o rese incolori da un'indifferenza
che sembra inestirpabile, all'improvviso possono venire illuminate dalla più
elementare - eppure più difficile - delle epifanie: scoprire che si può o si deve
morire aumenta la carica degli affetti, li rende assoluti.
Sei ritratti di «uomini non illustri» che sono, da un lato, apologhi sui grandi e
piccoli addii che costellano le nostre esistenze e, dall'altro, struggenti storie
d'amore. Con una scrittura elegante e ironica - e uno sguardo sempre vigile
sui destini dei suoi personaggi - Alberto Asor Rosa compone un prezioso
apprendistato all'arte del congedo.
In sopracoperta: Mario Fani, Convivio, olio e acrilico su tela, 2012,
particolare. (Foto Alessandro Ferrini).
© 2013 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino www.einaudi.it
ISBN 978-88-06-21632-0
Alberto Asor Rosa
Racconti dell'errore
Einaudi
Racconti dell'errore
a Umana
Epifanie
L'attesa
Aristide Galeoto, siciliano di lontana origine spagnola (sicché in lui si
combinavano le due nature più cupe e riflessive d'Europa), sapeva da sempre
(forse da certi, apparentemente incomprensibili, tremori dell'infanzia, di
sicuro dall'adolescenza: quattordici-quindici anni, quando gli era riuscito per
la prima volta di vedersi e contemplarsi dall'esterno, quasi fosse un estraneo,
- il momento, per lui come per tutti gli altri, in cui si comincia a capire di che
pasta si è fatti, e dove si è destinati ad arrivare, e come), sapeva di dover
morire, anzi, come lui stesso preferiva più semplicemente spiegare, di morire.
Bella forza, direte voi, che c'è di strano? Tutti lo sanno. No. No. No! A parte
il fatto che molti se lo dimenticano, - se ci pensassero seriamente anche una
sola volta, ne proverebbero un tale spavento che sarebbero già morti, - per lui
era diverso. Aristide, infatti, era convinto in ogni momento della sua vita che
non sarebbe arrivato, che non sarebbe potuto arrivare a quello successivo.
Capite? Lui non smetteva mai di pensare che la sua vita fosse sul punto di
finire: che anzi, nell'istante stesso in cui lo pensava, essa stesse finendo,
avesse cominciato a finire, fosse, inequivocabilmente e irrimediabilmente, già
finita.
Si svegliava la mattina presto, dopo un sonno pieno di incubi, in cui non
aveva fatto che sognare di stare per morire, apriva gli occhi, fissava il soffitto
nella luce baluginante dell'alba, allungava la mano per premere il pulsante
della luce, ma, prima che questo accadesse, tutto quello che sapeva (ben poca
cosa, s'intende, rispetto alla sterminata infinità dello scibile, ma insomma pur
sempre qualcosa rispetto all'altrettanto illimitata infinità dell'umana
ignoranza, - insomma qualcosa, qualcosa che lui, e lui solo per giunta, aveva
faticosamente accumulato in anni e anni di esperienze e di impegni, di letture,
contatti, amicizie, conflitti, amori e dolori), svaniva di colpo nel nulla,
risucchiato da questo unico, lancinante pensiero: è inutile che tu perda tempo
a premere il pulsante, la luce, ammesso che tu riesca per un istante a farla
scaturire dal nulla, non ti servirà più, la fine è qui, è sul punto di arrivare,
ecco, è già arrivata, mentre tu ti affanni sterilmente a far luce intorno a te, -
del resto, una meccanica luce, luce senza prospettive né senso, che lui
comunque aborriva per la sua artificiale indifferenza alle cose, - nello stesso
istante la tua luce s'affievolisce e sparisce, la tua vita si spegne.
La fine non arrivava, quel momento di terrore passava, e Aristide Galeoto si
ritrovava con la mano tremante sul pulsante della luce, lo premeva, la luce,
indifferente come sempre a timori e affetti umani di ogni sorta, inondava la
stanza, e lui si ritrovava circondato da una moltitudine di oggetti consueti
sempre immobili ai loro posti (Aristide non toccava mai nulla di quel che,
magari per caso, si era ritrovato intorno da anni: si difendeva cosi dal terrore
della fine; per fermare il momento che sempre gli incombeva, aveva costruito
intorno a sé un universo immobile, fatto di tavoli, letti, sedie, poltrone, libri e
quadri, in cui non spostava mai nulla dall'originaria casella, non toglieva
neanche la polvere che, mese dopo mese, anno dopo anno, diligentemente vi
si depositava, per il timore che cambiare le cose anche in quella maniera
scontata e banale, non facesse che modificare a proprio disfavore l'ordine
universale, da cui tutto, anche la sua miserabile vita dipendeva); e infine,
dopo aver compiuto con enorme sforzo gli atti che sono necessari alla più
elementare sopravvivenza, - soffiarsi il naso, asciugarsi il sudore, cavarsi il
pigiama, infilare un paio di pantaloni, - si guardava intorno, sbalordito di
esserci ancora.
In quelle condizioni, come si può capire, tutto gli riusciva difficile e faticoso,
a cominciare (non è un gioco di parole) dalla banale sopravvivenza. Vivere,
infatti, - se un termine come questo può essere ragionevolmente usato anche
in un caso come il suo, - significava per lui passare di continuo dall'attesa
dell'una all'attesa dell'altra possibile scomparsa, insomma, dall'una all'altra
dissoluzione improvvisa, che lo avrebbe arrestato, e per sempre, mentre stava
sorbendo un caffè, nell'atto di cogliere un fiore, con il piede sul predellino di
un treno, oppure in attesa di un autobus che lo portasse lontano da tutta quella
sofferenza, in un luogo dove ne avrebbe incontrata un'altra più dura e
peggiore. Siccome Aristide sapeva (perché questo davvero tutti lo sanno) che
un giorno sarebbe morto, - cioè sapeva per certo che prima o poi sarebbe
inevitabilmente accaduto quel che lui pensava che gli sarebbe accaduto nel
momento stesso in cui formulava quel singolo, per lui ultimo pensiero, - non
poteva nemmeno trarre conforto dal pensiero che il suo terrore non avesse
alcun fondamento, che fosse il frutto di una mente esaltata o malata. Che
accadesse a tutti, ma proprio a tutti, anche a quelli che passavano l'intera vita
senza pensarci neanche una volta, era fuori discussione. Se morire fra
trent'anni o subito dopo, anzi, nell'istante stesso in cui stava pensando quel
pensiero, era il frutto di un mero calcolo di probabilità, peraltro insicuro e
incerto sul piano individuale (fra milioni e milioni di casi, come accertarsi di
non essere l'eccezione che conferma la regola?), tutto diventava possibile,
anzi probabile, - una vecchiezza illimitata come un arresto cardiaco
subitaneo, - non c'era alcun modo di saperlo con qualche certezza in anticipo.
Dunque, gira e rigira, sempre al punto di partenza Aristide ritornava: e se
fosse stato il momento dopo? e se fosse stato il momento stesso in cui,
pensandola, la cosa si sarebbe risolta ipso facto e istantaneamente certa, nella
sua versione per lui più reale, indiscussa e definitiva?
La sua vita prese perciò a funzionare come ancora, nonostante tutto,
funzionava il suo cuore: un seguito ininterrotto, - e precario, estremamente
precario, - di sistole e diastole: sto per morire; no, non sono morto; sto per
morire; no, non sono morto; sto per morire; no, non sono morto; e cosi via,
all'infinito (o, per meglio dire, fino al momento in cui il gioco si sarebbe rotto
e interrotto sul serio, e il suo cuore, la sua vita avrebbero cessato davvero di
funzionare).
A un certo punto, verso i vent'anni, stremato dall'attesa provò a cercar
sollievo in una qualche credenza soprannaturale, che gli desse ragione di quel
suo sincopato e incessante ritmo di assenze e presenze. Cominciò a
frequentare un giovane e cordiale frate francescano, allocato in un convento
non lontano da casa sua. Le conversazioni presero un ritmo regolare, Aristide
provò per il frate un sentimento di gratitudine, e persino di amicizia. Ma si
rese conto ben presto che le sue consolazioni e spiegazioni erano lontane,
lontanissime, le più lontane che si possa immaginare, dal nucleo vivente della
sua sofferenza. Il frate gli raccontava che c'era una spiegazione a tutto, e che
tutto, al tempo stesso, era nelle mani misericordiose di Dio: da cui, e da cui
solo, dipendeva se lui restava ancora in vita oppure se, come lui si augurava,
ben preparato mentalmente e spiritualmente, dovesse seduta stante far fagotto
e apprestarsi a partire. Mentre ascoltava quelle spiegazioni, Aristide si vide, -
fisicamente si vide, - seduto alla tavola sulla quale sua madre affettuosa e un
po' dolente (allora c'era ancora) gli preparava ogni giorno pasti inutilmente
saporosi e abbondanti: lui, Aristide, sotto gli occhi vigili e preoccupati di lei,
spezzava un pezzo di pane, si versava un bicchiere di vino, tirava a sé il piatto
fumante di pasta, - e, mentre l'una o l'altra di quelle azioni, normalissime,
abitudinarie, - non faceva che pensare: riuscirò a mettere in bocca il pane? ad
assaporare il vino? a infilare la forchetta nella pasta e a rigirarcela per più di
mezzo minuto onde confezionare il prezioso, indispensabile bolo alimentare?
Da nulla di quello che faceva per sostentarsi traeva godimento: solo i puri
gesti elementari che, a loro volta, gli consentissero di sopravvivere invece di
spirare o di inedia o di sete o d'insonnia. Al termine di ognuno di quei pasti,
- un po' troppo rapidi per non protrarre eccessivamente la sofferenza, un po'
troppo lenti per evitare che, morendo, gli finissero troppo presto, - Aristide
era esausto, privo di forze e, per fortuna sua, svuotato per un po' di pensieri
(ma siccome questo gli capitava in ogni più pallida e insignificante attività
quotidiana, - mangiare, dormire, coricarsi, svegliarsi, uscire di casa,
rientrarvi, conversare o tacere,
- non aveva requie, non aveva soste, era implacabilmente sempre e senza
pausa alcuna sotto il fuoco nemico). La sua sofferenza era quella,
circostanziata e concreta, fisica e mentale insieme. Come avrebbero potuto le
alate spiegazioni del giovane frate, - tutte improntate a un ottimistico, solare
disegno generale, generalissimo del mondo, e a un rimando di spiegazioni
tutte esterne e lontane, molto lontane, - distoglierlo dalla sua sofferenza?
Aristide si rassegnò a pensare che non c'era né spiegazione generale né
consolazione possibile, e che tutto si giocava, e sempre più si sarebbe
giocato, fra lui e la cosa misteriosa (lui non sapeva nemmeno quale nome
darle) che lo premeva da dentro. La fede funziona se uno ci si affida; ma se si
rifiuta l'affido, se ci si sente e si vuol restare soli, allora non c'è fede che
tenga, si può contare solo sulle proprie (limitatissime, precarie, transeunti)
forze personali. La gara, perciò, invece di placarsi e concludersi, continuò,
ingigantì, divenne permanente, sistematica: e Aristide fu costretto ad
apprendere come fare i conti con lei.
Quando aveva sei anni, Aristide si era trasferito con il padre e la madre da
Palermo in una grande, anzi grandissima città, nella quale il suo vizio
genetico aveva messo le radici e s'era, come dire, ancora meglio
acquartierato. Nel centro di quella disordinata megalopoli esiste un'altra
vecchia, molto più vecchia, anzi vecchissima città, nettamente distinta da
tutto il resto, fatta di vicoli, piazzette, strettoie, slarghi senza sbocco: il cielo
sta in alto, ma in nessun punto è possibile vederlo dispiegato e sereno.
Quando piove, sembra che il fango cada dall'alto invece di salire dal basso. E
tra una casa, o casetta, e l'altra non c'è soluzione di continuità: il sipario è
continuo, non dà adito alle vane speranze. Aristide, appena uscito dal reticolo
di strade nel cui seno era nato, crebbe da quel momento in poi nel puzzo di
merda dei vicoli senza uscita, delle fogne otturate, della sporcizia depositata
ovunque, e dell'accalcata e triste umanità, che gli viveva negligentemente
intorno. I giochi infantili nelle piazze, fra una miriade di ambulanti lerci e di
visitatori oziosi, non erano serviti a fargli vedere il lato positivo delle cose,
anzi gli avevano ispirato il senso di una gratuità che, senza volerlo,
conduceva sempre dalla stessa parte.
Perciò, crescendo, Aristide aveva fondato la sopravvivenza quotidiana sulla
propria personale insignificanza: gli sembrava che, quanto meno valeva, e
contava, tanto meno gli sarebbe importato di andarsene, tanto meno a
qualcuno, - compreso il suo destino che, noncurante di lui, ma sempre ben
presente, lo sovrastava, - sarebbe importato che se ne andasse. Perciò
relazioni ridotte al minimo; viaggi, nessuno; nessun interessamento estetico,
culturale, letterario (salvo qualche lettura rapinosa, fatta in fretta e furia, in
qualche raro intervallo della sua ossessione). Non parliamo della politica:
l'umano, inesausto, ciclopico azzuffarsi e affannarsi per governare altri e
farsene in qualche modo (un modo anche sparuto, insignificante, miserabile)
egemoni, - azzuffarsi e affannarsi che dalle sue parti raggiungevano in quegli
anni vertici difficilmente immaginabili altrove e in altri tempi, - gli sembrava
un esercizio folle, anzi insensato, alla luce inequivocabile ed eloquente delle
sue paure. Cosi, siccome vivere doveva, almeno fin quando il momento fatale
e cosi ostinatamente atteso non fosse sopraggiunto, Aristide si acconciò a una
vita in tono minore, rimodellata sull'inconfondibile fisionomia del suo credo
interiore. Di tutte le lezioni di storia che aveva ascoltato, una in modo
particolare l'aveva colpito per la sua spontanea saggezza. Di fronte ad una
forza enormemente superiore, molto meglio una tattica guerrigliera che una
linea Maginot, poderosa sulla carta, ma che qualsiasi agile armata avrebbe in
men che non si dica aggirato e reso impotente. Insomma: mai difendersi a piè
fermo, se c'è qualcuno più veloce e incomparabilmente più forte di te. Invece
di combattere l'istinto di morte, scelse di renderlo inoffensivo (inoffensivo il
più possibile, s'intende), non opponendo resistenza, anzi celandosi al nemico,
facendosi piccino, indifeso, al limite, quando meglio gli riusciva, invisibile.
Non poteva sperare, certo, che la paura smettesse di perseguitarlo: ma cercò
di attenuarne la potenza offensiva, riducendo la portata e il valore di ciò
contro cui essa era mossa: cioè, esattamente il sé medesimo di cui si trattava.
Aristide faceva questo a ragion veduta, per proteggersi dal nemico che lo
minacciava da dentro; ma questo è in effetti ciò che fa, senza saperlo né
volerlo, la grande maggioranza degli esseri umani: non per una paura
avvertita e comunque cosciente, come Aristide, ma per mediocrità,
insipienza, ignoranza, rilassatezza mentale e morale. Gli umani
s'accontentano di esserci, non gliene importa niente di essere qualcosa di
diverso, di più e di meglio. In un certo senso la paura, affondando Aristide,
che invece di qualità ne aveva da vendere, finiva per assimilarlo alla massa,
lo rendeva simile a tutti gli altri (anche se non lo era), lo faceva, appunto,
invisibile: che era quel che lui voleva.
Con il lavoro gli era andata abbastanza bene. Dopo studi mediocri e svogliati
(al solito: pur avendone tutte le possibilità, non gli riusciva d'impegnarsi e
faticare per qualcosa che un secondo più tardi avrebbe potuto non esserci
più), aveva trovato un impiego in banca, utilizzando qualche conoscenza del
padre, che era stato un potente alto funzionario dello Stato. Quando sedeva al
computer a compilare, un mese dopo l'altro, gli stipendi di impiegati e operai
della ditta Videt, manutenzione e riparazione grandi macchine, era preso
persino da qualche pausa di distrazione e di allontanamento dal suo incubo
perenne. Non gliene importava nulla del lavoro che faceva; sapeva che
chiunque altro al posto suo lo avrebbe fatto come e meglio di lui; se spingeva
lo sguardo un po' più in là del suo caso personale, - gli accadeva raramente,
ma qualche volta gli accadeva, - si rendeva conto che all'operaio Ficarra
Benvenuto, addetto da dieci anni allo smontaggio e al rimontaggio delle
scatole di cambio, non gliene importava assolutamente nulla neanche a lui
che a compilare il proprio cedolino stipendiale mensile fosse un tale di nome
Galeoto Aristide oppure un altro sconosciuto di identiche, ugualmente
anonime e indifferenti, caratteristiche umane, mentali e professionali. Fra i
suoi colleghi di lavoro, tutti più o meno, appunto, delle medesime
caratteristiche umane, mentali e professionali, avrebbe potuto pescare
conoscenze e persino amicizie se fosse stato interessato ad averne; ma
siccome, invece, lui le aborriva e sfuggiva come la peste, non ci fu nessuno
che si mostrasse interessato ad attirarlo in una forma qualsiasi di relazione.
Anzi, come accade in questi casi, fu presto evidente che quello strano tipo
che si limitava a battere intensamente e con continuità persino eccessiva i
tasti del proprio computer, chiuso nella sua stanza, e a mala pena salutava
chiunque incontrasse per i corridoi o in attesa come lui di fronte ad uno dei
cessi impiegatizi, non esclusi i superiori più ragguardevoli, era uno che
preferiva stare per conto suo e, per superbia o per timidezza (ci fu un breve
dibattito sulla possibile prevalenza di una di queste due ipotesi, presto reso
vano dall'assoluta mancanza di interesse a parteciparvi), scansava i contatti
con gli altri. Ne fu preso atto, e il caso fu rapidamente chiuso, e per sempre.
Aristide pendolava giorno dopo giorno dai vicoli intorno a casa sua alla bella
e rutilante sede bancaria in una delle vie più mondane della città, e, a parte il
versamento automatico che anche dello stipendio veniva da altri effettuato sul
suo conto corrente presso la medesima banca in cui lavorava, con quel mondo
eliminò ogni altro contatto, incorporandolo di fatto nel medesimo
meccanismo elementare che ogni giorno lo costringeva a mangiare qualcosa
almeno una volta, a dormire faticosamente qualche ora e a compiere altre
due-tre funzioni necessarie alla sopravvivenza, che non vale la pena di
nominare, perché tutti ovviamente sanno di che cosa si tratta.
Il catafratto sistema di sopravvivenza, che Aristide aveva a poco a poco
messo in piedi, urtava però anch'esso contro insormontabili ostacoli.
Sopravvivere non è vivere; e persino tra vivere ed esistere non c'è
coincidenza. Per giunta Aristide, mediocrizzato da tutte le proprie scelte di
sopravvivenza, restava però abbastanza intelligente da capire le diversità tra
questi diversi piani e fasi e alternanze del suo esserci in questa storia,
dimentico di sé il più possibile, certo, ma non fino al punto di dimenticarsene
del tutto. Anche se avesse voluto, non avrebbe potuto. Fatto sta che Aristide
era incline, fortemente incline, all'innamoramento: o meglio, a raccogliere il
messaggio di seduzione che gli proveniva spontaneamente e irresistibilmente
da un corpo femminile. Gli bastavano di solito una bella bocca, o due occhi
spiritosi e gentili, o un seno abbondante, o due gambe snelle e diritte, di
quelle che spuntano dall'orlo della gonna con il dinamismo corretto ed
elegante conferito loro da un meccanismo cerebrale perfetto (questo, per
intenderci, è uno dei casi esemplari in cui si dimostra che un bel fisico conta
poco se non c'è una buona mente a dargli la carica che ci vuole per diventare
davvero seducente), per accendersi immediatamente e tumultuosamente.
Come poteva accadergli tutto questo, se era impegnato tutto il tempo ad
auscultare le proprie pulsazioni, resecare rapporti, eliminare relazioni, farsi
solo e sempre più solo? Gli accadeva per caso, per la strada, nei bar, in
qualche negozio, nei supermercati dove si approvvigionava di cibo mediocre,
imbattendosi in sconosciute dalle quali lo separava ogni cosa, la classe
sociale, - talvolta molto più bassa ma talvolta anche molto più alta della sua, -
l'educazione, la mentalità e, ovviamente, le pulsioni più profonde (anche se
non è da escludere del tutto che alcune di quelle creature celassero qualcosa
di simile a ciò che scuoteva continuamente Aristide). E non bisogna credere
che nel contesto in cui lui abitualmente si muoveva tutto ciò apparisse o
diventasse più difficile che altrove: anzi, dalle donne di quel posto, - quello,
insomma, in cui lui non era nato ma bene o male viveva, - il messaggio che
Aristide lanciava con tutti i mezzi a propria disposizione, - occhi, bocca,
mimica facciale, postura del corpo, talvolta, quando la situazione sembrava
suggerirglielo, con qualche più esplicito, e in taluni casi indecente, richiamo,
- veniva raccolto e apprezzato con molta più intelligenza e disponibilità di
quanto sarebbe presumibilmente accaduto in un qualsiasi altro posto del
mondo (come mai? beh, su questo si potrebbe scrivere un libro, anzi un bel
libro, ma per ora ci limitiamo a prenderne atto). E il messaggio era questo:
vedere, desiderare, darsi da fare per possedere per lui era tutt'uno. Non aveva
né tempo né voglia né, soprattutto, spazi mentali disponibili per qualcosa di
preparatorio o d'intermedio. Il corteggiamento, insomma, gli dava noia:
troppo lungo a pensarsi, ancor più lungo a realizzarsi, inutile di fatto ai suoi
fini, perciò inevitabilmente da scartare. Se avesse avuto tempo e voglia,
sarebbe stato, come gli accadeva di essere in tante altre cose minori,
«comune». La pressione che lo spingeva cosi irresistibilmente in avanti era
invece in tutti i casi la stessa: Aristide doveva comunque tentare di sapere il
più presto e il più intensamente possibile ciò che lo aspettava, perché dopo
non ci sarebbe stato più tempo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :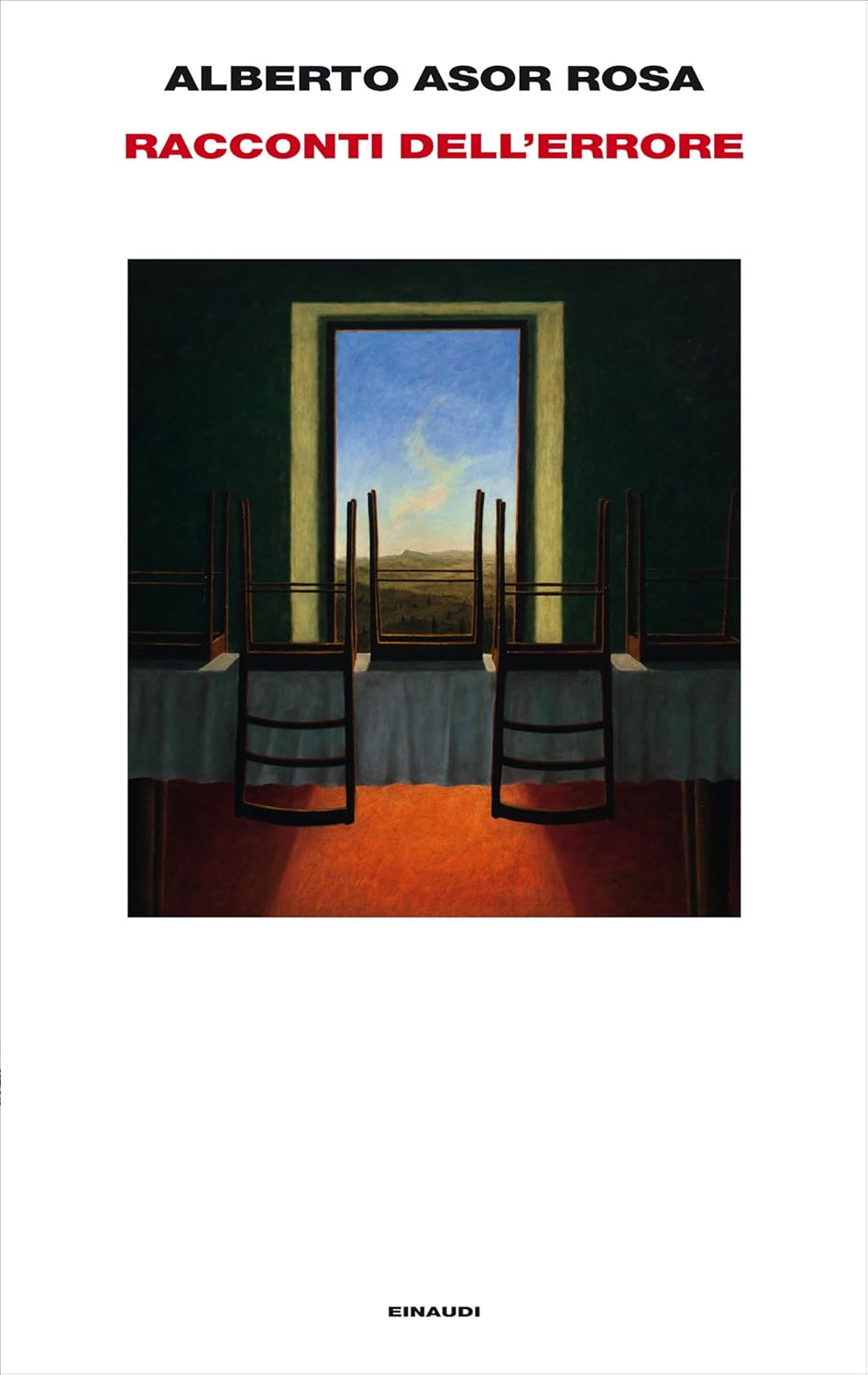






Commento all'articolo