Ninfa dormiente – Ilaria Tuti
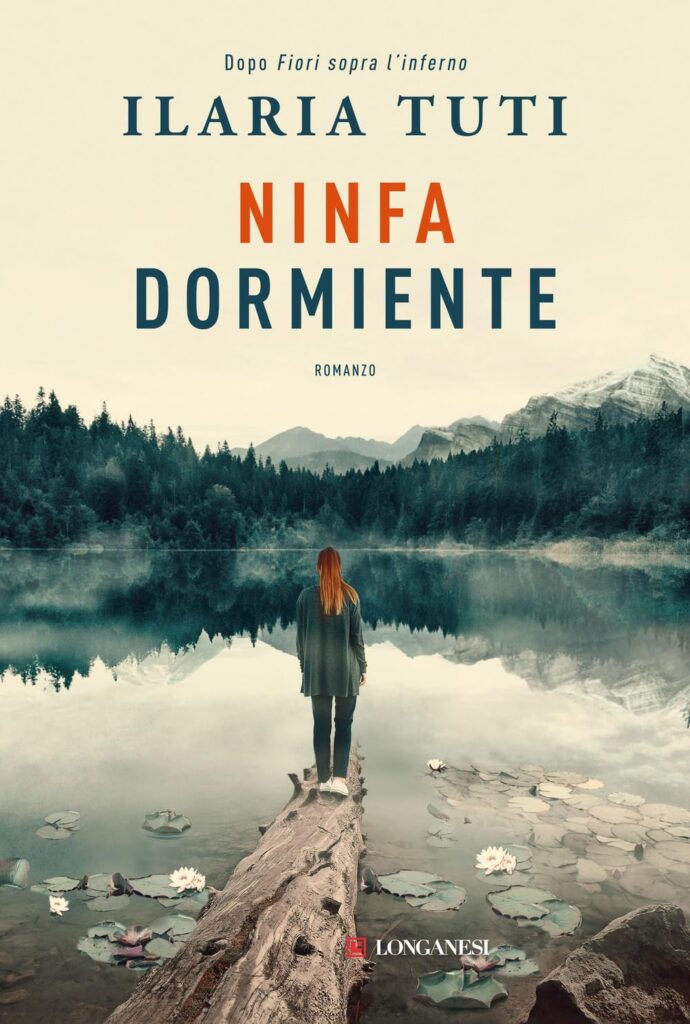
SINTESI DEL LIBRO:
Il sole scolpiva di taglio il viso di Massimo Marini e si
insinuava tra le ciglia, accendendo il castano di riflessi di
fiamma. I passi battevano nervosi la via circondata da
giardini segreti, nascosti agli occhi da mura cieche. I rami
più alti delle magnolie sfuggivano alla recinzione e
deponevano petali che crocchiavano carnosi sotto le suole.
Era come calpestare cose ancora vive, un tappeto di
creature morenti.
Il pomeriggio primaverile languiva placido, ma il nero
turbinoso al limite del campo visivo annunciava uno
stravolgimento. L’aria crepitava elettrica, contagiando
l’ispettore di irrequietezza.
La galleria d’arte La Cella era indicata da una targhetta
d’ottone affissa all’intonaco irregolare del palazzo
secentesco. Il riflesso degli occhi sul metallo era distorto
come il suo umore. Massimo srotolò le maniche della
camicia e indossò la giacca. Quando suonò il campanello,
un clic fece scattare la serratura del portone. Sospinse il
battente borchiato ed entrò.
Il tepore del giorno si arrestò sullo stipite. Oltre l’uscio,
un’ombra umida lo avvolse.
Il pavimento era a scacchi, nero e bianco, e uno scalone
di marmo marezzato saliva curvando al piano superiore. La
luce entrava dalle vetrate più alte e colpiva il lampadario in
vetro di Murano, liberando sfumature smeraldine che
digradavano verso la semioscurità del pianterreno. C’era
odore di gigli. A Massimo ricordava quello dell’incenso, una
chiesa buia, litanie interminabili e gli sguardi severi di suo
padre quando lui, bambino, mostrava insofferenza. Sentì le
tempie pulsare.
Nel silenzio di quel luogo composto, calato in una
dimensione rarefatta e marina, la vibrazione del cellulare
sembrò irrompere da un altro mondo.
Sfilò il telefono dalla tasca interna della giacca. Fremeva
nel palmo come un cuore artificiale piatto e freddo, eppure
Massimo sapeva che dall’altra parte della linea ce n’era
uno vero in cui amore e rabbia, delusione e dolore si
azzuffavano come bestie dal ventre vuoto e i denti scoperti.
Il suo sottrarsi le aveva rese fameliche. Il numero chiamava
con insistenza da alcune settimane, più volte al giorno.
Non rispose, un impasto ripugnante di rimorso e colpa a
riempirgli la bocca. Attese che la chiamata terminasse, poi
spense l’apparecchio. Girò attorno allo scalone e scese
veloce i gradini di ferro battuto che si svolgevano in spirali
di tralci d’edera fino al piano interrato. Un vocio attutito
saliva dalla semioscurità. Ancora un corridoio illuminato
debolmente da faretti pavimentali, ancora una porta di
cristallo zigrinato, poi la galleria.
La Cella, finalmente. Il soffitto a volte, di mattonelle
ruvide, guardava un pavimento lucido di ardesia. Gran
parte dell’intonaco era stata raschiata per rivelare la pietra
originale. Ogni macchia di luce cadeva su una delle opere
esposte, facendola emergere dalla penombra come un
gioiello. Sculture bronzee, vasi vitrei e quadri astratti dai
colori sgargianti erano i protagonisti di quel proscenio
minimale e sotterraneo.
L’ispettore seguì il mormorio e trovò un capannello di
persone nella stanza più ampia. Ai lati del locale
stazionavano due poliziotti in divisa. Poco oltre, in
borghese, riconobbe Parisi e De Carli. Il primo, scuro e
atletico, parlottava al cellulare. Il secondo, magro e
dinoccolato come un adolescente, lo guardava intervenendo
di tanto in tanto. Erano la sua squadra, da quando aveva
chiesto il trasferimento dalla grande città a un capoluogo di
provincia. Un cambio di rotta con cui aveva creduto –
sperato – di ritrovare la pace, un modo di ricominciare. In
realtà aveva trovato molto di più, ma la pace era rimasta
una chimera vomitante fiamme, che lo bruciava non appena
provava ad avvicinarsi.
Li raggiunse e si salutarono con un cenno.
«Di che si tratta?» chiese a De Carli.
Il collega si sistemò i jeans che gli pendevano dai fianchi.
«A saperlo. Non ci hanno detto ancora nulla. È un
mistero.»
«Allora perché mi hai chiamato con tanta urgenza?»
Parisi mise una mano davanti al microfono del cellulare e
accennò con il mento in direzione opposta.
«Perché lei ha bisogno di noi. E anche di te.»
Lo sguardo scattò in cerca della persona che, negli ultimi
mesi, aveva reso ogni suo istante un inferno e tuttavia,
proprio per questo, l’aveva riportato in vita.
Di lei vide per prima cosa i piedi, tra le gambe di due
agenti. Calzava un paio di sneakers con la suola rialzata.
Notò come spostasse il peso da una parte all’altra, il modo
in cui ogni tanto sollevava i talloni per dare sollievo alle
estremità.
È stanca, pensò. Pur ignorando il motivo che aveva
portato la squadra alla Cella, sapeva che lei sarebbe stata
l’ultima a uscire da lì dentro.
I poliziotti si spostarono e finalmente la vide, tra la
scultura in bronzo di un cuore per metà liquefatto e
un’installazione di ali di plexiglas che pendevano dal
soffitto. Cuore e anima, come lei.
E determinazione, una forza vitale che a volte sembrava
schiacciare chi aveva accanto, ma che invece all’ultimo
momento lo afferrava e lo sollevava per portarlo sulle sue
vette.
Certo, non mancava anche un bel po’ di stronzaggine.
A renderla consumata nell’aspetto non erano i quasi
sessant’anni, ma un tormento interiore che per Massimo
non aveva ancora un nome e che sembrava trovare riflesso
nel taccuino che lei stringeva sempre tra le mani. Appena
poteva, lo riempiva di frenetici appunti.
La raggiunse. Notò il battito di ciglia – nient’altro – con
cui lei registrò la sua presenza. Non si era nemmeno
voltata. Teneva la stanghetta degli occhiali da lettura tra le
labbra e masticava nervosa una caramella.
«Spero sia almeno senza zucchero» le disse.
Lei finalmente lo guardò, per non più di un secondo.
«Pensi davvero siano affari tuoi?»
La voce era roca, secca. In sottofondo, una nota di
divertimento.
«È diabetica, commissario. E dovrebbe essere anche una
signora...» mormorò, tralasciando l’imprecazione che seguì.
Era un gioco che conosceva bene e al quale non vinceva
quasi mai.
Lei smise di tormentare gli occhiali.
«Non è il tuo giorno libero, ispettore?» gli chiese,
puntandogli addosso quei maledetti occhi che vedevano fin
troppo oltre la superficie.
Massimo fece un mezzo sorriso.
«E lei non ha appena smontato dal turno?»
«Tanta solerzia non servirà a far passare inosservate le
tue recenti défaillance, Marini.»
Massimo non si avventurò nelle insidie di una replica.
Osservò con attenzione quella donna che sembrava già aver
perso interesse in lui. Non gli arrivava nemmeno al petto,
ma aveva l’abitudine di passare sopra il suo ego come un
carrarmato. Aveva quasi il doppio della sua età, ma lo
lasciava senza energie molto prima che a esaurirsi fosse lei.
Le sue maniere erano spesso brutali e il caschetto di capelli
che incorniciava il viso era di un rosso talmente artificioso
da essere quasi imbarazzante. Lo sarebbe stato su
chiunque, ma non su di lei.
Teresa Battaglia abbaiava, ma c’era chi giurava di averla
vista mordere, letteralmente.
«Allora, perché siamo qui? Perché tutti questi misteri?» le
chiese, per riportarla su un terreno in cui lei sembrava
correre più veloce degli altri: quello della caccia.
Teresa Battaglia guardava davanti a sé come se ci fosse
qualcuno, gli occhi assottigliati, foschi pensieri incarnati
tra le sopracciglia. Quando rispose, lui capì che stava
scrutando una vittima nella sua mente, viso a viso. Cuore a
cuore.
«Singolare, non plurale, ispettore. Il mistero è sempre e
soltanto uno.»
Il commissario Battaglia prese a pulire le lenti degli
occhiali da lettura, come sembrava fare ogni volta che
rifletteva. Si stava chiarendo i pensieri.
«Perché dovremmo essere qui, noi, se non per sciogliere
il mistero di una morte?»
2
«Morte antica.»
Così le aveva detto il sostituto procuratore Gardini,
neanche un’ora prima, quando le aveva chiesto di
presentarsi alla Cella. Solo quelle due parole, assieme a
una manciata di altre che il commissario Teresa Battaglia
ben conosceva: «Voglio te e la tua squadra».
Morte antica. Teresa si era sentita sollevata: non c’era un
assassino a piede libero a cui dare la caccia, altre vittime
da salvare e lo scorrere del tempo come avversario. Solo
l’eco di un evento lontano, riapparso chissà come dalla
polvere del passato.
Poteva gestirlo. Il caso non le sarebbe sfuggito di mano, e
se anche fosse successo, non ne avrebbe sofferto nessuno,
solo il suo amor proprio.
Sei una sciocca se pensi che non si accorgeranno di
quello che ti sta accadendo.
Quello che le stava accadendo aveva un nome che poteva
annichilire e rendere il futuro uno schermo nero, ma Teresa
non era mai arretrata davanti alla parola scritta sul referto,
non le aveva concesso spazio per invadere il proprio
mondo. La custodiva dove si annidano le paure più
terrificanti: in fondo all’anima, e in un diario che stringeva
anche in quel momento tra le mani. La sua memoria di
carta.
In quel quadro già complicato, Massimo Marini
rappresentava un ulteriore problema. La scrutava come se
avesse fiutato qualcosa, come se potesse accedere ai suoi
pensieri. Faticava a tenerlo a distanza. Al contrario, la sua
vicinanza cominciava a sembrarle normale. Temeva che
diventasse una pericolosa abitudine per entrambi, quella di
cercare la compagnia dell’altro.
Da una stanza a cui era vietato l’accesso uscì il sostituto
procuratore Gardini. Sembrava agitato, come ogni volta
che Teresa lo incontrava. Alto e magro, Gardini era sempre
spettinato e con la cravatta fuori posto, quasi fosse stato
appena investito da una folata di vento. Era un magistrato
in gamba, che non si dava tregua. Il suo aspetto sembrava
suggerire la fretta con cui viveva, le mille cose che si
riprometteva di fare e gli infiniti contrattempi che, invece,
gli scombinavano l’esistenza.
Lo accompagnava un uomo dall’aspetto eccentrico e
l’abbronzatura marcata. I capelli castani, schiariti dal sole
ai lati, fecero dedurre a Teresa che anche il colorito della
pelle fosse naturale, di chi pratica sport all’aperto.
Qualcosa di elegante, comunque, di esclusivo come gli abiti
che indossava, dal taglio classico e i colori sgargianti.
Estrosi ma di gran gusto.
Teresa immaginava chi fosse. Aprì veloce il diario e cercò
le ultime annotazioni, ma non vi trovò la descrizione di
quell’uomo. Ricordava bene: non si conoscevano ancora.
Non appena la vide, Gardini le andò incontro con la mano
tesa. Erano amici di lunga data, ma sul lavoro le posizioni
restavano separate.
«Commissario, grazie per essere venuta. So che l’ho
disturbata alla fine del turno» la salutò, dandole del lei. «Le
presento Gianmaria Gortan, il proprietario della galleria.
Signor Gortan, il commissario Battaglia. Intendo affidare a
lei le indagini.»
Teresa accennò un sorriso breve, poi riportò l’equilibrio
che spesso Gardini per la fretta trascurava.
«Il mio braccio destro, l’ispettore Marini» disse.
Le mani si strinsero. Quella del mercante d’arte, notò lei,
era sudata. Una piccola perdita di controllo che stonava
con l’immagine patinata che offriva di sé.
«È stato il signor Gortan a chiamarci» stava dicendo
Gardini. «Si tratta di un caso particolare.»
Non le aveva anticipato nulla, ma Teresa aveva trascorso
gli ultimi minuti nella galleria d’arte osservando gli uomini
della scientifica andare e venire dalla stanza che ancora
non aveva visitato. La reflex del fotorilevatore scattava
senza sosta, potenti flash saettavano nella penombra. Se la
morte era antica, qualcosa non tornava, pensò Teresa. Il
dispiegamento di mezzi e personale non era coerente con il
quadro che si era fatta arrivando. Le morti impolverate
interessano a pochi. Con il sangue si asciuga anche
l’empatia verso la vittima e la famiglia che la piange. In
questi casi la Giustizia non ha fretta di puntare la spada. I
piatti della bilancia restano sospesi e la benda sugli occhi si
allenta quanto basta per guardarsi attorno e spronare i
segugi migliori a seguire tragedie più fresche.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






Commento all'articolo