L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica – Walter Benjamin
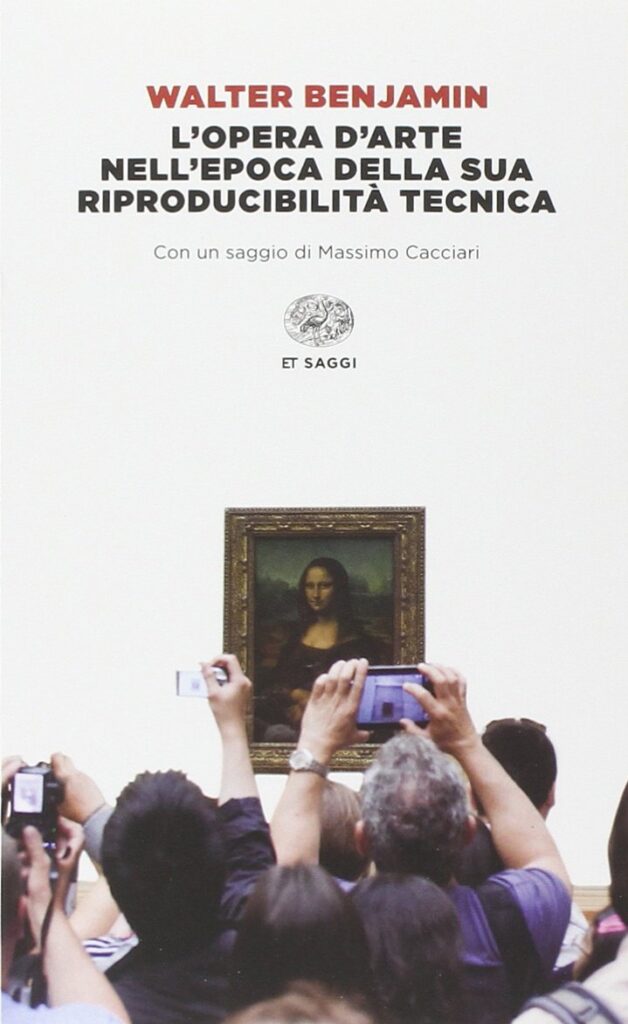
SINTESI DEL LIBRO:
Il primo paradosso che dovrebbe considerare il lettore
accingendosi alla lettura o alla rilettura del saggio più
celebre di Walter Benjamin L’opera d’arte nell’epoca della
sua riproducibilità tecnica (quasi certamente il testo
filosofico novecentesco più letto e citato, ben oltre la
cerchia degli specialisti o dei cultori della letteratura
filosofica) è che di questo saggio non esiste un’unica
versione, bensì quattro versioni tedesche e una versione
francese, l’unica a essere pubblicata durante la vita
dall’autore. Tradotto da Pierre Klossowski, con la decisiva
collaborazione e supervisione dello stesso Benjamin, il
saggio apparve, nel maggio 1936, sulla «Zeitschrift für
Sozialforschung» diretta da Max Horkheimer.
Con questa pubblicazione iniziò, seppur limitata per
estensione, la prima ricezione dell’opera1. Il lavoro destò
subito interesse nei circoli intellettuali parigini: André
Malraux citò le tesi di Benjamin in occasione del Congresso
londinese degli scrittori nel luglio del 1936; il filosofo Jean
Wahl ne discusse con il poeta Pierre Jean Jouve2. Qualche
eco il saggio la ebbe negli Stati Uniti, dove aveva sede la
rivista, destando tra l’altro un profondo interesse nello
storico dell’arte Meyer Schapiro3. Nonostante le
sostituzioni terminologiche e i tagli ai quali fu sottoposta4
dal solerte redattore parigino Hans Klaus Brill, la
traduzione francese va considerata come una versione a
tutti gli effetti. Non solo Benjamin collaborò intensamente
per alcune settimane al lavoro di traduzione di Pierre
Klossowski, ma – seppur convinto che la soppressione del
primo capitolo privasse il lavoro del suo orientamento – non
misconobbe mai il testo. Per di più esso presenta minime
varianti assenti nelle quattro versioni tedesche. Di queste
ultime, a pervenire in forma manoscritta sono soltanto due
versioni: quella che nel volume 16 della Kritische
Gesamtausgabe dei Werke und Nachlaß di Benjamin,
apparso nel 2013 presso Suhrkamp a cura di Burkhardt
Lindner (con la collaborazione di Simon Broll e Jessica
Nitsche), è stata riconosciuta come una prima stesura, pur
in forma di abbozzo, del saggio risalente al settembre
19355 e una Seconda versione (fino all’edizione critica del
2013 considerata dai curatori delle Gesammelte Schriften
«prima versione»)6 composta in bella copia verosimilmente
nell’ottobre 1935. Questa seconda versione, non è
certamente alla base della traduzione francese. Piuttosto lo
è stata quella che nelle Gesammelte Schriften veniva
considerata la «seconda versione», mentre ora è stata
stabilita come la Terza, ritrovata in forma di dattiloscritto
nell’Archivio di Horkheimer, presso la Biblioteca
dell’Università di Francoforte sul Meno, soltanto nella
seconda metà degli anni ottanta, per essere pubblicata nel
1989 nel VII volume delle Gesammelte Schriften di
Benjamin.
Questa versione, che amplia significativamente le prime
due versioni manoscritte (anche con l’aggiunta di diverse
note), fu fatta battere a macchina in più copie da Benjamin,
a seguito dei colloqui avuti con Horkheimer in vista della
pubblicazione del saggio. Preparato tra il dicembre del
1935 e il gennaio 1936, è sicuramente il testo, il cosiddetto
Urtext, «nella versione che Benjamin voleva dapprima
vedere pubblicata»7. Rispetto alla «seconda versione»
manoscritta, che ne costituisce il termine di riferimento più
immediato, è senz’altro più complessa e più ricca sia dal
punto di vista filosofico sia da quello della diagnosi politicoculturale. Venuto meno però il primo tentativo di
pubblicazione di questa stesura con Horkheimer e la
«Zeitschrift für Sozialforschung» e, soprattutto, dopo la
travagliata vicenda della traduzione francese, Benjamin
decise di rimettere mano al testo. Nell’agosto 1936 portò
così con sé, oltre alla versione francese, anche il
dattiloscritto della terza stesura in Danimarca da Brecht.
Insieme lavorarono a una rielaborazione del saggio in
tedesco (che avrebbe dovuto essere «circa un terzo più
lung[o]» della traduzione francese)8. Nacque così la Quinta
versione, che Benjamin sperava di pubblicare sulla rivista
moscovita «Das Wort», della cui redazione Brecht stesso
era parte. Anche questo tentativo fallì9. Dopo il rifiuto
definitivo (fine marzo 1937) del caporedattore Willi Bredel,
Benjamin riprese a lavorare al saggio, raccogliendo
ulteriori appunti10. Parte di queste rielaborazioni le lesse a
Gretel e Theodor Adorno, durante una visita a Villa Verde a
Sanremo, dove i due soggiornarono dalla seconda metà del
dicembre 1937 fino a inizio gennaio del 1938. Quale testo
Benjamin lesse, conferma oggi la nuova edizione critica,
non è dato saperlo. Gretel rimase particolarmente colpita e
si offrì di produrne una copia battuta a macchina. Benjamin
inviò però a Gretel il testo solo un anno dopo, nell’aprile del
1939. E certamente esso non conteneva tutto ciò che aveva
letto a Sanremo, come si evince dalla delusione di Gretel al
riguardo. Seguendo la tesi di Lindner, si tratta della Quinta
versione, dato che la copia dattiloscritta che Gretel
concluderà di predisporre solo dopo la morte di Benjamin
(e che pubblicherà nelle Schriften del 1955) coincide con
essa. Quel che è certo è che Benjamin non considerava
definitiva questa versione, data la richiesta a Gretel di
approntare un margine ampio al lato del testo proprio per
poter continuare il lavoro di revisione e ampliamento11.
Sta di fatto che fu proprio quest’ultima versione a essere
pubblicata nella prima edizione postuma, in due volumi,
delle Schriften benjaminiane, apparsa nel 1955 presso
Suhrkamp a cura di Theodor e Gretel Adorno e di Friedrich
Podzus. Con questa edizione, e in misura più determinata
con la pubblicazione separata del saggio in un volumetto
del 1963 (insieme al saggio su Fuchs e alla Piccola storia
della fotografia e con il sottotitolo Tre studi sulla sociologia
dell’arte), comincia appunto l’immenso influsso esercitato
da questo scritto, grazie anche alle numerosissime
traduzioni di cui fu e continua a esser fatto oggetto.
Singolarmente, però, questa ricezione, almeno fino al 1989,
ossia all’anno in cui fu pubblicata per la prima volta la
versione dattiloscritta ritrovata tra le carte di Horkheimer,
non ha potuto tener conto del fatto inaggirabile che la
versione erroneamente considerata del 1939 (prima intesa
come «terza versione» e ora da considerarsi come quinta)
non costituisce in alcun modo una versione finale o più
completa delle precedenti. Se si escludono le varianti e le
aggiunte più significative (l’inserimento di nuove note,
l’aggiunta di un nuovo paragrafo dedicato alla differenza
tra attore teatrale e cinematografico, una lunga citazione e
un nuovo esergo tratti da La conquête de l’ubiquité di Paul
Valéry), questa versione spicca piuttosto per una minore
complessità filosofico-concettuale rispetto alla seconda,
dove non solo è presente una cruciale distinzione tra due
accezioni di tecnica (distinzione mantenuta anche nella
versione francese), ma anche un’altra polarità concettuale
nella definizione dell’arte oltre a quella più celebre tra
valore cultuale e valore espositivo, vale a dire la polarità
tra gioco e apparenza, come momenti costitutivi, seppur
con differenti accentuazioni, di ogni fare artistico.
Già facendo questa semplice considerazione, non ci si
potrà, dunque, riferire al saggio benjaminiano sull’opera
d’arte se non nei termini di un multiplo, ovvero di una
pluralità di versioni ancora in cerca di ulteriore
integrazione, assestamento e sviluppo. Rispetto alle due
ultime versioni tedesche e a quella francese, la prima
versione manoscritta con i caratteri di un abbozzo e la
seconda manoscritta ma in bella copia (assai probabilmente
per essere dattiloscritta da qualcun altro o fatta leggere,
considerata l’illeggibilità della grafia benjaminiana),
conservano nel loro complesso il carattere di un testo-base
dove sono presenti nell’essenziale i principali temi e motivi
che ritroviamo in tutte le versioni successive, le quali
riguardo all’impianto concettuale e testuale delle prime due
versioni manoscritte rappresentano in ogni caso
ampliamenti tematici e significative riformulazioni12.
E questo è il secondo paradosso di un saggio che ha al
proprio centro la nozione di riproducibilità tecnica (seppur
riferita principalmente all’opera d’arte): le varianti, o
meglio, le differenti ma non divergenti o contrastanti
versioni tendono qui sostanzialmente a occupare il posto
nel quale, nella tradizione filologico-letteraria, s’insedia un
originale. Si stabilisce così un’inevitabile dialettica tra le
versioni manoscritte che possediamo e quelle esistenti
unicamente in forma dattiloscritta (la terza e la quinta) e a
stampa (come la versione francese). In quanto documento
capace di attestare l’identità e l’unicità di un’opera,
l’«originale» del saggio sulla riproducibilità pare così
esposto a una continua oscillazione tra il proprio fantasma
e la costanza nominale offerta dal titolo. Al punto che
l’unità delle diverse versioni e varianti, dei frammenti
preparatori e delle ulteriori riflessioni in vista di una
rielaborazione può anche esser letta nel dispiegarsi di una
tensione tra il nominalismo del titolo, il suo carattere di
etichetta capace di identificare espressivamente un’idea, e
la storia incompiuta e, per certi aspetti, pluriversa del suo
sviluppo. Una tensione tutta benjaminiana tra nome e
storia, che dell’originale e dell’origine se non l’aura, anche
qui immiserita e declinante, lascia affiorare almeno la
traccia.
Una traccia, come tale, non può tuttavia smentire il suo
valore d’indice o d’indizio. Se non altro di un problema –
ecco il terzo paradosso – che percorre come un assillo tutta
la complessa genesi biografica, e non solo, di questo lavoro.
L’assillo di disporre, per le contingenze della vita e per i
limiti che ancora caratterizzavano la riproducibilità tecnica
della scrittura, di pochissime copie dattiloscritte del saggio.
A più riprese Benjamin vi fa riferimento nelle lettere,
reclamandone spesso una restituzione dai suoi
interlocutori. Un assillo a cui si aggiunge la costante
tensione tra la dimensione autografica di manoscritti
contenenti paralipomena, varianti e appunti per future
rielaborazioni del saggio e le copie tecnicamente riprodotte
delle sue versioni. Una tensione che assegna proprio alle
versioni tecnicamente riprodotte il paradossale carattere
della provvisorietà rispetto al continuum immateriale di un
metatesto che costituisce la vera unità del saggio e del
problema cui intende corrispondere13. In un saggio sul
principio della riproducibilità tecnica, preoccupazione
costante e drammatico problema sembra proprio l’unicità
dell’esemplare di cui l’autore dispone. Nell’epoca del word
processing e della riproduzione digitale di immagini e
scrittura, almeno questo ulteriore assillo gli sarebbe stato
risparmiato. E forse è proprio a partire da alcuni non
trascurabili tratti della nostra epoca che possiamo cogliere
in tutta la sua forza anticipante il saggio di Walter
Benjamin.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :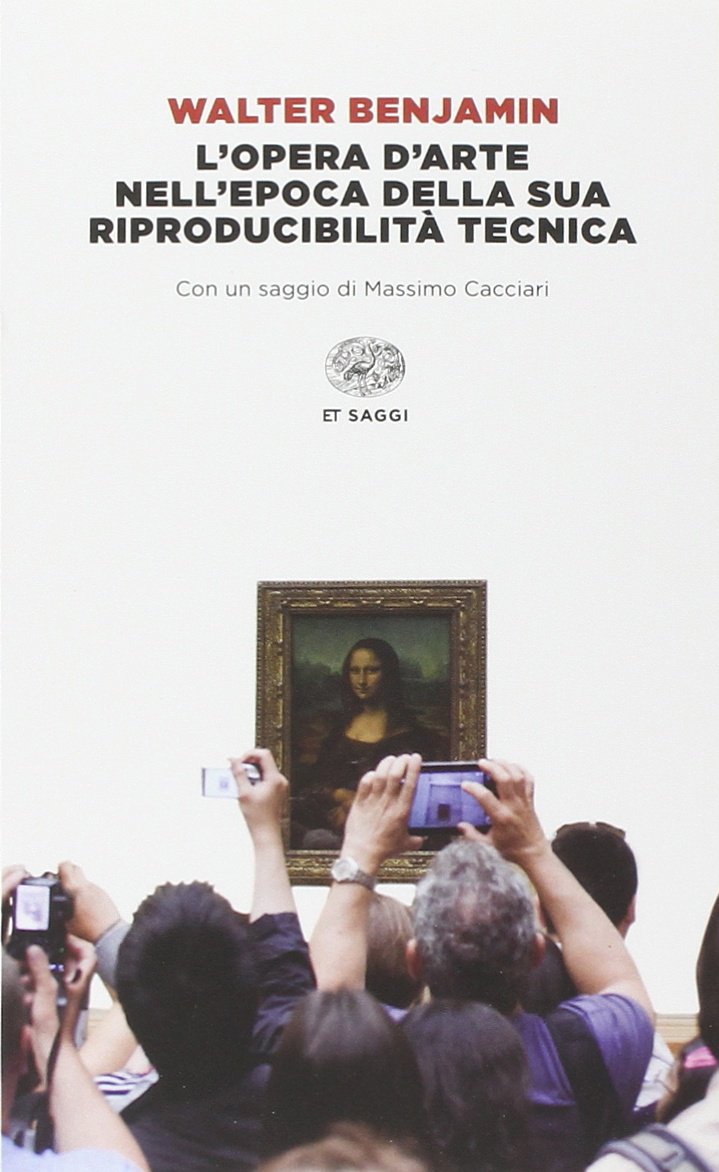






Commento all'articolo