La storia ci salverà – Carlo Greppi
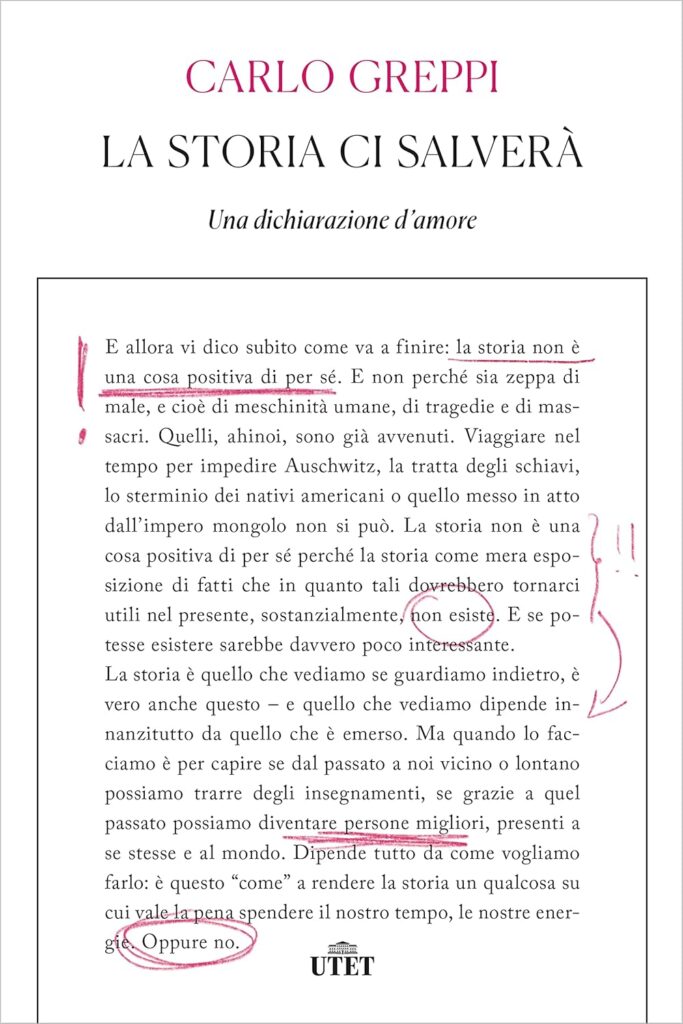
SINTESI DEL LIBRO:
Che cos’è per te la storia?» mi ha chiesto una volta uno studente di
diciassette anni, durante un incontro. Ci ho pensato qualche
secondo e poi ho risposto.
«L’eterna lotta tra il bene e il male, forse.»
D’istinto mi è venuto da citare Il Signore degli Anelli e Harry Potter,
che non è che parlino di storia anche se un legame con la storia –
come ogni cosa – ce l’hanno, per poi aggiungere subito che
ovviamente anche nel bene ci sono porzioni di male, e viceversa.
Sempre d’istinto, mi è venuto da specificare che quella è la storia
che interessa a me, mentre ci sono interi periodi in cui questa lotta
non esiste. O forse non smette mai di esistere, mi viene da chiarire
ora, solo che a volte non si vede.
Sicuramente non mi sarebbe mai venuto da definire la storia “uno
degli argomenti che spesso annoiano i ragazzi”, come avrebbe fatto
in mia presenza tre anni dopo un’altra studentessa, benché io sia del
tutto consapevole del fatto che, per molti, la storia è esattamente
quella roba lì. Non il modo per scoprire come siamo arrivati fin qui,
ma qualcosa di tremendamente noioso, una litania di biografie di
uomini e donne (ma per lo più uomini) illustri e delle loro imprese,
una sfilza di eventi e date con pochi appigli logici – eventi e date che
noi dovremmo imparare non si sa bene perché.
E allora vi dico subito come va a finire: la storia non è una cosa
positiva di per sé. E non perché sia zeppa di male, e cioè di
meschinità umane, di tragedie e di massacri. Quelli, ahinoi, sono già
avvenuti. Viaggiare nel tempo per impedire Auschwitz, Hiroshima e
Nagasaki, la “tratta” degli schiavi, lo sterminio dei nativi americani o
quello messo in atto dall’impero mongolo non si può. La storia non è
una cosa positiva di per sé perché la storia come mera esposizione
di fatti che in quanto tali dovrebbero tornarci utili nel presente,
sostanzialmente, non esiste. E se potesse esistere sarebbe davvero
poco interessante.
La storia è quello che vediamo se guardiamo indietro, è vero
anche questo – e quello che vediamo dipende innanzitutto da quello
che è emerso. Ma quando lo facciamo è per capire se dal passato a
noi vicino o lontano possiamo trarre degli insegnamenti, se grazie a
quel passato possiamo diventare persone migliori, presenti a se
stesse e al mondo. Dipende tutto da come vogliamo farlo: è questo
“come” a rendere la storia un qualcosa su cui vale la pena spendere
il nostro tempo, le nostre energie. Oppure no.
La storia è positiva solo se, anche per vie tortuose, arriva a farci
capire come siamo fatti, cosa possiamo essere e cosa rischiamo di
diventare. Questa è la prima cosa che vorrei dire: la storia è l’eterna
lotta tra il bene e il male, forse – fuori e dentro di noi.
2. Futura umanità
La storia universale
Molti storici amano citare un aneddoto riportato da uno dei più illustri
medievisti del Novecento, il francese Marc Bloch. È un dialogo tra lui
e un collega belga più anziano, Henri Pirenne. Un giorno della prima
metà del secolo scorso i due arrivarono a Stoccolma e Henri disse a
Marc: «Che cosa andiamo a visitare come prima cosa? Sembra che
vi sia un municipio nuovissimo. Cominciamo da lì». Poi, come a
voler anticipare il “moto di meraviglia” dell’interlocutore, aggiunse:
«Se fossi un antiquario, non avrei occhi che per le cose vecchie. Ma
io sono uno storico. È per questo che amo la vita».
Ora, su Bloch torneremo, e gli dedicheremo lo spazio che merita
in un libro che – lo confesso subito – è un atto d’amore nei confronti
della storia. Intesa però come inno, appunto, alla vita e alla felicità a
cui tutti gli umani devono avere diritto. Ma quello che vorrei qui
sottolineare è che proprio Henri Pirenne, l’uomo che disse «sono
uno storico. È per questo che amo la vita», qualche anno dopo la
prima guerra mondiale propose di creare un’Internazionale degli
storici – Internationale des historiens – contro «il disordine mondiale
delle coscienze», perché sosteneva che i manuali di storia
avrebbero potuto fare enormi danni, e cioè portare all’esasperazione
del nazionalismo, come in effetti stava accadendo. È indubbiamente
vero, infatti, che nei decenni precedenti la cultura storica aveva
contribuito a legittimare gli stati nazionali e le loro pretese (territoriali,
ma non solo) e, di conseguenza, il nazionalismo, un’invenzione
terribile che tra Ottocento e Novecento sfuggì di mano «a chi aveva
trovato vantaggio nel manipolarlo», come avrebbe scritto il grande
storico britannico Eric J. Hobsbawm. E il nazionalismo, comunque lo
vogliamo chiamare, porta solo odio e guerra, quindi morte e
infelicità. Cioè il contrario di quello a cui tutti gli esseri umani
dovrebbero tendere.
A differenza di Bloch, il suo collega Henri Pirenne non avrebbe
vissuto tanto a lungo da vedere divampare la seconda guerra
mondiale, scoppiata anche per colpa di un’idea di storia distorta, a
servizio proprio di feroci nazionalismi che avrebbero distrutto
l’Europa e il mondo intero. Così come una certa concezione della
storia – unita all’idea di “destino”, e dunque di dominio di una “stirpe
eletta” – avrebbe portato ad Auschwitz, lo stesso era successo con il
commercio degli schiavi, con lo sterminio dei nativi americani o con
quello verificatosi secoli prima sui territori dell’impero mongolo a
danno delle popolazioni via via sottomesse. Pirenne aveva ragione:
la storia o riguarda tutti e tutte o riguarda solo alcuni, che la usano
per affermarsi su altri. Come avrebbe scritto il suo amico Marc,
«l’unica storia autentica […] è la storia universale». Se la storia, cioè,
è “usata” da un gruppo umano per schiacciarne altri, può diventare
uno strumento terribile. E questa è la seconda cosa che vorrei dire
oggi, in risposta a quello studente che mi chiedeva cosa fosse per
me la storia: la storia, come il futuro, è un patrimonio dell’intera
umanità.
3. Foreste di filo spinato
La storia tra narrazione ed emozioni
Questo libro è un tentativo di dire qualcosa intorno alla “materia” che
forse è più presente di ogni altra nei nostri discorsi, nelle nostre
giornate, nel nostro sguardo. Che ne siamo consapevoli o no, che ci
piaccia o no, tutto intorno a noi è storia. Guardiamo sempre al futuro,
è vero, con timore o speranza – o con sentimenti ambivalenti in cui
timori e speranze sono aggrovigliati. Ma tutto il resto è passato,
come scriveva sempre Marc Bloch: «Che cos’è, in effetti, il
presente? Nell’infinito della durata, un punto minuscolo che sfugge
senza posa; un istante che, appena nato, muore». Anni dopo lo
storico britannico Edward H. Carr avrebbe scritto che «tutti sappiamo
che il presente, questa linea immaginaria che separa il passato dal
futuro, è una realtà puramente mentale». Noi umani viviamo immersi
in questo “punto minuscolo” o in equilibrio su questa “linea
immaginaria” che ci sembra sempre di riuscire ad afferrare ma che
sfugge senza sosta alla nostra presa. E abbiamo un rapporto
complesso con ciò che c’è stato prima: più andiamo a ritroso e più il
passato ci appare una terra straniera. A meno che non ci sia
qualcuno di molto bravo a raccontarcelo, o a meno che questo
tempo già trascorso abbia direttamente qualcosa a che vedere con
la nostra vita.
Sembra ovvio a tutti che il passato che ci interessa di più sia
spesso quello personale, familiare, locale, quello che in qualche
modo ci riguarda, che ci dice qualcosa di noi stessi e della comunità
in cui siamo, quello del gruppo a cui riteniamo di appartenere. Ma il
compito di chi si occupa di storia credo sia proprio di rendere
“familiare” quella terra straniera, ovunque essa sia. L’altrove, nel
tempo e nello spazio. Tutto questo non può accadere senza
conoscenza, è vero, né senza ricostruzione o senza narrazione. È
così che il passato può rivelarsi incredibilmente vicino. Nel suo libro
Non c’è una fine. Trasmettere la memoria di Auschwitz il direttore del
Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau, Piotr M.A. Cywiński,
riferendosi al tentativo di un sito memoriale di proteggere e mostrare
l’autenticità del luogo, sostiene che «niente ha un effetto più
catastrofico del trascorrere del tempo». E come esempio più
emblematico prende quello del filo spinato:
Sottile, esposto al gelo, alla pioggia, alle oscillazioni di temperatura, appesantito
dal ghiaccio e cotto nel sole di agosto, deve essere cambiato ogni dozzina d’anni.
Qualcuno protesta, sostenendo che non si dovrebbe installare del filo spinato
moderno in un luogo in cui il paradigma è l’autenticità. Invece si può, e deve
essere fatto. Diversamente, Auschwitz sarebbe circondata da migliaia di pali di
cemento isolati. La connessione tra i pali sarebbe invisibile. I visitatori non
capirebbero come le SS avevano diviso il campo in settori delimitati: si
troverebbero davanti soltanto un’incomprensibile foresta di pali.
Cywiński svela una grande verità: se non è ricostruita, raccontata, la
storia non esiste – e dalla storia derivano la memoria individuale e la
memoria collettiva, che della storia non possono fare a meno. Se noi
non sapessimo niente di quello che è accaduto ad Auschwitz, per
esempio, cosa penseremmo muovendoci tra quella foresta di pali?
Di quella storia non avremmo alcuna memoria.
Sempre Cywiński scrive come la memoria rimuova, in un certo
senso, “la dimensione del tempo”, mettendoci faccia a faccia di
fronte ai fatti che vogliamo ricordare. E, in un luogo come Auschwitz,
questo fa male: grazie alla storia – alla conoscenza che qualcuno ci
ha trasmesso – fa dannatamente male vedere quello che l’essere
umano è riuscito a fare a se stesso. Ed è questa la terza cosa che
vorrei dire: la storia è una narrazione, e dunque ha sempre a che
vedere con le emozioni.
4. Sfidare il caso
La storia e le scelte
Credo di sapere, parlando di emozioni, il momento esatto in cui ho
intuito che la storia avrebbe potuto essere la mia vita. Era quasi sera
– il corso si teneva dalle 18 alle 20 –, ero iscritto alla laurea
magistrale in Culture moderne comparate, e la lezione del
professore era magnetica. Si discuteva di decolonizzazione, a
proposito di storia universale: forse per la prima volta nella mia
giovane vita mi rendevo nitidamente conto del fatto che esiste un
numero incalcolabile di prospettive sul nostro passato. Il professore
del quale non volevo perdermi neanche una sillaba si chiamava Aldo
Agosti, ed è uno dei massimi esperti di storia del comunismo. Si dice
che non si può ragionare con i “se”, ma poi tutti e tutte lo facciamo, e
allora mi chiedo se lui avesse scelto di dedicare quel suo corso alla
parabola del comunismo internazionale, per esempio, che fine avrei
fatto io. O, specularmente, se io non avessi scelto quel corso
universitario, mettendomi in gioco su un terreno in cui non ero a mio
agio perché incuriosito dal titolo, probabilmente voi non avreste
questo libro tra le mani. Ho poi saputo che quel corso anche per
Aldo era stato una sorta di esperimento: si voleva cimentare con una
materia che non era il “centro” del suo percorso di studi, né aveva un
granché a che fare con la sua storia personale e familiare.
Suo padre Giorgio, un magistrato, era stato un partigiano. Era uno
dei leader del Partito d’azione, che fu una delle esperienze di
militanza e di partecipazione più straordinarie della storia italiana. A
differenza di molti suoi compagni di lotta, lui non aveva scelto di
combattere fascisti e nazisti con le armi, ma aveva messo al servizio
della causa la sua capacità organizzativa, e tutta la dedizione di cui
era capace. Ho poi imparato a conoscere Giorgio, negli anni, così
come Aldo, solo che Giorgio l’ho conosciuto attraverso le storie su di
lui che ho sentito raccontare e attraverso i suoi scritti. Tra questi c’è
una lettera che invia all’amico Dante Livio Bianco, anche lui nella
Resistenza, mentre diversi loro compagni di lotta stanno per essere
fucilati, sapendo che «l’alternativa di oggi» è di lasciarci la pelle o
finire «al muro o in un campo di concentramento in Germania»,
mentre quella di domani «è di ritrovare, ignorati o dimenticati, il
nostro lavoro o di doverci difendere da nuove persecuzioni, che
vengano da destra o da sinistra». «Carissimo – scriveva Giorgio a
Dante Livio –, la nostra parte non è facile, il nostro lavoro è il più
oscuro, forse infangato. Per gli uni saremo dei pazzi, per gli altri dei
sovversivi.» «Eppure – continuava – questa lotta, proprio per questa
sua nudità, per questo suo assoluto disinteresse, mi piace. Se ne
usciremo vivi, ne usciremo migliori; se ci resteremo, sentiremo di
aver lavato troppi anni di compromesso e di ignavia, di aver vissuto
almeno qualche mese secondo un preciso imperativo morale.»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :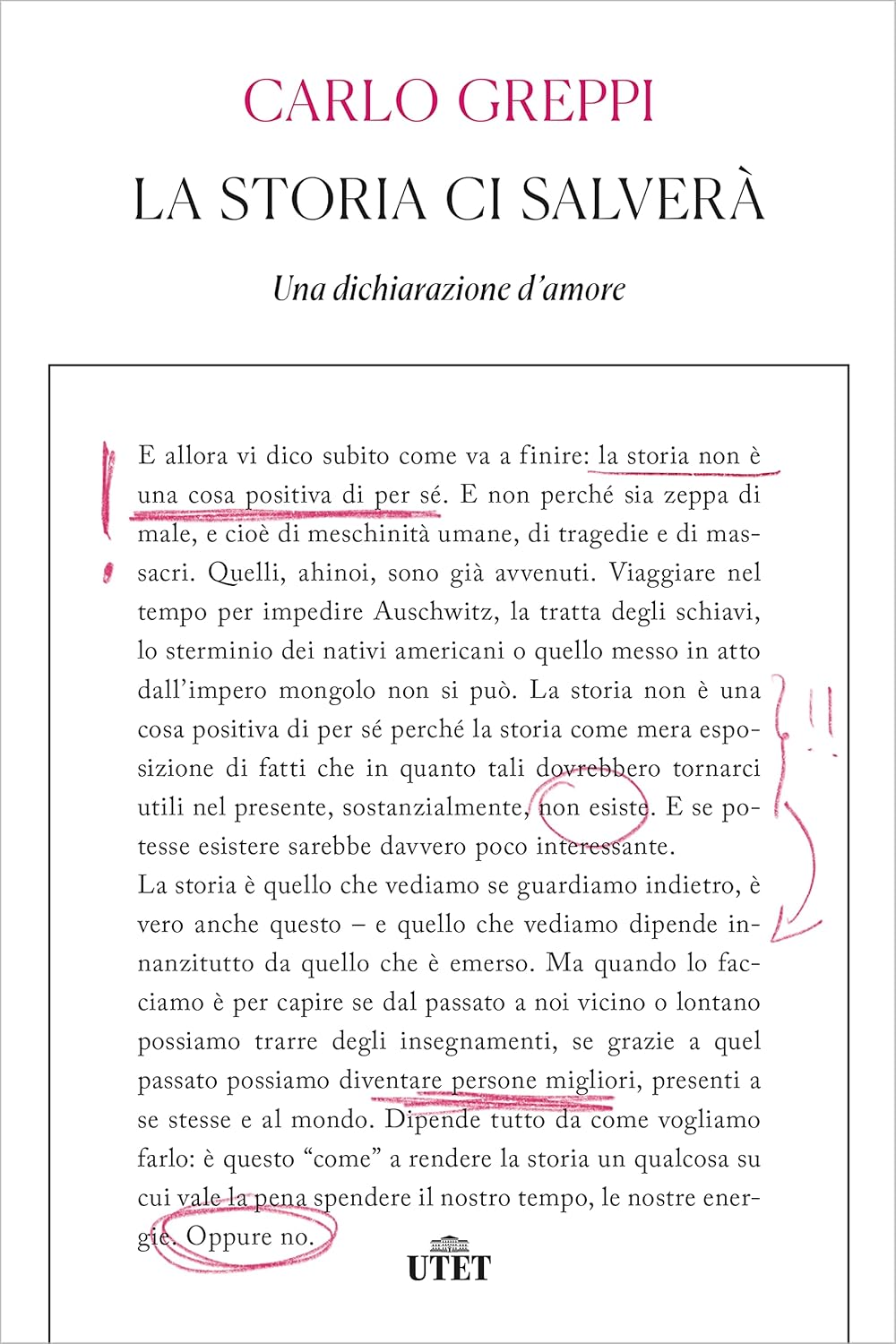






Commento all'articolo