La mente virtuale – Giulio de Martino
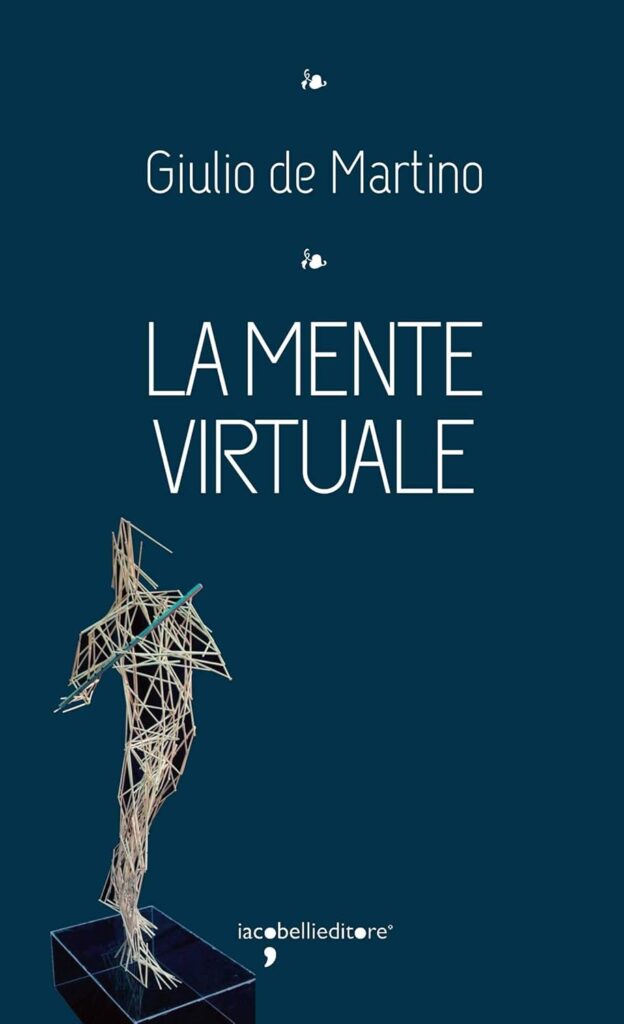
SINTESI DEL LIBRO:
Da tre decenni Hamelin è ovunque. In ogni casa vi sono una playstation, un
computer, uno smart-phone o un i-pod con le cuffiette. Preceduti negli anni
Sessanta dai registratori a nastro, dall’hi-fi e dalle istamatic, i new media digitali
attirano i sensi e la mente dei bambini e degli adolescenti assorbendoli
completamente. I genitori parlano loro, ma non sono ascoltati, li invitano a
venire a tavola o a uscire, ma i ragazzi li ignorano: restano nelle loro stanzette
(Wunderkammeren) ipnotizzati dallo schermo luminoso e dai folletti colorati
che vi si agitano dentro. I giovani sembrano soggiornare dentro una sfera di
vetro che li rende intangibili e indifferenti a quanto accade intorno. Inseritosi
nelle case come sostituto genitoriale o come ausilio per la baby-sitter, il
monitor, dopo aver acquietato i bambini, diventa il padrone della loro mente.
Allontanati a viva forza dalla tv o dal lettore dvd i bambini si ribellano e
danno sfogo a capricci e recriminazioni che vengono sedati a fatica dai
genitori: pianti e proteste terminano solo quando iniziano i rituali del sonno.
Col passare degli anni i ragazzi diventano selvatici e imprevedibili, agitati da
pulsioni enigmatiche e violente, sono indisciplinati e fragili: il processo
dell’alternarsi generazionale, la ciclicità del divenire sociale sembrano messi a
repentaglio.
Hamelin è un paese senza futuro perché i suoi bambini sono spariti, rapiti
altrove. Se la sociologia presta attenzione alla riproduzione in quanto processo
di trasformazione economico-sociale, la psicoanalisi ha focalizzato la
riproduzione in quanto processo psicologico e individuale: le dinamiche della
soggettivazione passano attraverso la struttura familiare e si completano con
l’integrazione nella società
2. La novità è che dentro la famiglia di oggi non si
sviluppano vere e proprie relazioni parentali. Dentro la famiglia, dentro la
casa,agisce la tecnologia digitale come elemento determinante nello sviluppo
psichico. Gli influssi – prima passivi e poi interattivi – del mondo digitale
imprimono una direzione peculiare alla formazione della personalità.
Osserviamo che luoghi sacrali dell’accesso al mondo sociale sono divenuti i
negozi di telefonìa mobile e gli store di micro-elettronica, i ragazzi e le
ragazze girano per le strade con il telefono cellulare fallicamente brandito e
tengono continuativamente l’i-pod nelle orecchie. Familiarizzati con il
mondo digitale fin dall’infanzia, i giovani forgiano la propria soggettivazione
e l’interazione attraverso il rispecchiamento e il filtro digitale. L’ingresso nella
rete – da cui provengono gran parte dei loro contenuti mentali – è segno
dell’esserci-nel-mondo.
La famiglia non funge da filtro selettivo e i bambini passano dalla simbiosi
con la madre a uno stato limbico di durata indefinita. L’ingresso nel mondo
sovradeterminato dalla presenza digitale non risulta facilitato. L’integrazione
attuata tramite le tecnologie del vedere/vedersi e dello scrivere/scriversi digitali è
divenuta virtuale. Il reale resta precluso. L’inclusione digitale aggira la relazione
face to face, non implica il riconoscimento del giovane da parte di un’autorità
simbolica e quindi attua una iniziazione alla vita sociale apparente.
Intanto, of line, i processi di socializzazione reale sono divenuti evanescenti:
scuola, quartiere, città sono luoghi sconnessi e vuoti di effettiva relazionalità.
All’integrazione virtuale sfuggono i più poveri, i caratteriali, gli emarginati, i
profughi: nella fiaba di Hamelin il bambino zoppo, che non riesce a stare al
passo con i coetanei e si salva dallo sterminio (de Martino 2014).
NOTE
2. La profezia di Baudrillard sulla “morte del sociale” (A l’ombre des majorités silencieuses ou la fin du social, 1978) ha aggravato la
diagnosi dell’omologazione e della unidimensionalità del piano intersoggettivo e relazionale formulate da Pasolini e da Marcuse. Ha
anche anticipato la diagnosi della “società liquida” di Bauman: un sociale uniformato e instabile, in cui gli umani replicano ruoli fittizi e
confusi.
Lo specchio
Lo psicologo francese Henry Wallon introdusse nella psicologia dell’età
evolutiva la nozione di stadio dellospecchio. A un certo momento della sua
formazione come soggetto psichico – superato il primo anno d’età – il
bambino attua una performance di autoriconoscimento attraverso la visione
della sua immagine corporea riflessa in uno specchio. Passa dal vedere al
vedersi, dall’esser-visto dalla madre al guardarsi da sé (Wallon 1945, 1949).
Lo specchio avvia la formazione dell’identitàpersonale: il corpo proprio, visto
dal di fuori diventa immagine di sé, un ego per il bambino che - andando oltre
la cenestesi del corpo vissuto – pensa: «io sono quella immagine di me».Wallon
ha scoperto l’origine del cogito ergo sum cartesiano nello sdoppiamento
primario tra la corporeità e l’immagine mentale dell’identità. L’immagine di
sé rende disponibile per il bambino un involucro esterno («come mi vedono
gli altri») che si sovrappone all’interno («come mi sento io»). Un involucro
protettivo, una pelle che gli apre le porte del sé che è anche «fuori di sé» e
sotto gli occhi dell’altro.
L’immagine di sé si sviluppa in concomitanza con l’acquisizione del linguaggio:
l’altra modalità della soggettivazione in perfezionamento tra la prima e la
seconda infanzia. Con una doppia traccia di identificazione (immaginaria e
simbolica) il bambino diventa uno specifico essere umano: presente al mondo e
relazionato agli altri. Jacques Lacan ha innestato l’acquisizione di Wallon nella
teoria freudiana dello sviluppo psicosessuale: la soggettivazione immaginaria e
simbolica è posta in concomitanza con la congiuntura psichica che Freud
chiamava complesso di Edipo e che segna il processo di distacco del nuovo
individuo dalla madre biologica per offrirsi al padre simbolico. Il passaggio
iniziatico attraverso la castrazione farà sì che il desiderio venga piegato alle
regole della relazione: con il desiderio dell’altro e con le leggi del discorso cui
lo introduce il nome del padre. Si apre così il campo dell’esistenza lacerata, ma
attiva, in cui sia le formazioni immaginarie che le regolazioni simboliche
sono poste al bordo esterno del reale (Lacan 1949).
Oggi che lo specchio è sparito dalle case – confinato nel bagno o nascosto
nell’anta dell’armadio – al suo posto troneggiano il video e il monitor di un
televisore, di un telefono cellulare o di un pc. Lo specchio non
comprometteva, anzi incrementava, la vita di relazione e lo sviluppo del
linguaggio: il padre-monitor, invece, parla in continuazione al bambino: cattura
la sua mente nella fascinazione aprendo lo spazio a soddisfazioni mute.
Guardando il monitor il bambino si sente autorizzato – posizionandosi dentro
le immagini – a individuare se stesso per una via diversa dal dialogo:
l’autonominarsi. La sua mente non transita verso l’altro e non circoscrive il
reale: la soggettivazione si dirige verso il virtuale, verso quella lingua e
quell’immagine che hanno origine nel monitor. La soggettivazione proposta
dalla famiglia e dal sociale sopraggiunge dopo, inudita e tardiva: il nucleo duro
della mente si è già formato.
Il monitorha occupato il luogo sorgivo della mente e incide sulla
strutturazione del desiderio ostacolando la rimozione. Restano dentro il flusso
desiderante oggetti, forme, pulsioni – pezzi di realtà – che sarebbero
altrimenti deperiti e scomparsi. Si può parlare di una fissazione all’infanzia?
Di accesso a un monologare ininterrotto? Collocandosi nel luogo del vuoto e
dell’assenza, il monitor lo ha riempito con un flusso continuo di colori e
suoni, ma non ha educato né alla fantasia, né alla sublimazione. Il monitor
incarna un tutto-pieno, una totalità compiuta, in cui vi è disponibilità illimitata
di immagini e contenuti appaganti. Nel bambino sorge l’inquietidine
dell’esterno, l’incertezza dell’umano: quando gli apparirà il mondo lo guarderà
dal di fuori, lo ridurrà a immagine e ne diventarà il riflesso. Lo specchio
preludeva all’apparizione sulla scena di un eroe che avrebbe guidato il
fanciullo lontano dalle terre incantate della sua infanzia, verso sfide e
conquiste. Nello scenario virtuale i fumetti diventano cartoon e i supereroi della
serialità assolvono al loro compito muovendosi all’esterno di una mente resa
immobile (Faeti 1972). È una strana mente primitiva quella che ha giocato
con il monitor.
Le cose
L’ef etto-Hamelin è una forma di sparizione: non ci sono più i bambini, ma
esseri post-umani che impersonano i bambini (Baudrillard 2007). Siamo in
un mondo stanco di uomini e donne che, privi dell’immagine di sé, temono
l’esterno e si acquietano nella cosalità: se non la raggiungono la rivendicano
con violenza. Già nella condotta degli adolescenti si enfatizza la pretesa
dell’oggetto. Divenuti incorporei nickname,i giovani vivono aggrappandosi a
gadget o grif e, merchandising o antistress: la funzione delle cose è di offrire – a
chi è stato rapito nel mondo virtuale e inibito nelle relazioni frontali – un
simulacro di realtà, un mondo cosale nel quale identificarsi. La relazione
oggettuale diventa ipertrofica: gli oggetti-mostro invadono la realtà
ponendosi come stadio supremo della soggettivazione. Le cose diventano
marchio, spot, simbolo parlante: la cosa è persona e il consumo diviene un
pasto antropofagico. L’uso dell’oggetto è dissezione anatomica, l’azione è
allucinazione: le cose sono il mondo e l’identità evita la differenza (Baudrillard
1983). Sulle cose si spostano la relazione affettiva (l’oggetto-feticcio è il simbolo
dell’essere amato) e la relazione di riconoscimento (l’oggetto è il segno della mia
identificazione).
Le cose non sono i segnali transitori di una generazione, ma le sbarre di una
prigione. Il corpo è divenuto corpogadgetico che può dire di me al mio posto.
La tatuazione, il piercing sono il marchiamento del proprio corpo, la scoperta
dell’oggetto che è in ognuno di noi. La tatuazione non comporta
l’inserimento in un mondo o il confronto con un’autorità iniziatrice. Nella
personalizzazione delle cose si svela una forma di autoriduzione, una
invalicabile marginalizzazione. Mitologie si imprimono sulla pelle, mitologie
si agitano nella mente.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :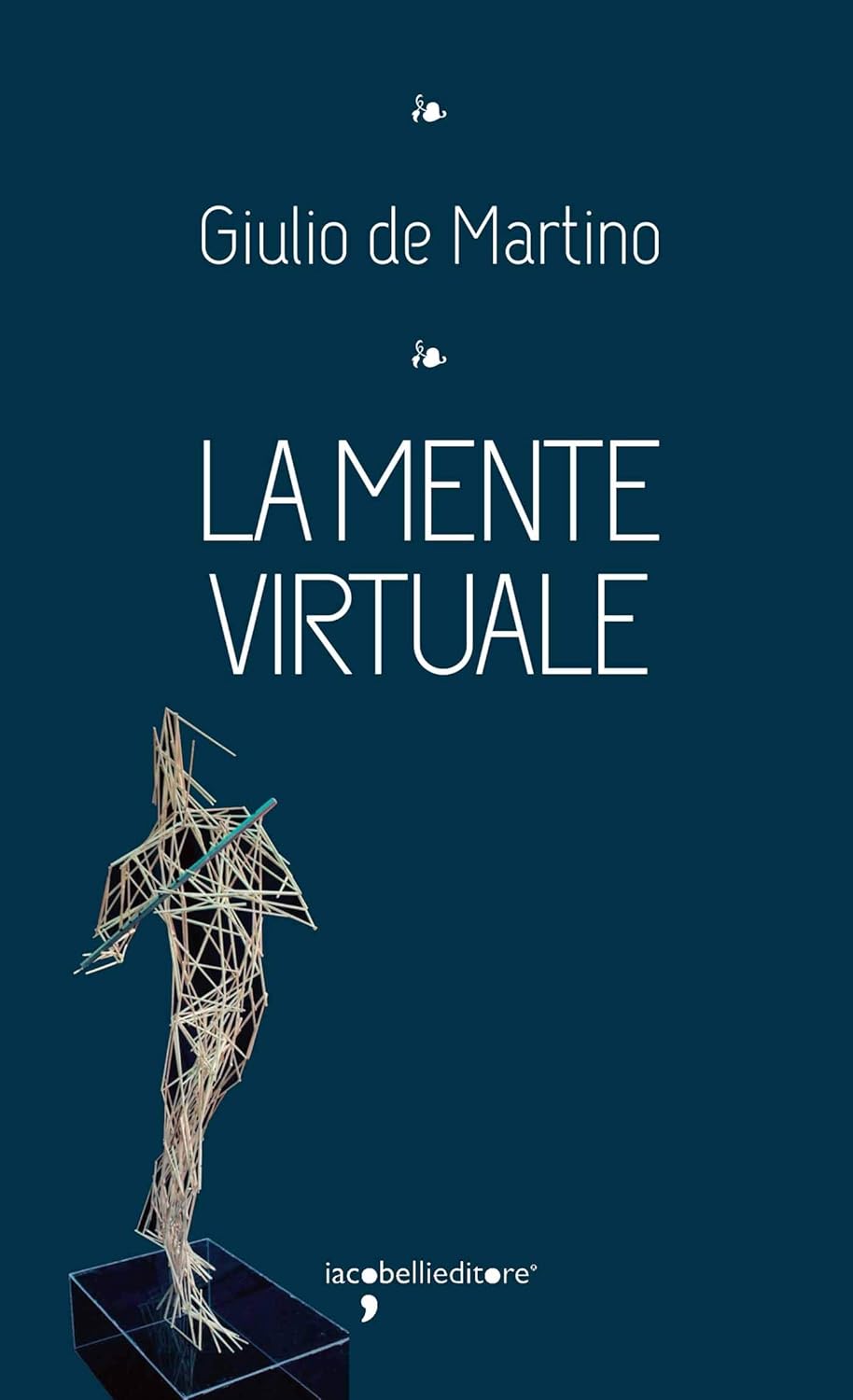




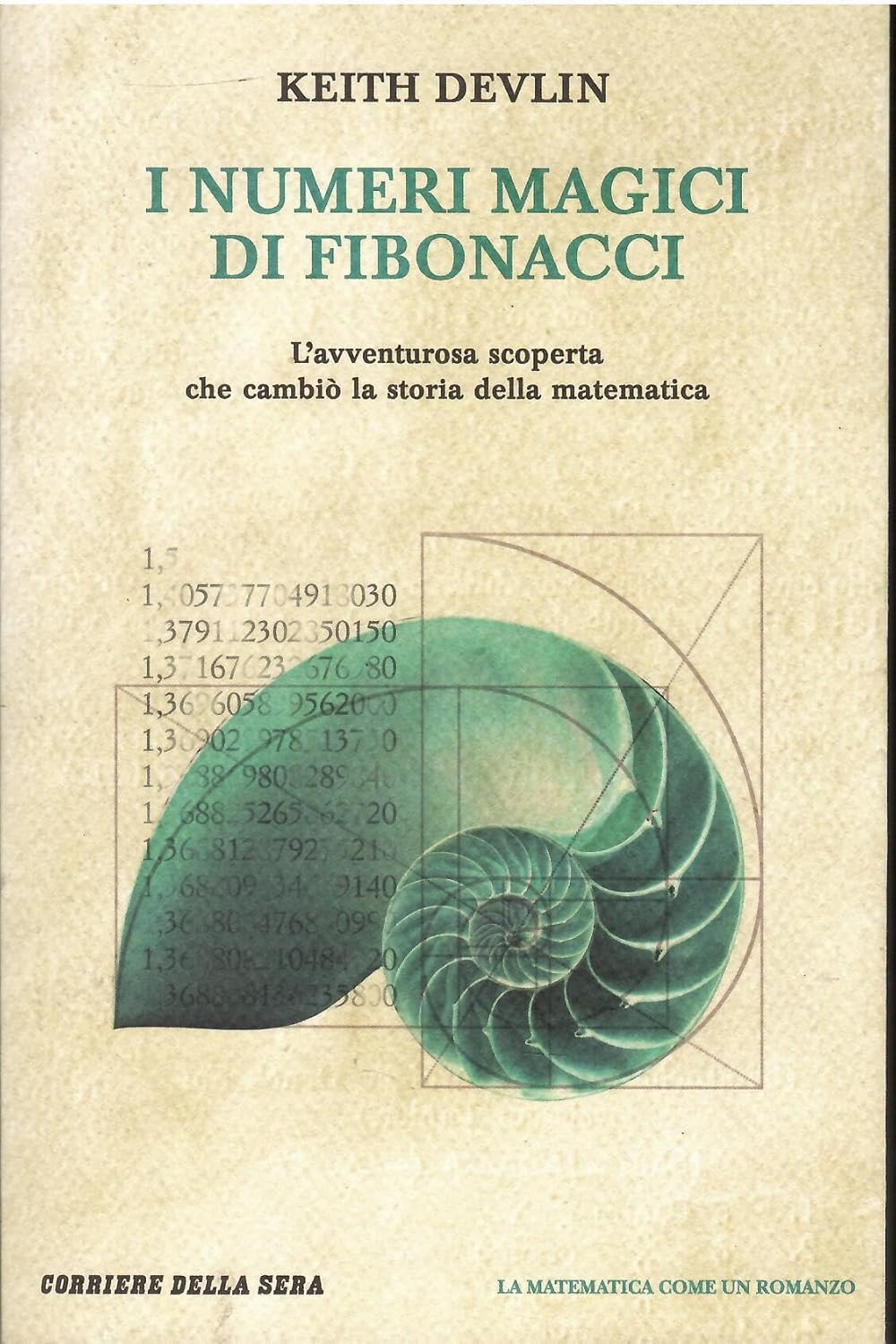

Commento all'articolo