La grande Hollywood – Stili di vita e di regia nel cinema classico americano – Veronica Pravadelli
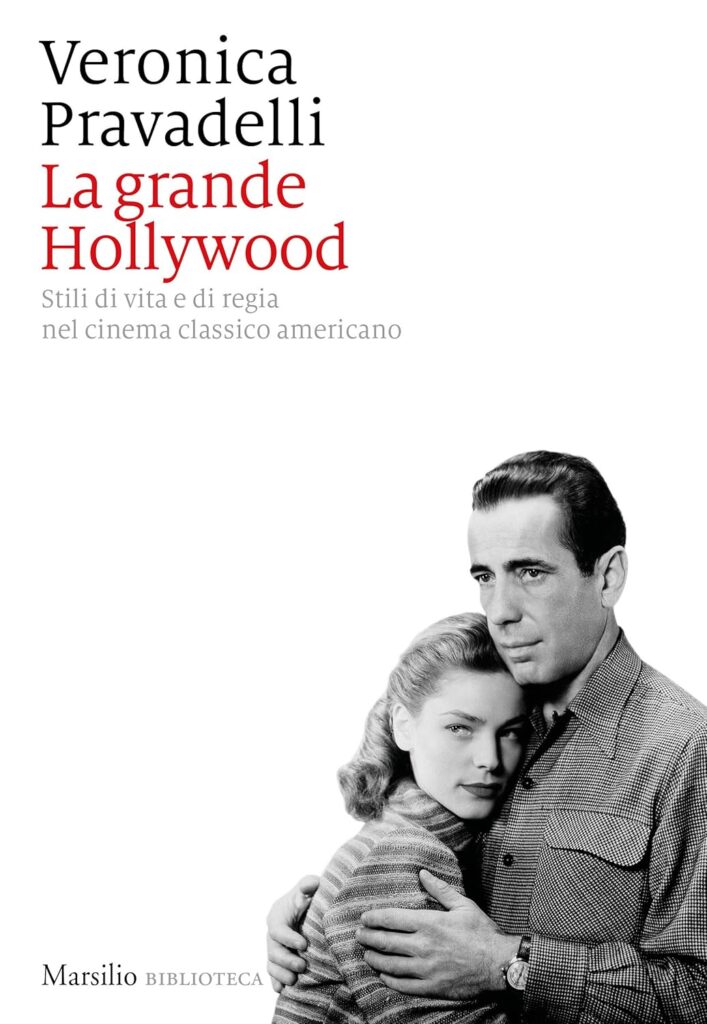
SINTESI DEL LIBRO:
Il dibattito sullo statuto ideologico dell’apparato
cinematografico e del film favorisce nei primi anni settanta la
formazione di un discorso concettuale di grande suggestione, che
costituisce, tra l’altro, uno degli sviluppi più importanti dell’analisi
del film: l’originale rielaborazione di alcuni interventi apparsi nei
«Cahiers du cinéma» tra fine anni sessanta e inizio anni settanta,
e tradotti in inglese su «Screen», porta alla formulazione di una
griglia teorico-interpretativa del cinema classico non più
monolitica. Due scritti, in particolare, hanno un ruolo di primo
piano: l’intervento di Jean-Louis Comolli e Jean Narboni Cinéma,
idéologie, critique (1969), in cui si propone una tipologia del
rapporto tra film e ideologia, ovvero di come il testo veicoli, o
meno, un messaggio ideologico, e lo scritto di Jean-Pierre Oudart,
Cinéma et suture (1969), in cui si discute il rapporto tra strategie
tecnico-formali ed esperienza spettatoriale. Riprendendo la
tipologia proposta da Comolli e Narboni, gli studiosi più accorti
individuano nel cinema classico la compresenza di due diversi
modelli di rappresentazione, il classic realist text e il subversive (o
progressive) text. Il realist text è «imbevuto dall’inizio alla fine
dall’ideologia dominante che vi compare in forma pura e
inadulterata […]. Questi film accettano il sistema stabilito di
dipingere la realtà: “realismo borghese” […] cieca fede nella
“vita”, nell’“umanità”, nel “buon senso”». Al contrario il
subversive text «sembra a prima vista appartenere fermamente
all’ideologia ed esserne dominato», ma risulta invece legato ad
essa in modo ambiguo. Guardando la struttura del film si possono
cogliere due momenti: uno in cui il testo sembra restare entro
certi limiti, un altro in cui li trasgredisce. Se si legge «il film
obliquamente, cercando sintomi e se si guarda oltre l’apparente
coerenza formale, si vedrà che il film è cosparso di crepe: è diviso
da una tensione interna che non si riscontra in un film
ideologicamente innocuo»9. Nel primo gruppo rientrerebbero tutti
quei film che, «nascondendo» i loro processi di scrittura –
utilizzando cioè l’invisible style – e privilegiando i nessi
dell’intreccio e della sua risoluzione, «nascondono» anche
l’ideologia veicolata dal racconto. Componente fondamentale del
classic realist text è il processo di identificazione cui lo spettatore
è interpellato, processo che, fondandosi su schemi inconsci,
impedisce all’esperienza filmica di diventare esperienza cosciente.
Nel privilegiare l’istanza dell’Immaginario, a scapito di quella del
Simbolico, il cinema di Hollywood non farebbe altro che
alimentare quella «falsa coscienza» che, all’indomani del ’68,
intellettuali e critici si propongono di mettere in discussione10.
Quando si vanno ad analizzare concretamente i film, si fa però
strada la consapevolezza che il loro funzionamento ideologico è
diversificato. A nostro avviso si può cogliere una scansione
cronologica, all’interno del periodo 1930-1960: rispetto al cinema
degli anni trenta, quello dei due decenni successivi mostra
dispositivi narrativi e modelli di messa in scena profondamente
mutati11. Nel cinema degli anni quaranta e cinquanta le storie
diventano complesse e confuse, i nessi di causa ed effetto non
sono più rigorosamente rispettati e il racconto riesce solo
faticosamente a spiegare, e risolvere, i conflitti della story. Spesso,
è così contorto e inverosimile da risultare contraddittorio. Ma è il
livello stilistico, o meglio l’eccesso stilistico, che rivelerebbe le
contraddizioni del racconto stesso e quindi, questo è il punto
fondamentale, dell’ideologia veicolata. Lo stile, in altre parole,
svelerebbe ciò che la story censura e non riesce a esplicitare,
acquistando dunque una funzione critica e rivelando le
contraddizioni dell’ideologia. Nel rendersi visibile, e
nell’oltrepassare il racconto, lo stile porterebbe in superficie, così
come il sintomo, dei contenuti latenti. Si tratta di un «controcinema» che mette in discussione, attraverso codici stilistici ed
espressivi, il progetto formale del film classico. Questo secondo
tipo di testo, di cui il family melodrama degli anni cinquanta
costituisce un nucleo importante, è il subversive text12.
Il saggio di Thomas Elsaesser Tales of Sound and Fury (1972)
costituisce la prima articolata interpretazione del «film
sovversivo». Dedicato al family melodrama degli anni cinquanta,
l’intervento di Elsaesser ha un ruolo di primo piano, in quanto
apre un vero e proprio campo di ricerca: a partire dalla centralità
che rivestono nel dibattito su film classico/film sovversivo, gli
studi sul melodramma rimarranno nei decenni successivi un luogo
privilegiato nelle elaborazioni teoriche e metodologiche sul
cinema hollywoodiano. Anzi, come speriamo di chiarire in seguito,
si può affermare che la dialettica tra classico e melodrammatico
sia il nucleo teorico forte di quasi tutti i modelli di interpretazione
sul film americano e che, a partire da questo elemento, sia
possibile spiegare gli snodi più interessanti nel modo di affrontare
il tema13.
Elsaesser evoca la tradizione melodrammatica a teatro e nel
romanzo sottolineando che, in linea con questa tradizione, il
melodramma hollywoodiano è costruito sulla discontinuità,
«sull’evidenza di crepe e rotture nel tessuto dell’esperienza e sul
richiamo alla realtà della psiche»14. La forma melodrammatica si
manifesta in periodi di cambiamenti sociali che mettono in crisi
l’esperienza soggettiva. Le variazioni tonali del melodramma
esprimono sia tali cambiamenti che le diverse modalità tramite cui
gli individui li vivono. In virtù della necessità di esprimere stati
emotivi e psichici, il melodramma poggia sull’intensità, resa
formalmente da codici visivi e musicali, a scapito del linguaggio
verbale che qui ha una minore rilevanza15. Secondo Elsaesser,
l’intensità e l’eccesso stilistico del melodramma, che significano
oltre l’azione e il linguaggio, costituiscono un’indicazione assai
chiara dell’uso cosciente «dello stile come significato», il tratto
che definisce «la sensibilità modernista all’opera nella cultura
popolare»16. Dunque, dietro la spettacolarità delle immagini e la
forza dell’emozione, il melodramma hollywoodiano attiva
un’operazione sovversiva, in cui l’esperienza spettatoriale diventa
la presa di coscienza critica dei valori espressi dal film.
Il lavoro di analisi compiuto in quegli anni porterà molti
studiosi a scovare all’interno del cinema classico una miriade di
«testi sovversivi». Una ricognizione sulla tipologia di questi film
mi ha portato a due conclusioni: da un lato che, a parte pochi casi
eccellenti, i film sovversivi sono prodotti negli anni quaranta e
cinquanta, dall’altro che appartengono sostanzialmente a tre
generi, il family melodrama degli anni cinquanta, il noir e il
woman’s film del decennio precedente. È soprattutto su queste
opere che negli anni settanta e ottanta si è affinata l’analisi del
film. Con l’affermarsi della Feminist Film Theory, la nozione di film
sovversivo viene declinata nella prospettiva di gender.
«FEMINIST FILM THEORY» E CINEMA CLASSICO: PERDITA E RICONQUISTA DEL
PIACERE
Nella doppia veste di concetto teorico e pratica analitica il
binomio classic realist e subversive ha contribuito in modo
determinante anche allo sviluppo della Feminist Film Theory (FFT).
Poiché il film sovversivo è un testo parzialmente aperto e dalle
dinamiche identificative molteplici, esso è divenuto un modello di
riferimento per le femministe che sono riuscite a cogliere, in molti
film del periodo classico, elementi di autonomia del femminile.
Nell’ambito della FFT, la nozione di film sovversivo viene
inizialmente proposta da Claire Johnston e Pam Cook a metà anni
settanta. Le due autrici partono dalla lettura che Lacan fa di LéviStrauss a proposito del funzionamento dei sistemi di parentela
nell’elaborazione del rapporto tra soggetto e simbolico. La
parentela è una struttura regolata da un sistema di scambio che è
anche un sistema di comunicazione attraverso cui uomini e donne
vengono posizionati: in questo sistema sono sempre gli uomini che
scambiano le donne. Pertanto, le donne diventano un segno che
circola assicurando la comunicazione tra uomini, clan, gruppi ecc.
Nella lettura lacaniana, tale sistema di scambio viene applicato al
complesso edipico: così la donna come segno sta a significare,
innanzitutto, il non-uomo, la differenza, la mancanza e, quindi, la
castrazione17. Il tipico film classico è fondato su questo modello,
sull’asimmetria tra maschile e femminile18. Tuttavia, ponendosi
sulla scia di Comolli e Narboni, Johnston si chiede anche se sia
possibile, per un regista di Hollywood, assumere una posizione
critica nei confronti del sistema dominante. Il gesto critico
dell’autrice consiste nell’appropriarsi di questa suggestione
teorica e di riformularla in chiave femminista: esistono, cioè,
all’interno del cinema hollywoodiano, subversive films in relazione
alla differenza sessuale, all’articolazione del rapporto
maschile/femminile? Come si rintracciano sul testo queste
operazioni? È dunque possibile un controcinema all’interno del
sistema? Johnston nota che nei film di Dorothy Arzner e Ida
Lupino, le uniche registe donne del periodo classico, vi è una
frattura tra ideologia e testo: esse «cercano attraverso espedienti
formali di produrre uno iato tra ideologia sessista e testo del
film»19. In particolare, nel cinema di Arzner è iscritto uno
specifico discorso femminile che sovverte e contraddice quello
maschile20. In film come Merrily We Go to Hell (1932) e Dance,
Girl, Dance (1940), l’operazione sovversiva viene assicurata da
strategie retoriche che rompono l’identificazione della spettatrice
promuovendo invece la comprensione dei meccanismi narrativi e
ideologici21.
La perdita del piacere a favore della riflessione è uno dei tanti
punti di contatto tra la posizione di Johnston e Cook e il più
famoso e influente intervento di Laura Mulvey, Visual Pleasure
and Narrative Cinema, pubblicato nel 1975 su «Screen».
Nonostante il concetto di subversive text abbia fortemente
influenzato gli studi femministi, è indubbio che Piacere visivo e
cinema narrativo rimane, a trent’anni dalla sua pubblicazione,
l’intervento più importante della FFT. Se è vero che alcuni
fondamentali concetti sono presenti in Johnston e Cook, per
esempio la donna come mancanza e come spettacolo, il ruolo dello
sguardo nella rappresentazione filmica, è anche vero che spesso
essi vengono più enunciati che spiegati: mancano alcuni passaggi
esplicativi, così che la proposta spesso rimane a livello di
suggestione senza trasformarsi in effettivo modello teorico, ruolo
che compete invece a Piacere visivo. La forza e l’efficacia
argomentativa con cui Mulvey propone una teoria psicoanalitica
non solo del film classico, ma anche dell’apparato cinematografico
e dell’esperienza spettatoriale, colpiscono ancora oggi. In
particolare, Mulvey teorizza la centralità dello sguardo
nell’esperienza cinematografica: ovvero, lo sguardo è il vettore del
funzionamento dell’apparato, del rapporto spettatore/schermo e
delle dinamiche diegetiche del testo filmico.
La tesi centrale del saggio investe la relazione di omogeneità
che esisterebbe tra le dinamiche psichiche del soggetto umano,
come le ha spiegate la psicoanalisi freudiana, il dispositivo
cinematografico e le strutture narrative e linguistiche del film
classico. Il cinema hollywoodiano iscrive, tramite strategie formali
altamente codificate, la differenza sessuale, replicando così il
rapporto di subordinazione del femminile verso il maschile che
caratterizza la società patriarcale e che Freud ha descritto in
molti suoi interventi22. In primo luogo, il piacere visivo
dell’esperienza cinematografica si fonda sull’attivazione di due
pulsioni del guardare contraddittorie, il voyeurismo e il
narcisismo. Queste dinamiche, tuttavia, non sono ugualmente
disponibili per lo spettatore e per la spettatrice, in quanto il
cinema classico ha iscritto la differenza sessuale nelle sue
strategie retoriche e, conseguentemente, nell’esperienza
spettatoriale. Nel film classico «il piacere del guardare è stato
scisso in attivo/maschile e passivo/femminile»: la funzione della
donna è puramente erotica e si esaurisce nel sostenere il
desiderio maschile, motore dell’azione narrativa. Così il rapporto
attività/passività è registrato sia a livello narrativo che retorico:
mentre l’azione diegetica viene condotta dal personaggio
maschile, la soggettiva è la figura che meglio mette in scena il
ruolo attivo dell’uomo. Grazie alla tecnica cinematografica –
profondità di campo, movimenti di macchina, montaggio – «il
protagonista maschile è libero di imperare sulla scena, una scena
di illusione spaziale in cui egli articola lo sguardo e crea
l’azione»23. In sintonia con le elaborazioni più avanzate del
periodo, Mulvey riscontra, nei meccanismi dello spettacolo
cinematografico e nelle tecniche filmiche del cinema classico,
dispositivi che attivano nello spettatore le dinamiche inconsce
studiate dalla psicoanalisi. Ma, diversamente da Baudry e Metz24,
per i quali l’esperienza cinematografica non è sessualmente
definita, Mulvey afferma che la differenza di gender è iscritta non
solo nella rappresentazione filmica, ma anche nell’esperienza
cinematografica. Il cinema classico è costruito per il solo piacere
dello spettatore maschile: se l’identificazione è il riconoscimento
di sé nell’immagine del proprio simile, è chiaro che, poiché è il
personaggio maschile a dominare la scena, con l’azione e lo
sguardo, solo l’uomo in sala potrà identificarsi con l’eroe. Unendo
il proprio sguardo a quello del personaggio, lo spettatore sarà in
grado di possedere vicariamente la donna. Dunque, la disparità
nella rappresentazione si traduce in una disparità spettatoriale. È
questo il punto più controverso e dibattuto del saggio, cui si
cercherà, a iniziare da Mulvey stessa, di contrapporre una visione
meno negativa dell’esperienza femminile.
Se «per un bel po’ qualsiasi femminista che scrivesse sul
cinema si sentiva obbligata a situarsi in relazione a Mulvey»25
cercando di smentirla, il tempo ha ampiamente dimostrato la
centralità di questo saggio nell’ambito degli studi cinematografici.
Così come è del tutto evidente che le critiche mosse in quegli anni
sono state prontamente accolte dall’autrice che, in un saggio del
1981, ha completato la sua proposta teorica. L’importanza di
Piacere visivo sta nel suo impianto teorico di base, ovvero
nell’avere fornito un modello forte di interpretazione del film
centrato sulle dinamiche di sguardo, desiderio e identificazione e
nell’avere sottolineato la non universalità di questi processi,
ovvero la differenza che comportano per il maschile e il femminile,
sullo schermo e in sala. L’eccesso della prima proposta di Mulvey
stava nel non dare alcuno spazio al desiderio e
all’autodeterminazione del soggetto femminile. In Afterthoughts
on «Visual Pleasure and Narrative Cinema» Inspired by King
Vidor’s duel in the Sun (1946), Mulvey offre un’ipotesi alternativa
e complementare, ammettendo la possibilità del piacere
femminile. Rifacendosi all’interpretazione freudiana della
sessualità, afferma che il cinema classico in realtà permette alla
spettatrice di identificarsi con l’immagine cinematografica.
Secondo Freud la sessualità femminile preedipica è segnata, come
per il maschio, dall’attività, e solo nell’età adulta dalla passività.
Freud nota che per la donna questo passaggio è particolarmente
difficile e doloroso e che il soggetto femminile tende in età adulta
a regredire alla fase fallica, tanto che la bisessualità caratterizza
le donne molto più degli uomini. È precisamente questa dinamica
che, secondo Mulvey, il cinema hollywoodiano attiverebbe: la
spettatrice può in taluni casi identificarsi con l’eroe in virtù della
regressione alla fase attiva pre-edipica. Il cinema strutturato
attorno al piacere maschile consentirebbe così «alla donna
spettatrice di riscoprire quell’aspetto perduto della sua identità
sessuale, il mai pienamente represso fondamento della nevrosi
femminile.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :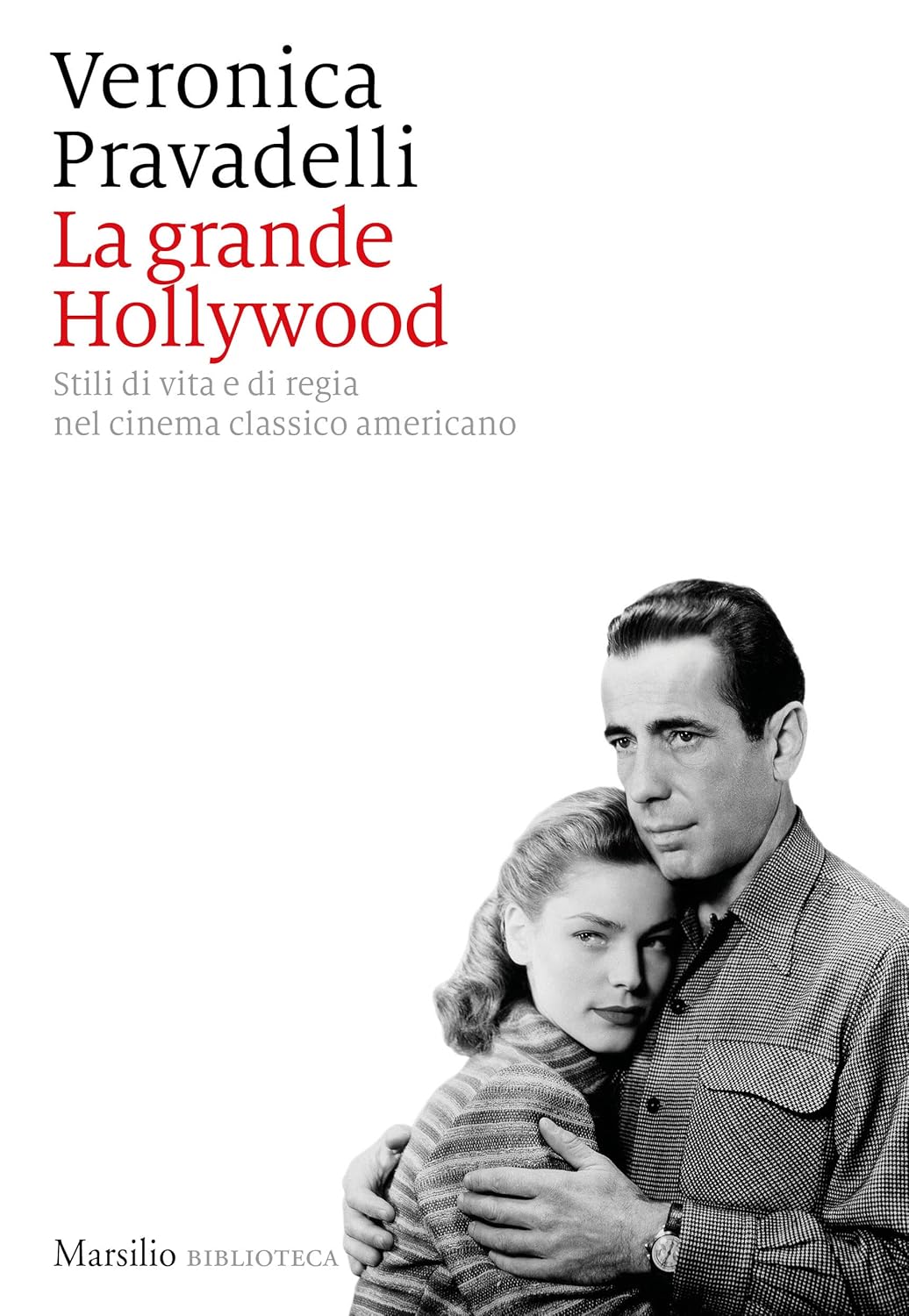






Commento all'articolo