Kim – Rudyard Kipling
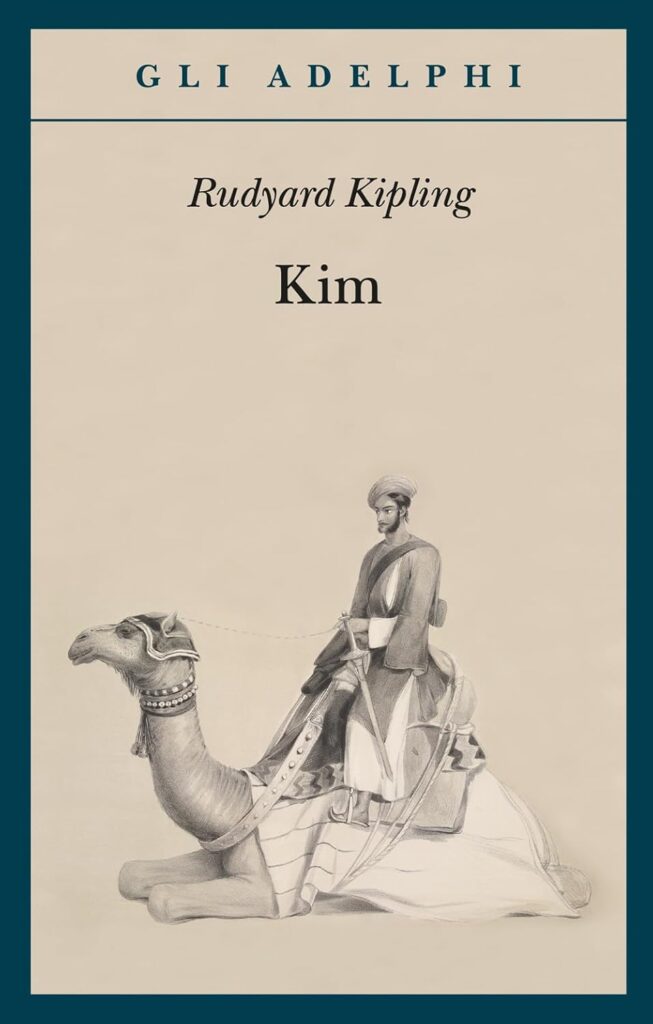
SINTESI DEL LIBRO:
Era seduto, in barba alle ordinanze municipali, a cavallo
del cannone Zam-Zammah che su un basamento di mattoni
fronteggiava il vecchio Ajaib-gher, la Casa delle Meraviglie,
come gli indigeni chiamano il museo di Lahore. Chi detiene
Zam-Zammah, il «drago sputafuoco», tiene il Punjab, e quel
gran pezzo di bronzo verde è sempre stato la preda più
ambita dal conquistatore.
A parziale giustificazione di Kim – che aveva cacciato il
figlio di Lala Dinanath giù dall’affusto – c’era il fatto che gli
inglesi tenevano il Punjab, e Kim era inglese. Pur essendo
un tizzo nero almeno quanto un indigeno; pur parlando di
preferenza il vernacolo, e la lingua madre con un’incerta,
zoppicante cantilena; pur facendo comunella su un piano di
perfetta parità con i ragazzini del bazar, Kim era bianco...
un bianco povero fra i più poveri. La mezzosangue che
badava a lui (fumava oppio e faceva mostra di tenere una
bottega di mobili usati vicino alla piazza dove stazionano le
vetture da nolo a buon mercato) raccontava ai missionari di
essere la sorella della madre di Kim; in realtà, la madre del
ragazzo aveva fatto la bambinaia presso la famiglia di un
colonnello e aveva sposato Kimball O’Hara, giovane
sergente portabandiera dei Maverick, un reggimento
irlandese. In seguito O’Hara aveva trovato impiego alla
Sind, Punjab and Delhi Railway, e il reggimento era tornato
in patria senza di lui. La moglie era morta di colera a
Ferozepore e O’Hara si era messo a bere e a vagabondare
su e giù lungo la linea ferroviaria assieme al figlio, un
bimbo di tre anni con due occhi vispi. Istituti e cappellani,
preoccupati per il piccolo, avevano cercato di sottrarglielo,
ma O’Hara aveva preso il largo fino a quando, incontrata la
donna che faceva uso di oppio, ci aveva preso gusto anche
lui ed era morto come muoiono i bianchi poveri in India. Al
momento del decesso il patrimonio consisteva in tre
documenti: uno che chiamava il suo «ne varietur», dalle
parole sotto la sua firma in calce al testo, e un altro il suo
permesso di trasferimento da una loggia all’altra. Il terzo
era l’atto di nascita di Kim. Quelle cose, non si stancava di
ripetere nell’ebbrezza dell’oppio, avrebbero comunque
fatto un uomo del piccolo Kimball. A nessun costo Kim
doveva separarsene, giacché rientravano in una grande
magia, magia come quella esercitata dagli uomini laggiù
dietro il museo, nel grande Jadoo-gher bianco e turchino: la
Casa Magica, come chiamiamo noi la Loggia Massonica. Un
giorno, diceva, tutto sarebbe andato a finir bene, e il corno
di Kim sarebbe assurto in gloria fra due pilastri, due
pilastri portentosi per bellezza e possanza. Il colonnello in
persona, cavalcando in testa al più bel reggimento del
mondo, si sarebbe preso cura di Kim... del piccolo Kim, al
quale sarebbe toccata miglior sorte che al padre.
Novecento diavoli di prim’ordine, che adorano un Toro
Rosso in campo verde, si sarebbero presi cura di Kim, se
non avevano dimenticato O’Hara... il povero O’Hara,
caposquadra sulla linea di Ferozepore. A quel punto, sulla
sedia di giunco sgangherata in veranda, versava amare
lacrime. Così, dopo la sua morte, la donna cucì pergamena,
nullaosta e atto di nascita in un astuccio di avorio per
amuleti che appese al collo di Kim.
«E un giorno» disse, ricordando confusamente le profezie
di O’Hara «verrà a cercarti un Toro Rosso in campo verde,
e il colonnello sul suo alto cavallo, sì, e poi» passando
all’inglese «novecento diavoli».
«Ah, me ne ricorderò» disse Kim. «Verranno un Toro
Rosso e un colonnello a cavallo; prima, però, diceva mio
padre, verranno i due uomini a preparare il terreno. Mio
padre diceva che così si è sempre fatto; ed è sempre così
quando gli uomini praticano la magia».
Se la donna avesse mandato Kim al Jadoo-gher locale con
quelle carte, sarebbe stato accolto senza meno dalla Loggia
Provinciale e mandato all’orfanotrofio massonico sui monti;
ma per quanto ne sapeva lei, della magia non c’era da
fidarsi. E anche Kim la vedeva a modo suo. Giunto all’età
dell’indiscrezione, aveva imparato a evitare i missionari e i
bianchi dall’aria seriosa che gli chiedevano chi era e cosa
faceva. Perché Kim non faceva niente, e con enorme
successo. Certo, conosceva la meravigliosa città murata di
Lahore, da Delhi Gate fino all’estremità di Fort Ditch; se la
faceva con tizi che conducevano un’esistenza più bizzarra
di qualunque fantasia di Harún ar-Raschid, ed era a sua
volta immerso in una vita avventurosa degna delle Mille e
una notte, ma missionari e segretari degli istituti di carità
erano ciechi a tanta bellezza. Per i rioni era
soprannominato «il Piccolo Amico di tutto il Mondo»; e
siccome era un’anguilla e non dava nell’occhio, spesso e
volentieri eseguiva commissioni notturne sui tetti affollati
per conto di bellimbusti impomatati e lustri. Si trattava
neanche a dirlo di tresche amorose – fin lì ci arrivava, lui
che del male già sapeva tutto da che aveva l’uso della
parola –, ma ad attirarlo era il gioco per il gioco: aggirarsi
furtivo al buio per vicoli e canali di scolo, arrampicarsi su
per un condotto dell’acqua, suoni e immagini del mondo
femminile sulle tettoie piatte, e fughe a precipizio di tetto
in tetto col favore delle tenebre infuocate. Poi, accanto ai
loro tempietti di mattoni sotto gli alberi in riva al fiume,
c’erano i santoni, i fachiri cosparsi di cenere con i quali era
in grande intimità: li accoglieva al ritorno dalla questua e,
quando in giro non c’era nessuno, mangiava dallo stesso
piatto. La donna che badava a lui lo scongiurava con le
lacrime agli occhi di vestire all’europea: calzoni, camicia e
un cappello acciaccato. Kim trovava più comodo infilarsi
panni indù o maomettani per sbrigare certi affari. Uno dei
bellimbusti – quello trovato morto in fondo a un pozzo la
notte del terremoto – una volta gli aveva dato un completo
indù, un costume da monello di bassa casta, e Kim lo
custodiva in gran segreto sotto una catasta di legname nel
deposito di Nila Ram, dietro l’Alta Corte del Punjab, dove i
tronchi profumati di deodara, dopo aver disceso il Ravi,
sono tenuti a stagionare. Quando c’era da brigare o da
spassarsela, Kim sfoggiava la tenuta, tornando sul far del
giorno alla veranda, stanco morto per essersi sgolato sulla
scia di un corteo nuziale o sganasciato a una festa indù. In
casa alle volte c’era da mangiare, ma più spesso no, e così
Kim usciva di nuovo per rimediare qualcosa con i suoi
compari indigeni.
Mentre tamburellava coi calcagni contro Zam-Zammah,
ogni tanto smetteva di giocare a re del castello con il
piccolo Chota Lal e con Abdullah, il figlio del venditore di
dolciumi, per lanciare un’insolenza al poliziotto indigeno di
guardia alla fila di scarpe sulla soglia del museo. Il grosso
punjabi sfoderava un sorriso tollerante: conosceva Kim da
sempre. Come l’acquaiolo, che riversava il liquido dall’otre
di pelle di capra sulla via riarsa. Come Jawahir Singh, il
falegname del museo, chino sulle nuove casse da
imballaggio. Come tutti nei paraggi, a parte i contadini
accorsi dalla campagna alla Casa delle Meraviglie per
ammirare i prodotti fabbricati nella loro provincia e altrove.
Il museo era dedicato alle arti e ai manufatti indiani, e a
chiunque cercasse lumi bastava rivolgersi al conservatore.
«Dài, togliti di lì! Fammi salire!» strillava Abdullah,
arrampicandosi sulla ruota di Zam-Zammah.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :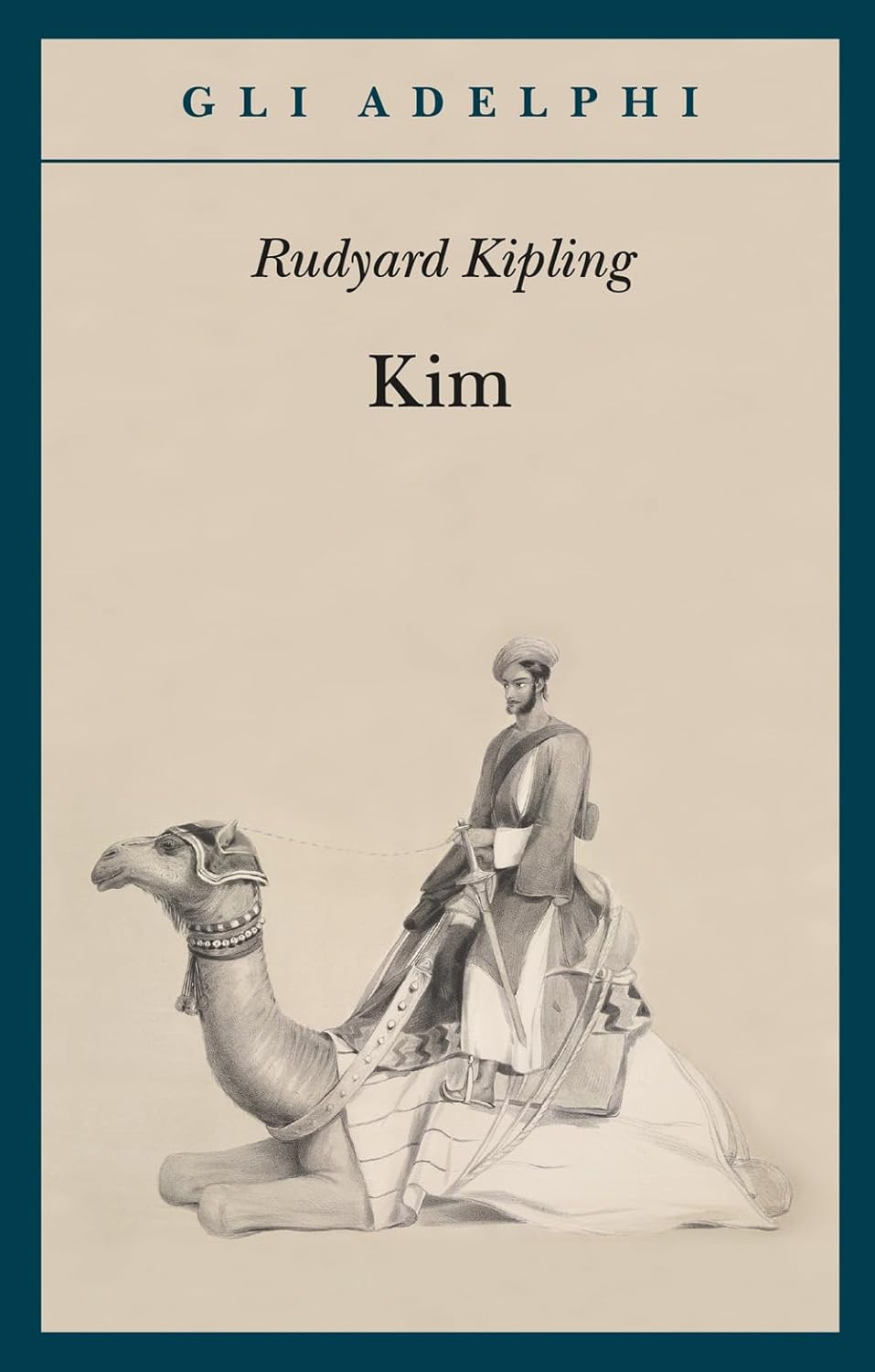






Commento all'articolo