Il sovversivo: Concetto Marchesi e il comunismo italiano – Luciano Canfora
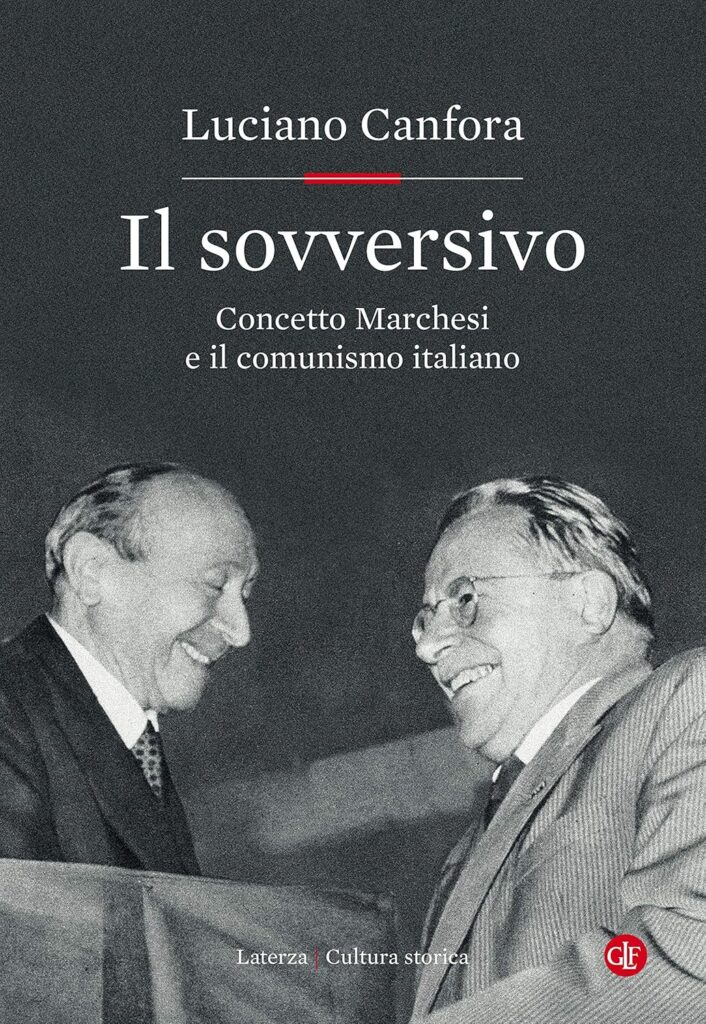
SINTESI DEL LIBRO:
La vita di un ‘capo’ dev’essere esemplare. Almeno due dirigenti
comunisti sono stati perciò «contadinizzati» dalla leggenda di partito:
Antonio Gramsci e Concetto Marchesi. Poiché l’architrave della
strategia politica del partito era il «blocco storico» dell’alleanza tra
operai (soprattutto del Nord) e contadini (soprattutto del Sud)1 –
s’intende col contributo attivo degli intellettuali «organici» –,
l’intellettuale meridionale comunista doveva essere, preferibilmente,
di origine contadina. Così il latinista, prosatore, parlamentare
Concetto Marchesi (1878-1957), discendente dal marchese
Benedetto Gioeni, duca d’Angiò2
, diventò, nella commemorazione
che ne fece Umberto Terracini al Senato della Repubblica, il 14
febbraio 1957, «nato di popolo, da famiglia contadina», o, al più,
nella visione più nuancée di Palmiro Togliatti «di ambiente piccoloborghese».
Le parole di Terracini esaltavano l’origine popolana ponendola in
relazione col grande prestigio conseguito da Marchesi nel corso
della sua vita:
«Non li aveva carpiti – così si espresse l’oratore – i titoli che erano l’esterna insegna delle
luminose conquiste del suo ingegno e della sua coscienza; e neanche li aveva avuti in dono
dalla sorte. Nato di popolo, da famiglia contadina, egli era infatti salito a fama universale nel
mondo dei maggiori studi [= le lingue classiche, intende] e fra la gente più umile solo per le
sue virtù»3.
Essendo siciliano, di Catania, Marchesi doveva anche aver
partecipato alle ‘lotte contadine’ nonché ad abundantiam, ai fasci
siciliani. E siccome, per un ‘reato di stampa’ – l’elogio degli anarchici
parigini –, compiuto da lui quando aveva sedici anni, aveva subìto (al
compimento del diciottesimo anno di età) un mese di detenzione,
tale periodo di detenzione divenne – nella leggenda – il carcere
subìto appunto per aver preso parte alle lotte contadine e/o ai fasci
siciliani.
La prima traccia scritta di questa leggenda è dovuta a Cesare
Musatti, figlio di Elia Musatti (deputato socialista veneziano fino al
1929) e collega di Marchesi a Padova (1928-1938) nonché
promotore della psicanalisi in Italia. Intervenendo per ben due volte
sull’«Avanti!» (17 e 21 febbraio 1957) nella polemica suscitata,
all’indomani della morte di Marchesi, da un intervento limitativo di
Ludovico Geymonat4
, Musatti scrisse tra l’altro: «Geymonat non era
ancora nato quando Marchesi era in carcere per la sua
partecipazione ai moti dei contadini siciliani»
5
.
Far quadrare i dati anagrafici di Marchesi (classe 1878) con i fasci
siciliani non era facile. Un conterraneo e amico socialista di
Marchesi, il deputato catanese Gaudioso (classe 1891),
intervenendo anche lui nelle commemorazioni parlamentari di
Marchesi – in questo caso, alla Camera – nello stesso giorno in cui
Terracini parlava al Senato, se la cavò così: «Dai documenti del mio
archivio [risulta] la venuta di Amilcare Cipriani a Catania nel marzo
del 1891, dopo il congresso socialista di Capolago, e il comizio
catanese del 24 marzo. Fra gli ascoltatori vi era un giovanetto
tredicenne, Concetto Marchesi»6
. E aggiunge: «Me lo ha
confermato». Prezioso riferimento che fa luce su di un fenomeno che
ci dovrà interessare: che cioè, fonte era stato, per lo più, Marchesi
medesimo7
. Ne è conferma quel che raccontò, diffusamente, con
lievissimi appannamenti di memoria, Cesare Musatti – trent’anni
dopo il suo precedente intervento – nell’ultimo suo libro (Chi ha
paura del lupo cattivo?, Editori Riuniti, Roma 1987) a carattere
memorialistico e pubblicato quasi in limine mortis. Lì Musatti rievoca
di aver frequentato assiduamente Marchesi, nel 1930/1931, – in
particolare nella trattoria padovana del padre dell’esule repubblicano
Plinio Odoardo Masini – e di aver appreso da Marchesi, in tali
quotidiane conversazioni ‘conviviali’, il racconto della sua vita, in
particolare degli esordi siciliani8
.
Più prudente di tutti, Togliatti, peraltro buon esperto delle
costruzioni biografico-leggendarie di partito (da Gramsci a Stalin), il
quale – nella commemorazione di Marchesi alla Camera – preferì
non parlare affatto di questo presunto coinvolgimento rivoluzionario
di Marchesi giovanissimo, ma parlò piuttosto della «visione diretta
della quotidiana fatica e pena dei lavoratori che gli [a Marchesi] dette
il primo impulso a quella concezione del mondo, a quei compiti di
lavoro e di lotta ai quali fino all’ultimo è rimasto fedele»9
. A Togliatti,
Marchesi non può aver millantato una preziosa ‘origine’ o addirittura
militanza contadina. Lo si ricava dal seguito della commemorazione
togliattiana, che, dopo un’ampia citazione dal brano più famoso e più
verghiano dello scritto di Marchesi Perché sono comunista (5
febbraio 1956)10 – «Filari e filari di viti dentro un’ampia cerchia di
mandorli e di ulivi, e un suono di corno che radunava le
vendemmiatrici. Vigilavano i guardiani etc.» – commenta: «Così
entra nella vita sua, dalla prima puerizia, la penosa realtà della vita
degli uomini che vivono soltanto del loro lavoro. L’offesa fatta a
questi uomini [le vendemmiatrici] egli sente come offesa sua, e
cresce in lui, nel distacco dall’ambiente borghese e piccolo
borghese, l’animo dell’oppresso».
Anche per Togliatti, fonte è Marchesi stesso; in particolare nel
riferimento ad un presunto ambiente familiare «piccolo borghese»
(non più contadino). Ma anche nella rievocazione delle
frequentazioni ‘popolari’ di lui (delle quali Togliatti può aver avuto
solo in parte conoscenza diretta): «Studioso, universitario, scrittore,
giunto alle cime più alte della più eletta delle culture, accademico dei
Lincei, parlamentare di prestigio, diresti che l’animo suo si distenda
solo nel colloquio fraterno con l’uomo semplice, col diseredato, col
povero: il pescatore del Cavo dell’isola d’Elba, il popolano delle
osterie di Trastevere, il rude [?] operaio di Marghera, il fraticello che
coltiva la terra del convento e che ogni anno egli va a cercare, e
discorrono e s’intendono, anche senza parlare, delle cose
supreme».
2.
Per quel che attiene alla cronologia, Togliatti si mantiene sul vago,
sulla approssimazione per decenni: «Al movimento operaio e
socialista aveva aderito in anni lontani, sin dal 189511
, in quell’ultimo
decennio del secolo passato in cui al socialismo venivano gli animi
più nobili e nella Sicilia, dove egli era nato, le masse lavoratrici
impegnavano memorabili lotte per la loro emancipazione».
All’origine vi è, probabilmente, la prima redazione, che Marchesi
pubblica sul settimanale di partito «Vie Nuove» nell’ottobre 1949, del
Perché sono comunista (titolo: L’animo dell’oppresso). In quella
prima redazione, dopo l’intera pagina riutilizzata sei anni dopo («filari
e filari di viti etc.») e dopo il cenno alle sue letture formative (Mazzini,
Proudhon, Marx nel compendio di Lafargue, «poi il gran fascio di
luce, il Manifesto di Londra del ’48»)12
, Marchesi prosegue con
informazioni relative al suo impegno concreto: «Alla lettura di quelle
pagine, una solida gioia empiva l’animo mio. Da allora compresi che
una guerra era cominciata per una infallibile vittoria; compresi che
non esistevano per il proletariato in lotta battaglie perdute. Venne poi
la organizzazione operaia e contadina anche in Sicilia: e lo stato
d’assedio [cioè la repressione dei fasci] e arresti e prigione anche
per me che entravo diciassettenne nelle aule universitarie»13
.
E vi è ancora un altro accenno, al termine dell’intervento del 1949,
che suggerisce una persecuzione direttamente patita in quanto
«combattente» per «il popolo lavoratore»: «Intelligenza, esperienza,
dottrina non bastano ad assicurare al popolo lavoratore i combattenti
della sua causa. Voglio dire: non basta riconoscere e dimostrare
l’ingiustizia quale realtà sociale, bisogna averla patita e patirla come
un’offesa personale».
Entrambe queste frasi («stato d’assedio, arresti e prigione anche
per me»; «bisogna averla patita l’ingiustizia sociale») vengono
soppresse nel riutilizzo che Marchesi fa di questo scritto nel Perché
sono comunista del 1956. In entrambi i passi veniva istituito (sia pure
lasciando aperta la possibilità di una interpretazione meno
impegnativa) un nesso tra la repressione del movimento dei fasci
siciliani ed il suo arresto («arresti e prigione anche per me»). Arresto
che invece – come sappiamo – fu determinato da tutt’altra causa,
dall’apologia di ‘reato’ (elogio degli anarchici parigini) e che
comunque ebbe luogo dopo, quando – nel 1896 – Marchesi aveva
ormai compiuto i 18 anni (prima non era possibile). Vuol dire altro:
che cioè, quando al compimento del diciottesimo anno fu arrestato
per il reato commesso da minorenne, i carabinieri vennero a
prelevarlo all’Università.
Come mai questa autocensura? Forse perché, nel frattempo
(gennaio 1955), Marchesi aveva dovuto fornire un chiarimento
autobiografico al settimanale della Federazione catanese del PCI, «Il
Rinnovamento», a seguito della pubblicazione, in quel settimanale,
di un articolo di tale Enzo Marraro riguardante – come la rivista
precisò – «lontane vicende della lotta politica socialista, che allora
videro appunto l’illustre Maestro e amico»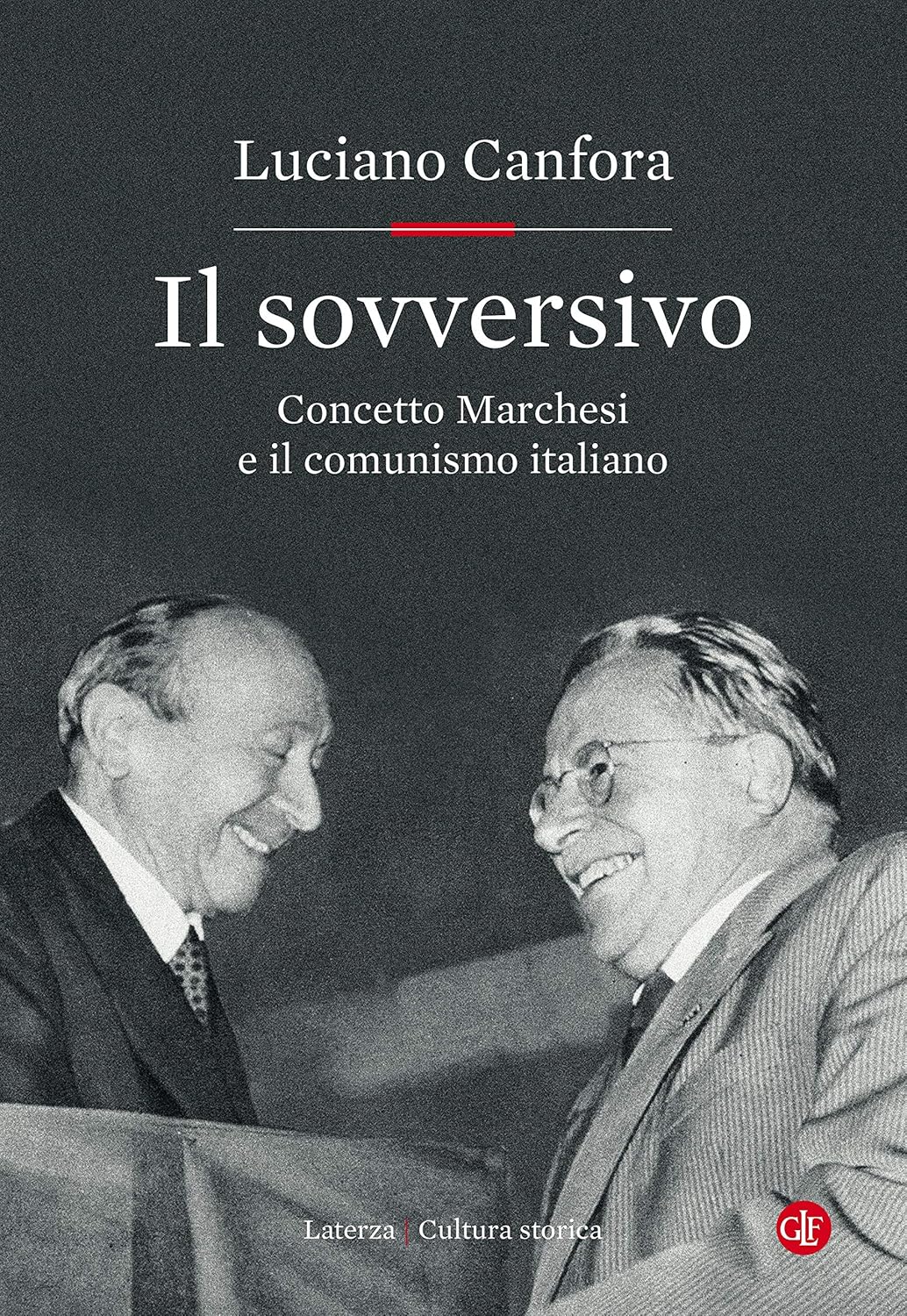






Commento all'articolo