Il matematico indiano – David Leavitt
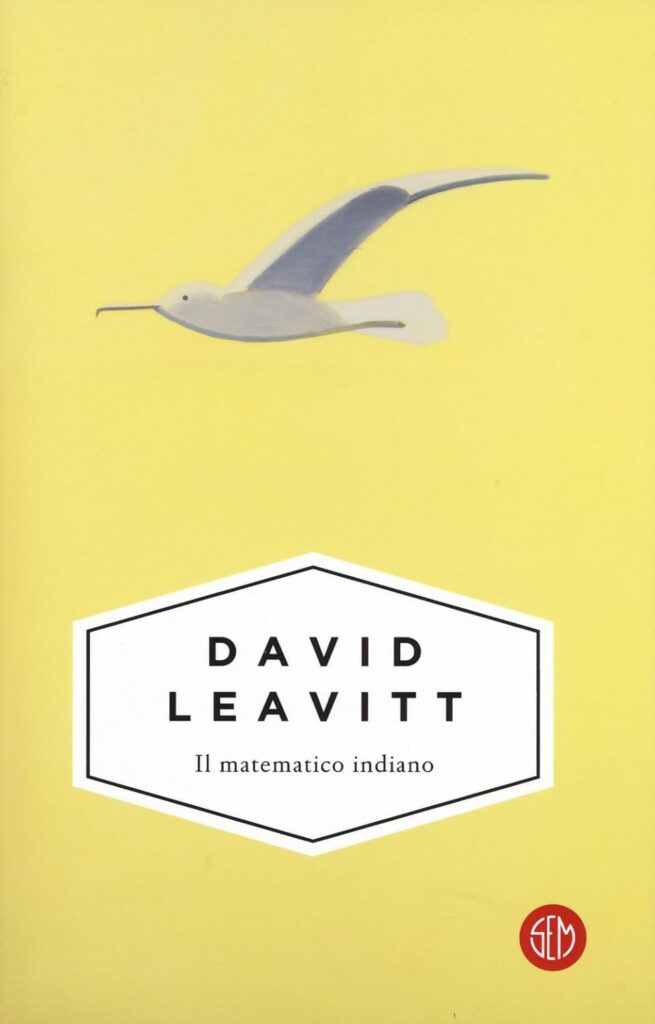
SINTESI DEL LIBRO:
L’uomo seduto accanto al podio
sembrava vecchissimo, almeno agli
occhi dei suoi ascoltatori, per la
maggior parte giovanissimi. In realtà
non aveva ancora sessant’anni. La
sfortuna degli uomini che sembrano
più giovani della loro età, pensava
spesso Hardy, è che a un certo punto
della vita oltrepassano un confine e
cominciano a sembrare più vecchi di
quanto non siano. Quando era uno
studente universitario a Cambridge,
veniva regolarmente scambiato per
un ginnasiale in visita. Quando era
già un docente, veniva regolarmente
scambiato per un laureando. Adesso
l’età lo aveva raggiunto e superato, e
sembrava l’incarnazione dell’anziano
matematico che il progresso si è
lasciato alle spalle. “La matematica è
un gioco per uomini giovani” – lui
stesso avrebbe scritto queste parole
di lì a pochi anni – e per lui era
durato più che per molti altri.
Ramanujan era morto a trentatré
anni. Gli ammiratori odierni,
affascinati dalla leggenda di
Ramanujan, facevano congetture sui
risultati che avrebbe potuto
conseguire se fosse vissuto più a
lungo, ma l’opinione personale di
Hardy era che non avrebbe ottenuto
molto. Era morto lasciandosi il
lavoro migliore alle spalle.
Questo avveniva a Harvard, nella
New Lecture Hall, l’ultimo giorno
d’agosto del 1936. Hardy era uno dei
numerosissimi studiosi convocati da
tutto il mondo per ricevere la laurea
ad honorem in occasione del
trecentesimo anniversario
dell’università. Tuttavia, a differenza
della maggior parte dei partecipanti,
non era lì – e neppure era stato
invitato, intuiva – per parlare del suo
lavoro o della sua vita. Questo
avrebbe deluso il suo pubblico.
Volevano sentirlo parlare di
Ramanujan.
Sebbene l’odore della sala per certi
versi risultasse familiare a Hardy –
odore di gesso, di legno e di fumo di
sigarette stantio – il rumore gli parve
tipicamente americano. Com’erano
più chiassosi dei colleghi britannici,
questi giovanotti! Frugando nelle
loro cartelle, facevano scricchiolare
le seggiole. Mormoravano e
ridevano tra loro. Non indossavano
la toga, ma erano in giacca e
cravatta, alcuni con il papillon. Poi il
professore cui era stato assegnato il
compito di presentarlo – a sua volta
un giovanotto, di cui Hardy non
aveva mai sentito parlare e che gli
era stato presentato solo pochi
minuti prima – salì sul podio e si
schiarì la voce, segnale che fece
zittire il pubblico. Hardy badò a
restare impassibile mentre ascoltava
la propria storia, i premi e le lauree
ad honorem che consacravano la sua
fama. Era una litania cui aveva fatto
l’abitudine, e che non suscitava in lui
né orgoglio né vanità, ma solo noia:
sentir elencare tutte le sue conquiste
non significava niente per lui, perché
quelle conquiste appartenevano al
passato, pertanto, in un certo senso,
non erano più sue. A lui era sempre
appartenuto solo ciò che stava
facendo. E adesso stava facendo ben
poco.
Ci fu uno scroscio di applausi e
Hardy salì sul podio. Il pubblico era
molto più numeroso di quel che
aveva pensato all’inizio. Non solo la
sala era piena, ma c’erano studenti
seduti sul pavimento e in piedi
contro la parete di fondo. Molti di
loro avevano un taccuino sulle
ginocchia e impugnavano una
matita, pronti a scrivere.
“Bene, bene. Chissà cosa ne
penserebbe Ramanujan.”
«Per queste conferenze» iniziò,
«mi sono prefisso un compito
davvero difficile, un compito che, se
fossi deciso a iniziare cercando ogni
scusa per il fallimento, non esiterei a
definire pressoché impossibile. Per
la prima volta, mi trovo a dover
formulare, come non ho mai
veramente fatto finora, e a cercare di
aiutare voi a formulare, una sorta di
valutazione ragionata della figura
più romantica nella storia recente
della matematica…»
“Romantica.” Una parola che si
udiva di rado nella sua disciplina.
L’aveva scelta con cura, e progettava
di usarla ancora.
«Ramanujan è stato una mia
scoperta. Non l’ho inventato io –
come altri grandi uomini, egli ha
inventato se stesso – ma sono stato
la prima persona realmente
competente che abbia avuto la
possibilità di vedere alcuni dei suoi
lavori, e ricordo ancora con
soddisfazione che riuscii a capire
subito che tesoro avevo scoperto.»
Sì, un tesoro. Su questo non c’erano
dubbi. «E suppongo di conoscere
ancora Ramanujan più di chiunque
altro, e di essere ancora la principale
autorità su questo particolare
argomento.» Be’, qualcuno potrebbe
contestarmelo. Eric Neville, per
cominciare. E, a maggior ragione,
Alice Neville.
«L’ho visto e gli ho parlato ogni
giorno per parecchi anni, e
soprattutto ho attivamente
collaborato con lui. Devo più a lui
che a chiunque altro al mondo, con
una sola eccezione, e il mio rapporto
con lui è stata l’unica vicenda
romantica della mia vita.» Guardò il
pubblico. Aveva scandalizzato
qualcuno? Sperò di sì. Alcuni dei
giovani alzarono gli occhi dai loro
appunti e lo guardarono corrugando
la fronte. Uno o due, ne fu certo, gli
lanciarono occhiate solidali.
Avevano capito. Anche “la sola
eccezione” avevano capito.
«Per me dunque la difficoltà non
consiste nel non sapere abbastanza
di lui, ma è di sapere troppo, di
sentire troppo, e di non poter essere
imparziale.»
Ecco, l’aveva detta. La parola:
sentire. Sebbene nessuno dei due
fosse nella sala – uno era morto e
con l’altra non era in contatto da
decenni – dall’ultima fila Gaye e
Alice incontrarono il suo sguardo.
Gaye, per una volta, approvava. Ma
Alice scuoteva la testa. Non gli
credeva.
“Sentire.”
2
La lettera arriva l’ultimo martedì di
gennaio del 1913. A trentacinque
anni, Hardy è un abitudinario. Ogni
mattina fa colazione, poi una
passeggiata nel parco del Trinity
College; una passeggiata solitaria,
durante la quale scalcia la ghiaia dei
vialetti mentre cerca di sbrogliare i
dettagli della dimostrazione a cui sta
lavorando. Se il tempo è bello, pensa
tra sé: “Caro Dio, ti prego, fa’ che
piova, perché non ho nessun
desiderio che il sole entri a fiotti
dalle mie finestre oggi; voglio la
penombra, in modo da poter
lavorare alla luce di una lampada”.
Se il tempo è brutto, pensa: “Caro
Dio, ti prego, fa’ che non torni il sole
perché interferirà con la mia
capacità di lavorare, che richiede la
penombra e la luce di una lampada”.
Il tempo è bello. Dopo mezz’ora,
torna nei suoi appartamenti, che
sono stanze molto belle, come si
confà alla sua fama. Costruite sopra
una delle arcate che fiancheggiano la
New Court, hanno finestre a più luci
con colonnine divisorie, attraverso le
quali può osservare gli studenti che
passano sotto di lui diretti verso la
parte posteriore del college che dà
sul fiume. Come sempre, il suo
servitore, o gyp, come viene
chiamato a Cambridge, ha lasciato le
sue lettere impilate sul tavolino di
legno di rosa accanto all’ingresso.
Niente di interessante oggi, almeno
all’apparenza: alcuni conti, un
messaggio di sua sorella, Gertrude,
una cartolina del suo collaboratore,
Littlewood, con cui condivide la
bizzarra abitudine di comunicare
quasi esclusivamente tramite
cartoline, sebbene Littlewood viva
nel cortile accanto. E poi – vistosa in
mezzo a questa pila di
corrispondenza discreta, quasi
noiosa, ecco la lettera, sgualcita,
voluminosa e piuttosto sporca, come
un immigrante appena sbarcato
dopo un lunghissimo viaggio in
terza classe. La busta è marrone,
coperta da una sfilza di francobolli
sconosciuti. Sulle prime si chiede se
non ci sia stato un errore di
consegna, ma il nome scritto sulla
busta in una calligrafia precisa, il
tipo di calligrafia che farebbe felice
una maestra di scuola, che
piacerebbe a sua sorella, è il suo:
G.H. Hardy, Trinity College,
Cambridge.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :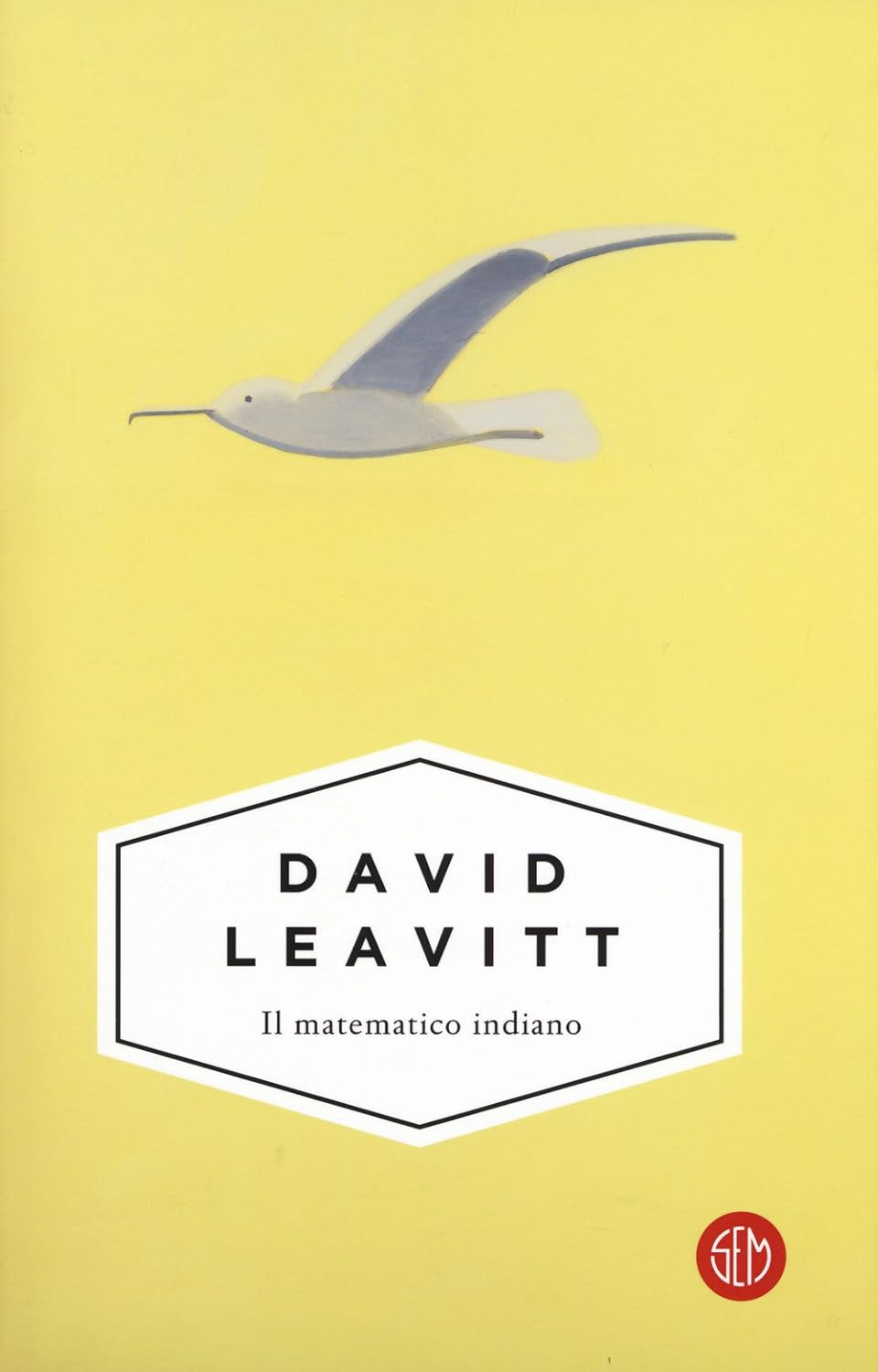






Commento all'articolo