L’inquisizione a Venezia- Riccardo Calimani

SINTESI DEL LIBRO:
La nascita dell’Inquisizione
Difficile dire quando ebbe origine l’Inquisizione, un
fenomeno storico che è durato molti secoli, e si è propagato
in forme differenti in numerosi paesi. Come accade spesso
nelle vicende umane, fu necessaria una lenta maturazione
perché si affermasse all’interno del mondo ecclesiastico una
struttura di questo tipo, le cui radici possono essere
ritrovate nel desiderio della Chiesa, da un certo momento
della sua storia in poi, di combattere i dissidenti con
qualsiasi mezzo, ricorrendo anche alla violenza più estrema,
per imporre a ogni costo, in nome dell’osservanza dei dogmi,
l’uniformità di pensiero e il silenzio su tutte le forme di
dissenso.
1
Intorno all’anno Mille il mondo cristiano era estraneo
all’idea che la Chiesa potesse trionfare e si sentiva come una
cittadella assediata e minacciata: dal mondo musulmano a
sud, dai normanni a nord, dai bizantini a est. Fu solo nell’XI
secolo, quando questi pericoli parevano ormai alle spalle,
che l’ortodossia riprese fiato a causa dell’estendersi di alcuni
sintomi di malessere già esistenti, che si concretizzarono
nello sviluppo impetuoso dell’eresia catara.
L’atteggiamento della Chiesa, tuttavia, anche in quel
periodo continuò a oscillare tra le opposte esigenze del
rigore e della clemenza. I comportamenti repressivi o, al
contrario, ispirati alla tolleranza erano il frutto delle
attitudini di singoli vescovi, di singoli prelati, piuttosto che di
una linea meditata o coerente della gerarchia ecclesiastica.
Molto dipendeva inoltre dallo zelo delle diverse popolazioni e
dal loro atteggiamento, talvolta assai severo, come fu ad
esempio nei confronti dei catari.
Nella seconda metà del XII secolo la diffusione di questa
eresia era giunta al punto che i catari formavano in Europa
meridionale una vera Chiesa alternativa, che si opponeva, da
pari a pari, alla Chiesa di Roma. Verso il 1170 essi si
riunirono in un concilio a Saint Félix de Camaran, nelle
vicinanze di Tolosa, per iniziativa di Niceta, un vescovo
proveniente da Costantinopoli che si diceva seguace del
bulgaro Bogomil.
All’interno della Chiesa molti seguivano gli insegnamenti
di san Bernardo, il quale, impressionato dagli avvenimenti
verificatisi a Colonia nel 1145, quando il popolino aveva
bruciato vivi alcuni eretici, scrisse che questi dovevano
essere convinti con la ragione piuttosto che con la violenza e
che, se fossero rimasti tali, bisognava evitare qualsiasi
contatto con loro. Qualche anno dopo, papa Alessandro III
dichiarò che era meglio perdonare qualche colpevole che
condannare degli innocenti; tuttavia, di fronte all’estendersi
del fenomeno manicheo raccomandò ai principi di
imprigionare gli eretici e di confiscarne i beni.
Queste idee potevano apparire moderate se si pensa che
appena sei anni prima, nel 1157, il concilio di Reims aveva
deciso che il viso dei delinquenti dovesse essere marchiato
con un ferro rovente; questo supplizio, detto dell’ordalia,
cadde a poco a poco in discredito, anche se qualche alto
prelato se ne servì per convincere un gran numero di eretici
a cambiare idea con la sua semplice minaccia, come fece a
Strasburgo il vescovo Enrico di Vehringen nel 1212, anno in
cui papa Innocenzo III ne proibì formalmente l’uso. Nel 1199
lo stesso pontefice, nella sua lotta contro gli albigesi, aveva
respinto l’esilio e la confisca come metodi di lotta, e
nemmeno il famoso Simone di Montfort, nell’editto di
Damiers del 1212, pur lottando con tutte le sue forze contro
gli eretici, arrivò mai a sostenere soluzioni estreme. Il papa
Ottone IV, dal canto suo, nella costituzione del 1220 metteva
al bando gli eretici, confiscava i loro beni e radeva al suolo le
loro case, ma non pensava certo di eliminarli fisicamente e in
maniera sistematica.
Il primo a introdurre l’idea della pena del rogo fu nel 1197
Pietro d’Aragona, mentre Federico II, nella sua costituzione
del 1224, ne perfezionò l’attuazione: gli eretici potevano
essere messi a morte con il fuoco, dopo il taglio della lingua.
La legge, dapprima emanata solo in Sicilia, fu estesa qualche
anno dopo in modo obbligatorio in tutto l’impero e nel 1249
il doge di Venezia, al momento della sua elezione, affermò di
volerli bruciare tutti. Alfonso il Saggio di Castiglia nel 1255
andò più in là in questa tragica progressione e decretò la
pena del rogo per ogni apostata che si fosse fatto ebreo o
islamico in Francia.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
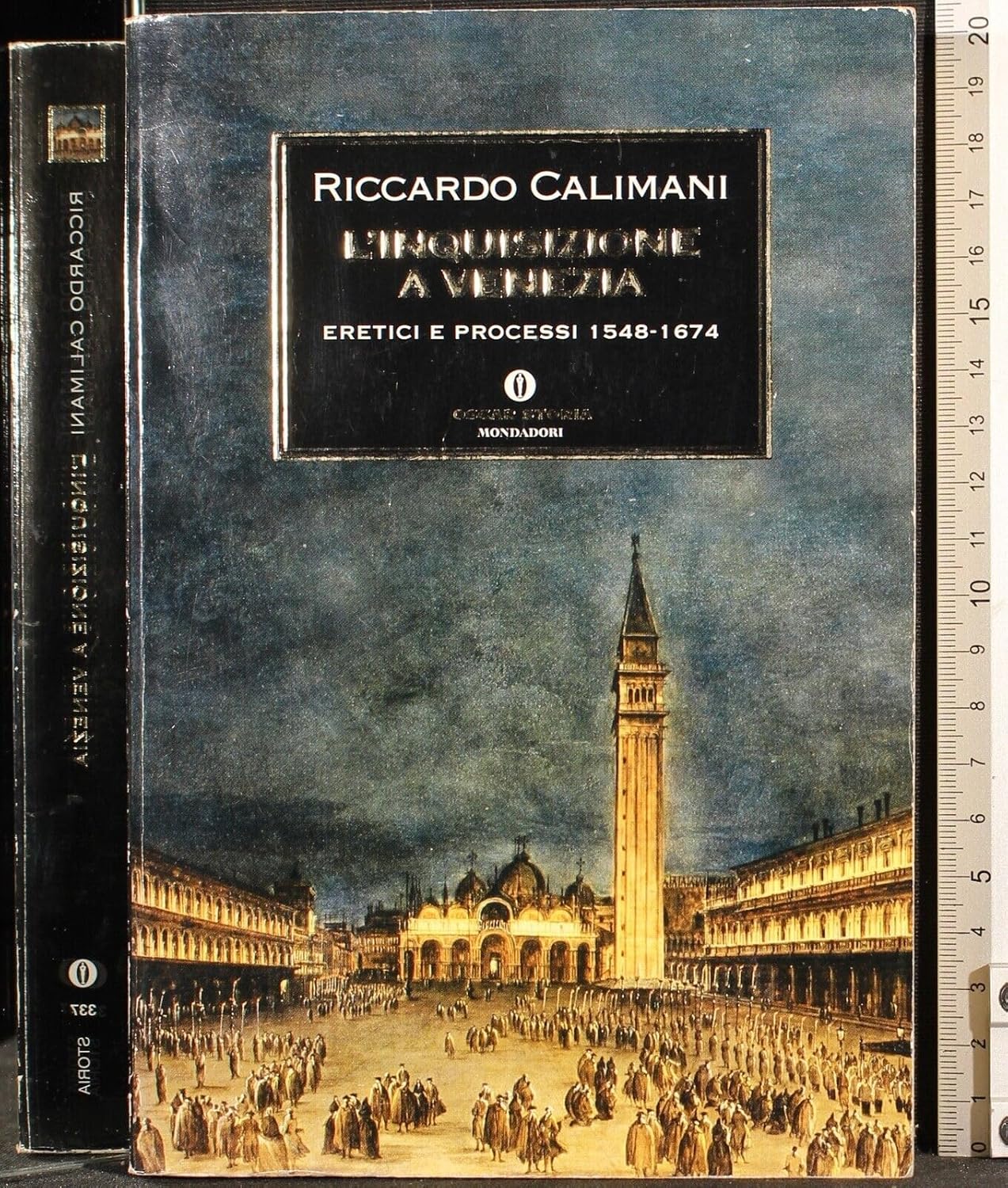






Commento all'articolo