Bella ciao – Marcello Flores
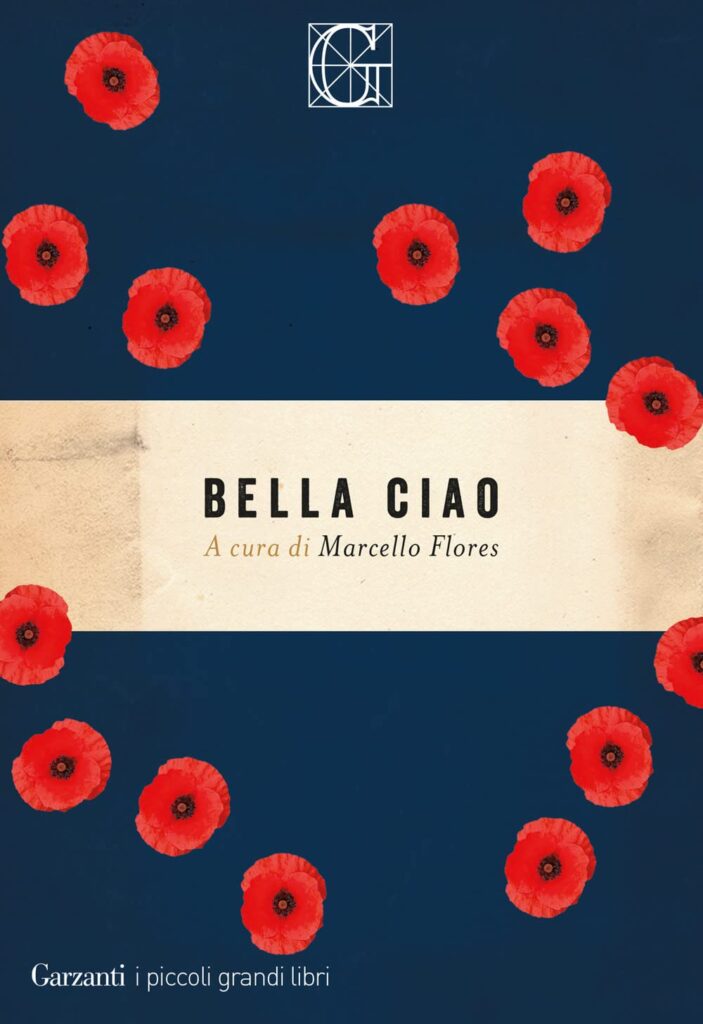
SINTESI DEL LIBRO:
La fortuna di un canto
È difficile, oggi, trovare qualcuno che non sappia cos’è Bella ciao,
che non l’abbia ascoltata, che non la caratterizzi, sia pure in modo
approssimativo, come un canto della Resistenza. Le occasioni per
ascoltarla o cantarla sono tante e si sono moltiplicate proprio negli
ultimi anni: manifestazioni, comizi, funerali, trasmissioni televisive,
film, viaggi della memoria, ma non solo. Il successo planetario di
Bella ciao, oggi, lo si deve a una serie televisiva spagnola – La casa
de papel, storia di una grande rapina – andata in onda dal 2017 e
vincitrice nel 2018 di un International Emmy Award, che ha avuto
grande risonanza non solo in Spagna ma anche in Italia (col titolo La
Casa di carta), Argentina, Brasile. La canzone partigiana, cantata in
italiano, è presente in alcuni passaggi cruciali, sempre a sottolineare
i momenti di felicità e la componente ribellistica del gruppo di
rapinatori. È il capo della banda – il Professore – ad aver imparato
da piccolo Bella ciao da suo nonno, il quale aveva partecipato alla
Resistenza e combattuto i fascisti. Ed è anche grazie al canto
partigiano che la banda di rapinatori – il cui obiettivo, un po’ alla
Robin Hood, è la Zecca di Madrid, simbolo del denaro e del potere –
è vista dal pubblico con simpatia e predisposizione positiva.
Il fatto che una canzone come Bella ciao sia stata utilizzata in
questo modo, tuttavia, già testimonia una sua lunga e radicata
presenza a livello internazionale, accentuata e moltiplicata proprio
dalle due parole che compongono il titolo e che costituiscono una
sintesi perfetta del modo di parlare italiano, dell’identità italiana, della
cultura popolare italiana così come vengono percepiti da un ampio
pubblico. Se si cerca oggi su YouTube Bella ciao, si possono trovare
decine e decine di rifacimenti realizzati negli ultimi mesi e anni in
decine di lingue, interpretati da cantanti singoli e da gruppi, da
rapper e da melodici, da giocatori di calcio (ad esempio Alexander
Pato, ex calciatore brasiliano del Milan, che la canta aggiungendo
«Italia, mi manchi»; ma anche la squadra danese del Brøndby), da
fan della Casa de papel ripresi e immortalati da Netflix per fare
pubblicità alla propria serie in ogni parte del mondo. I brasiliani, del
resto, avevano cantato il ritornello di Bella ciao durante i mondiali di
calcio in Russia, mentre il remix del dj francese Florent Hugel e le
versioni di Steve Aoki e Marnik e di Hardwell & Maddix sono state
viste, dal 2018 a oggi, milioni di volte.
È probabile che molti, tra coloro che l’hanno ascoltata in questi
anni da autori amati dai giovani per altre canzoni e performance, non
sappiano nemmeno che si è trattato di una canzone della
Resistenza e, probabilmente, non siano neppure consapevoli di che
cosa è stata la Resistenza. Un successo universale con numeri così
elevati allarga sempre più la platea di coloro che non hanno alcuna
conoscenza delle origini della canzone, che la cantano spesso in
italiano (almeno il ritornello) senza sapere bene cosa significhi, o che
la cantano nella propria lingua e traduzione con parole che spesso
sono un riadattamento o una rivisitazione del testo del canto
partigiano italiano.
Sbaglierebbe, quindi, chi presumesse che il successo di Bella ciao
vada di pari passo con una maggiore conoscenza di cosa sia stata la
lotta di liberazione in Italia e in Europa, e con una maggiore
consapevolezza dei valori che si fronteggiavano in quel drammatico
frangente di morte ma anche di libertà. In Italia, del resto, dove Bella
ciao è nota, almeno nel titolo, praticamente a tutti, essa ha costituito
spesso il pretesto o è stata il simbolo delle polemiche che
accompagnano ogni anno la celebrazione del 25 aprile, della festa
della Liberazione, considerata da una parte non secondaria, anche
se fortunatamente minoritaria, della società una data divisiva che
sarebbe bene lasciare nell’oblio insieme alla canzone, accusata di
rappresentare l’egemonia comunista sulla Resistenza. Per certi
aspetti la contrapposizione politica e ideologica attorno alla
Resistenza è cresciuta proprio in questo secolo, dando vita a un
conflitto di memorie che tende a ridimensionare il ruolo centrale che
la Resistenza ha avuto nella riconquista della libertà e nella
fondazione di una repubblica democratica e della sua costituzione. E
che non ha evitato di coinvolgere Bella ciao proprio negli anni del
suo inarrestabile successo planetario.
Per la maggior parte degli studiosi che si sono occupati di Bella
ciao, cercando di ricostruirne la storia, le origini, le forme e modalità
di divulgazione, è nel corso dei primi anni Sessanta del Novecento
che questa canzone si sarebbe imposta su un gradino di notorietà e
di diffusione superiore a ogni altro canto partigiano. Cesare Bermani,
uno degli autori che più hanno contribuito a fare emergere la
contraddittoria e ancora non definitiva storia di questo canto, ha fatto
coincidere con la nascita del Nuovo Canzoniere Italiano, nel 1962 –
«sulla scia delle prime ricerche condotte a Torino da Cantacronache,
cioè soprattutto da Emilio Jona, Sergio Liberovici, Lionello Gennero
e Michele L. Straniero» 1 – quel lavoro di ricerca e di raccolta dei
canti partigiani all’interno di una fase nuova di riscoperta del canto
sociale e della cultura popolare.
Il fatto che Bella ciao, in quegli anni, sia diventata la canzone
partigiana più nota, subentrando e sostituendo quelle – come Fischia
il vento – certo più diffuse e cantate nei venti mesi della lotta di
liberazione, sarebbe dovuto a motivi politici, al suo avere come unico
riferimento il tedesco «invasor» e a poter essere accolta, quindi,
come una canzone «unitaria», benaccetta non solo a democristiani e
socialisti ma anche all’esercito e alle associazioni partigiane, negli
anni di costruzione del centro-sinistra in cui sarebbe prevalsa una
«immagine della Resistenza oleografica, retorica, priva di
contraddizioni interne» in seguito rifiutata «da larga parte dei militanti
del Sessantotto e del post Sessantotto». 2
È certamente vero che, nei primi anni Sessanta, era presente,
soprattutto tra i giovani che cercavano di muoversi in alternativa alla
«via italiana al socialismo» promossa dal PCI, una specie di allergia
nei confronti di una visione unitaria e interclassista della Resistenza
(«la Resistenza è rossa e non democristiana» fu uno degli slogan
del Sessantotto); ma è anche vero che proprio negli anni che hanno
preceduto quello della rivolta studentesca Bella ciao si era
caratterizzato per una carica di protesta radicale e alternativa
trovando, con quella connotazione, la sua consacrazione come la
canzone partigiana. È nel 1964, infatti, che viene presentato a
Spoleto, in occasione del Festival dei Due Mondi, uno spettacolo
intitolato Bella ciao, curato da Filippo Crivelli, Franco Fortini e
Roberto Leydi, e dove il canto partigiano viene eseguito in apertura e
chiusura.
Quell’edizione del festival di Spoleto fu al centro di polemiche e
scandali proprio per quello spettacolo, anche se non per la canzone
resistenziale in sé né per la sua versione come canto delle mondine.
Causa ne fu piuttosto l’oltraggio recato alle forze armate e all’onore
dell’Italia – questa l’accusa che portò all’incriminazione – dalla
canzone della prima guerra mondiale O Gorizia tu sei maledetta,
soprattutto in una strofa che non avrebbe dovuto essere cantata,
anche se presente con certezza nel testo: «Traditori signori ufficiali
che la guerra l’avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina
della gioventù». Un abbassamento di voce di Sandra Mantovani
aveva costretto a cantarla Michele Straniero, che la conosceva e la
cantò nella versione nota a tutti, compresa la strofa che non era
stata trasmessa nel copione ufficiale per motivi di opportunità.
Straniero venne denunciato per vilipendio delle forze armate, in
parlamento furono presentate interrogazioni e lo spettacolo diventò,
da quel momento, oggetto di attacchi preordinati di militanti di
estrema destra per boicottarlo e impedirne la diffusione. Bella ciao,
quindi, che dava il titolo allo spettacolo, benché tutt’altro che
«ribelle» nel testo, divenne il simbolo di una protesta radicale
antimilitarista e antifascista che andava in direzione opposta a
un’idea unitaria e moderata della Resistenza.
Quello stesso anno, se posso permettermi un ricordo personale, al
festival della gioventù che si tenne ad Algeri in agosto, i giovani
italiani vicini al PCI, al PSI, al PSIUP ma anche ai movimenti trotskisti e
maoisti, tra le canzoni che cantavano nelle serate collettive ai
compagni degli altri paesi avevano inserito anche Bella ciao,
considerata una canzone «partigiana» alla stregua di quelle
comuniste e socialiste e ritenuta, proprio per le recenti vicende del
festival di Spoleto, un simbolo di radicalità giovanile antifascista.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :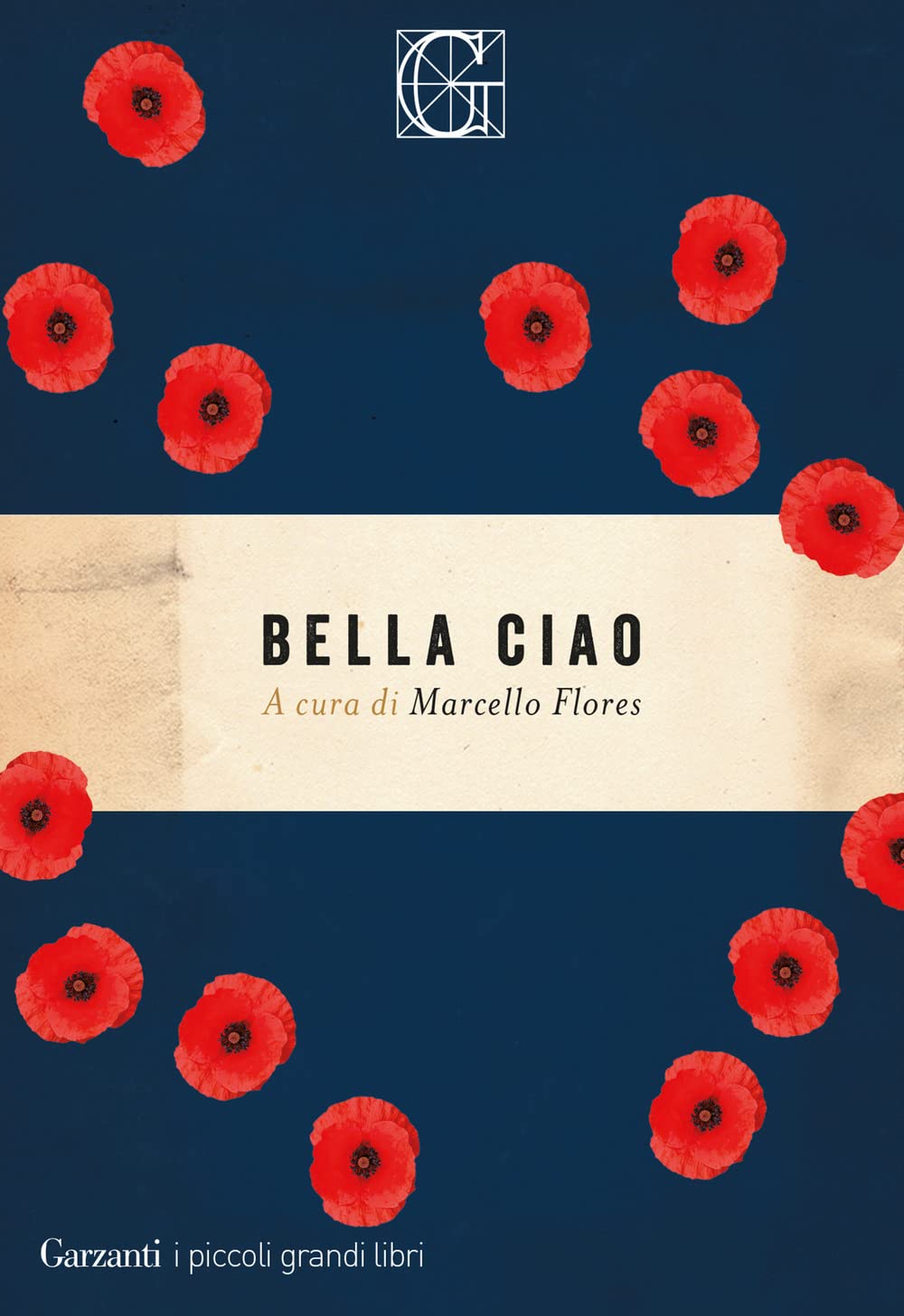






Commento all'articolo