Vedere voci – Oliver Sacks
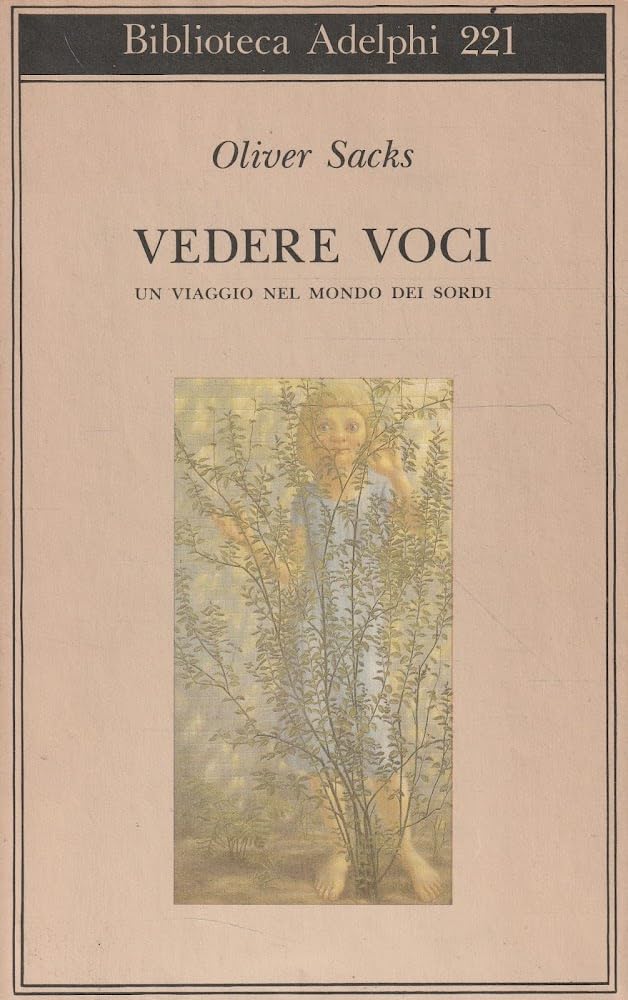
SINTESI DEL LIBRO:
E' sorprendente quanto poco sappiamo sulla sordità, che Samuel
Johnson definì «una delle più disperate tra le calamità umane»;
siamo assai più ignoranti di quanto lo fosse una persona colta del
1886 o del 1786. Ignoranti e indifferenti. Negli ultimi mesi ho
provato a parlare della sordità a un grandissimo numero di persone e
quasi sempre mi sono sentito rispondere frasi come: «La sordità?
Non ci ho mai riflettuto molto, a dire il vero. Non conosco nessun
sordo. Perché, c'è qualche cosa di interessante da sapere sulla
sordità?». Anch'io avrei risposto allo stesso modo, fino a qualche
mese fa.
Le cose cambiarono quando ricevetti un grosso libro scritto da
Harlan Lane, dal titolo "When the Mind Hears: A History of the
Deaf". Lo aprii con indifferenza, che ben presto si trasformò in
stupore, e poi in una sorta di incredulità. Ne parlai a un'amica e
collega, la dottoressa Isabelle Rapin, che da venticinque anni si
occupa dei sordi e della sordità. Feci amicizia con una collega sorda
dalla nascita, una donna molto intelligente e molto dotata, che fino
ad allora non mi aveva incuriosito in modo particolare (1). Cominciai
a vedere, o per la prima volta a osservare attentamente, vari pazienti
sordi che avevo in cura (2). Le mie letture ben presto si estesero dal
libro di Harlan Lane a "The Deaf Experience", una raccolta di
memorie scritte dai primi sordi alfabetizzati (o su di loro), curata
ancora da Lane, poi a "Everyone Here Spoke Sign Language", di Nora
Ellen Groce, e a moltissimi altri libri. Ora un intero scaffale della mia
biblioteca è pieno di testi dedicati a un argomento di cui fino a sei
mesi fa non sospettavo neppure l'esistenza; ho anche visto alcuni dei
notevoli filmati che trattano il problema della sordità (3)
Un ultimo debito, come preambolo. Nel 1969 W. H. Auden mi
aveva dato una copia, la sua copia personale, di "Deafness",
l'interessante autobiografia del poeta e romanziere sudafricano
David Wright, che era diventato sordo all'età di sette anni: «La
troverai affascinante» mi aveva detto. «E' un libro meraviglioso».
Era tutto annotato di suo pugno (non so però se lo ha mai recensito).
Gli diedi una scorsa, ma senza prestargli troppa attenzione. Dovevo
riscoprirlo da solo oggi, dopo vent'anni. Wright non scrive come uno
storico o uno studioso che tratti la propria disciplina: è uno scrittore
che scrive dal profondo della sua esperienza personale. Di più, non lo
sentiamo diverso da noi; ci riesce facile, tutto sommato, immaginare
che effetto farebbe essere al suo posto (mentre non riusciamo a
immaginare se non con grande difficoltà che effetto farebbe essere
sordi dalla nascita, come lo era il famoso insegnante sordo Laurent
Clerc). Così Wright può farci da tramite, e attraverso la sua
esperienza condurci nel regno dell'inimmaginabile. Poiché è più
facile da leggere dei grandi sordomuti del Settecento, è da lui che si
dovrebbe cominciare - perché ci prepara a leggere gli altri. Verso la
fine del suo libro Wright scrive:
«Sulla sordità non è stato scritto molto da parte dei sordi (4). Ciò
malgrado, tenuto conto del fatto che io sono diventato sordo "dopo"
aver imparato a parlare, rispetto a una persona udente non sono in
posizione migliore per immaginare che cosa significhi nascere in un
mondo di silenzio e raggiungere l'età della ragione senza aver
acquisito un veicolo per pensare e comunicare. Basta solo provare a
immaginarlo per sentire tutto il peso delle solenni parole con cui
inizia il Vangelo di Giovanni: "In principio era il Verbo". Come può,
una persona che si trova in tale condizione, formulare dei concetti?»
(5).
Questa relazione tra linguaggio e pensiero è appunto la questione
più profonda, cruciale, che incontriamo quando consideriamo la
sorte che aspetta, o che può aspettare, coloro che sono nati sordi, o
che lo sono diventati in giovanissima età.
Il termine «sordo» è vago, o meglio, è così generico che non
permette di distinguere i moltissimi gradi della sordità, gradi che
hanno un'importanza qualitativa, e perfino «esistenziale». Ci sono le
persone «dure di orecchio» (o «sordastri»), quindici milioni circa
nella popolazione degli Stati Uniti, che riescono a udire in parte
quanto viene detto, con l'aiuto di un apparecchio acustico e di una
certa dose di buona volontà e di pazienza da parte dei loro
interlocutori. Molti di noi hanno un genitore o un nonno
appartenente a questa categoria - un secolo fa avrebbero usato il
cornetto acustico; oggi usano le moderne protesi.
Vi sono poi i «sordi gravi», molti dei quali lo sono in conseguenza
di una malattia alle orecchie o di un incidente subìto nei primi anni
di vita; ma per loro, come per i duri di orecchio, udire le parole altrui
è ancora possibile, soprattutto con gli apparecchi acustici disponibili
oggi o in fase di messa a punto, congegni estremamente perfezionati,
computerizzati e «personalizzati». Infine vi sono i «sordi profondi»
("stone deaf") ai quali nessun futuro ritrovato tecnologico permetterà
mai di udire le parole degli altri. I sordi profondi non possono
conversare nel modo abituale: devono o leggere le labbra (come
faceva David Wright) o usare la lingua dei segni, o fare entrambe le
cose.
Non importa solo il grado della sordità, importa anche e
soprattutto l'età, o lo stadio, in cui essa sopraggiunge. Wright, nel
brano citato, ci ricorda che egli perse l'udito solo dopo avere
imparato a parlare, e che quindi non ha la minima idea di come deve
essere la situazione di coloro che sono nati privi dell'udito, o che lo
hanno perso prima dell'acquisizione del linguaggio. E' un argomento
che Wright tocca anche altrove:
«Il fatto di essere diventato sordo a sette anni - se la sordità
doveva essere il mio destino - fu una vera fortuna, perché, come tutti
i bambini di quell'età, avevo ormai afferrato i fondamenti del
linguaggio. L'aver imparato a parlare in modo naturale è stata
un'altra fortuna - la pronuncia, la sintassi, le inflessioni, le
peculiarità linguistiche, erano tutte cose che avevo ricevuto
attraverso l'orecchio. Possedevo le basi di un vocabolario che mi era
facile ampliare con la lettura. "Tutto ciò mi sarebbe stato negato se
fossi nato sordo o se avessi perso l'udito in età ancora più tenera"»
(6).
Wright descrive le «voci fantasma» che ode quando qualcuno gli
parla, purché possa "vedere" il movimento delle labbra e del volto
dell'interlocutore, e racconta di come «oda» le folate di vento quando
vede l'agitarsi degli alberi o dei rami. Affascinante è la sua
descrizione delle prime manifestazioni di questo fenomeno,
immediatamente dopo l'instaurarsi della sordità:
«Ciò che rese [la mia sordità] più difficilmente percepibile fu il
fatto che fin dall'inizio i miei occhi avevano inconsciamente
cominciato a tradurre il movimento in suono. Mia madre stava quasi
tutto il giorno accanto a me e io capivo tutto quello che diceva.
Perché no? Senza saperlo, per tutta la vita avevo letto le sue
labbra.
Quando parlava, mi sembrava di udire la sua voce. Questa
illusione rimase anche dopo che scopersi che era un'illusione. Mio
padre, mio cugino, tutti quelli che conoscevo, conservarono per me le
loro voci fantasma. Che tali voci fossero immaginarie, che fossero
una proiezione dell'abitudine e della memoria, lo compresi solo
quando uscii dall'ospedale. Un giorno stavo conversando con mio
cugino ed egli, con un'ispirazione subitanea, si coprì la bocca con la
mano mentre parlava. Silenzio! Improvvisamente e per sempre
compresi che, se non vedevo, non potevo sentire» (7).
Malgrado Wright sappia che i suoni che «ode» sono «illusori»,
che sono «una proiezione dell'abitudine e della memoria», essi
hanno mantenuto nel corso degli anni la stessa vivezza. Per Wright,
per coloro che sono diventati sordi dopo aver potuto godere
dell'udito, il mondo può restare pieno di suoni, anche se si tratta di
suoni «fantasma» (8).
Tutt'altra situazione, essenzialmente inimmaginabile per la
persona normale (e anche per la persona rimasta sorda dopo
l'acquisizione del linguaggio, cioè in età postlinguistica, o
postlinguale, come Wright), è quella in cui l'udito è assente alla
nascita, o è stato perso durante la primissima infanzia, prima
dell'acquisizione del linguaggio. Le persone che si trovano in questa
condizione, i cosiddetti sordi prelinguistici (o prelinguali),
costituiscono una categoria qualitativamente differente da tutte le
altre. Per queste persone, che non hanno mai udito in vita loro, che
non hanno alcun ricordo uditivo, né immagini o associazioni uditive,
non ci potrà mai essere neppure l'illusione del suono. Esse vivono in
un mondo di totale e ininterrotta assenza di suono, un mondo di
silenzio (9). I sordi congeniti, negli Stati Uniti, ammontano a
qualcosa come un quarto di milione di individui, e in tutto il mondo
un bambino su mille nasce sordo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




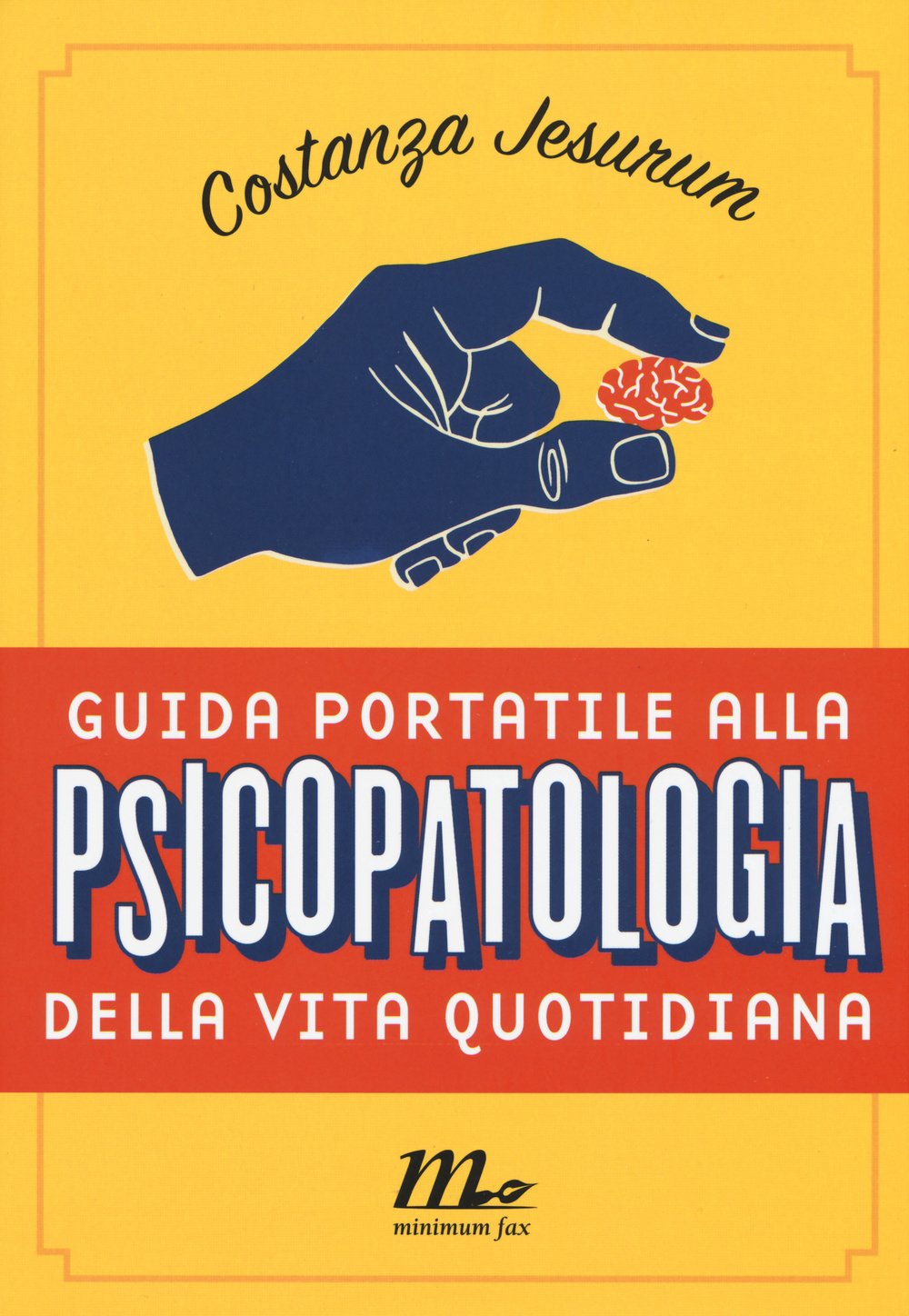
Commento all'articolo