Storia della filosofia moderna – 2. Da Cartesio a Kant- Luciano De Crescenzo
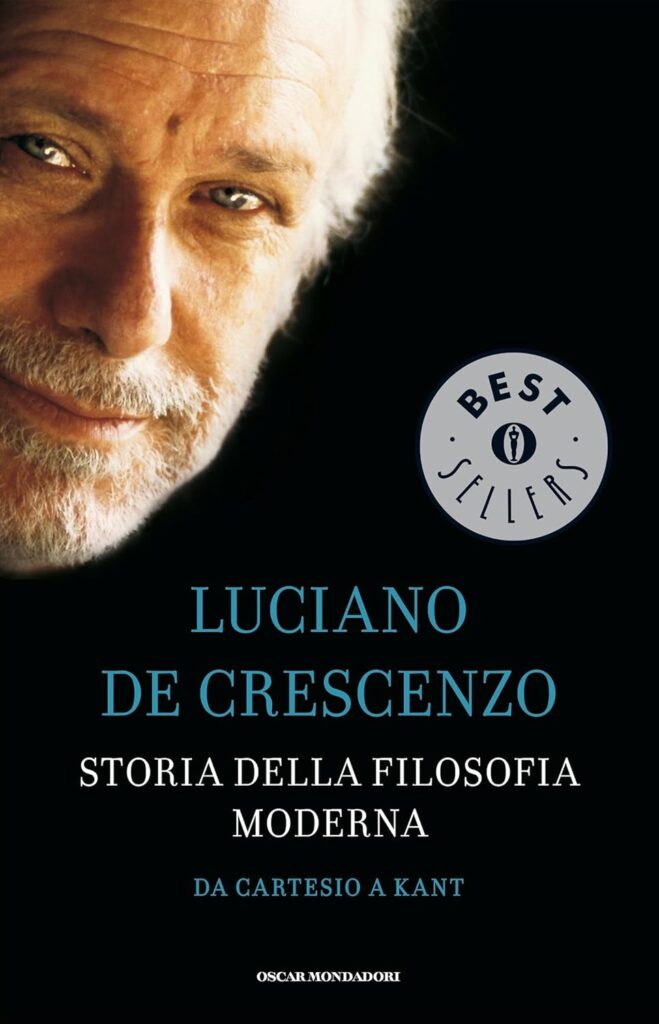
SINTESI DEL LIBRO:
Renato Cartesio
Se dubito penso, se penso esisto e se esisto anche Dio esiste.
Questo, in quattro parole, il pensiero di Cartesio. Tutto il resto si
potrebbe pure saltare.
La vita
René Des Cartes o Descartes, o Cartesius, o Cartesio, o Delle
Carte, nacque a La Haye, in Turenna, nel 1596, da una famiglia
della piccola nobiltà francese. Fu chiamato René, cioè «rinato»,
perché appena venuto al mondo stava per morire e solo grazie alla
respirazione della sua levatrice riuscì a sopravvivere.
Rimasto orfano di madre quando non aveva ancora compiuto un
anno, venne allevato da una nonna e dalla levatrice che lo aveva
aiutato a nascere. A nove anni fu messo in un collegio gesuitico,
quello di La Flèche, e lì ebbe modo di affrontare gli studi obbligatori
dell’epoca, e cioè la grammatica per quattro anni, la retorica per due
e la filosofia per tre.
I gesuiti, però, al giovane Cartesio stavano sulle scatole, anche
perché, durante le lezioni, pretendevano il silenzio più assoluto, e lui,
irrequieto com’era, faceva sempre casino. Ogni volta c’era qualcosa
su cui non era d’accordo e su cui avrebbe voluto discutere, anzi
litigare. Finì col farsi odiare da tutto il corpo docente.
Renato Cartesio (1596-1650)
La mattina si alzava tardi, mai prima di mezzogiorno, e non era
quello che si dice un grande lettore. A detta di Voltaire, non aveva
mai letto niente che valesse la pena. Nemmeno i Vangeli. A lui
bastava un’occhiata per capire un libro. Era solito affermare: «Sono
sufficienti poche pagine e uno sguardo alle figure. Tutto il resto è
inutile: è stato scritto solo per riempire la carta».
Misantropo e vegetariano, vestiva quasi sempre di nero. Aveva
una zazzera mal pettinata e uno sguardo bovino che esprimeva più
disgusto che stima nei confronti del prossimo. Insomma, era quello
che si dice un carattere difficile.
In seguito si trasferì a Poitiers dove prese la laurea in Legge.
Una volta terminati gli studi, se ne andò in Olanda dove, a quanto
pare, le autorità ecclesiastiche erano di manica più larga. Nel
contempo scrisse:
Proprio alla fine degli studi mi trovai sperduto tra infiniti dubbi ed
errori. Mi sembrava di aver studiato solo per scoprire quanto fossi
ignorante.
Durante la guerra dei Trent’anni si arruolò come «gentiluomo
volontario», prima nell’esercito protestante del principe Maurizio di
Nassau-Orange e poi in quello cattolico del duca di Baviera, quasi a
sottolineare il fatto che per lui una religione valeva l’altra. E fu
proprio in questo periodo che strinse due importanti amicizie: la
prima con un teologo, Marin Mersenne, di larghe vedute, e la
seconda col medico e scienziato olandese Isaac Beeckman.
Entrambe queste amicizie accrebbero in lui l’interesse per le scienze
esatte.
Successe, però, che una mattina, quasi all’alba, fece tre sogni,
l’uno più angoscioso dell’altro. Nel primo si vide circondato da un
gruppo di fantasmi che lo facevano ruotare su se stesso come una
trottola; nel secondo fu sommerso da una pioggia di scintille di
fuoco; e nel terzo venne aggredito da un uomo che gli volle per forza
recitare una poesia intitolata Est et non. Cosa, poi, volessero dire
questi sogni non si è mai saputo. Lui, comunque, li interpretò come
un messaggio divino affinché si rendesse conto del vero significato
della vita. Si recò allora al Santuario della Madonna di Loreto, deciso
a non lasciare quel sacro luogo finché non avesse scoperto
qualcosa in cui credere. Ovviamente non ci riuscì e allora
abbandonò ogni interesse per le materie cosiddette astratte, ovvero
la religione, la magia e l’astrologia, e mise al primo posto dei suoi
interessi la matematica.
Così facendo, anzi così ragionando, morì nel febbraio del 1650.
Nel settembre del 1649 era stato invitato dalla regina Cristina di
Svezia per una serie di lezioni filosofiche da tenere a corte.
Purtroppo, però, la regina pretendeva che le lezioni si tenessero alle
cinque del mattino e queste uscite all’alba gli furono fatali. Non
essendo abituato al clima nordico, si prese una polmonite che gli fu
fatale.
Le opere
Cartesio scrisse moltissimo. Fra le tante opere che ci ha lasciato
ricordiamo le Regole per dirigere l’ingegno, Le passioni dell’anima
(1649), le Meditazioni sulla filosofia prima (1641) e Principi della
filosofia (1644). Il saggio, però, che più gli diede dei grattacapi fu il
Mondo (la prima parte di un trattato di fisica e antropologia), * dove
sposava in pieno le tesi di Copernico, quelle che ipotizzavano il Sole
al centro dell’Universo. Ebbene, a quei tempi bastava un’allusione a
una nascita di Gesù un filino decentrata per finire sotto processo. La
Santa Inquisizione non perdonava e, dopo quello che era successo
a Galileo, non era proprio il caso di scherzare. Cartesio, allora,
decise di non dare alle stampe il Mondo e di pubblicarne solo alcune
parti, quelle dove non si affrontava il problema dell’eliocentrismo. Ne
vennero fuori tre saggi, la Diottrica, le Meteore e la Geometria, più
un’introduzione intitolata Discorso sul metodo. Tutto il resto, sotto il
titolo di Mondo o di Trattato sulla luce, uscì molti anni dopo, nel
1664, quando lui era già morto e sepolto.
Il Discorso sul metodo
Il Discorso è diviso in sei parti: nella prima si parla della
Scienza, nella seconda delle Regole indispensabili per ragionare,
nella terza della Morale, nella quarta di Dio, nella quinta della Fisica
e nell’ultima della Natura.
Il tutto comincia con un elogio del buonsenso. Ognuno di noi,
dice, ne è provvisto quanto basta. Ma che cos’è il buonsenso? «È la
facoltà di distinguere il vero dal falso, o, perlomeno, il probabilmente
vero dal probabilmente falso. L’importante è non lasciarsi prendere
dall’entusiasmo.» Detto in altre parole, ci consiglia di praticare il
dubbio ogniqualvolta siamo costretti a esprimere un’opinione. Poi,
parlando di se stesso, afferma:
Sono stato istruito nelle lettere fin da ragazzo, ma, appena
terminati gli studi, ho scoperto la mia ignoranza. In compenso, col
tempo, ho capito quanto fosse importante leggere e studiare. La
lettura di un libro è una conversazione con il suo autore. Leggere
equivale a viaggiare. Lo stesso dicasi della matematica, della
musica, della filosofia e della poesia. Vista, però, la moltitudine delle
materie, ho deciso d’iniziare studiando me stesso.
Dopodiché precisa: è molto utile conoscere i costumi degli altri
popoli, soprattutto per confrontarli con i propri. L’importante, però, è
non lasciarsi prendere dalle cose già dette in passato: si rischia,
infatti, di sottovalutare il presente. Infine Cartesio c’informa che da
ragazzo era convinto che l’eloquenza e la poesia fossero delle
qualità innate. Laddove, diventando più adulto, si era reso conto che
erano entrambe frutto dello studio.
Ed ecco, nella seconda parte del Metodo, le principali regole da
rispettare. La prima è quella di non dare mai nulla per scontato; la
seconda, quella di scindere ogni problema grande in più problemi
piccoli; la terza, quella di risalire dai problemi piccoli al problema
grande; e la quarta, quella di controllare che non ci si sia dimenticati
di nulla. Dette con altre parole, le regole sarebbero: l’Evidenza,
l’Analisi, la Sintesi e la Verifica.
Nella terza parte ci dà tre consigli pratici che hanno a che fare
con la morale e con la sopravvivenza. Il primo è quello di ubbidire
alle leggi e ai costumi del paese in cui viviamo, e, nei casi incerti, di
attenersi alle opinioni più moderate. Scegliendo la via di mezzo,
precisa, anche quando si sbaglia si finisce con lo sbagliare meno. Il
secondo è quello di non cambiare rotta in caso di smarrimento.
Supponiamo, dice, di esserci persi nel mezzo di un bosco. Guai ad
andare un po’ di qua e un po’ di là. Meglio scegliere una direzione
qualsiasi e mantenerla fino a quando non si esce dalla foresta. Terza
e ultima massima, quella di contare più su di noi che sulla sorte. Il
nostro buonsenso, osserva, ci porta a desiderare solo le cose
possibili e a diffidare di quelle estremamente improbabili, tipo il
SuperEnalotto, tanto per dirne una. A essere sinceri, Cartesio non
dice mai SuperEnalotto ma è come se lo avesse fatto.
La parte più interessante del Discorso è comunque la quarta,
quella sintetizzata dalla famosa affermazione «Cogito ergo sum». Il
ragionamento è quantomai elementare. Dice in sostanza Cartesio:
Invece di credere che tutto sia vero, suppongo che tutto sia
falso, e controllo se è rimasto in piedi qualcosa in cui credere. Di
certo so solo che sto pensando. Se penso, però, vuol dire che
esisto, e se esisto vuol dire che esiste qualcuno che mi ha messo al
mondo. Dopodiché mi decido e chiamo «Dio» questo qualcuno che
mi ha creato e «anima» la cosa che sta dentro di me e che pensa di
continuo.
Nella sesta parte del libro Cartesio fa un accenno a Galilei, pur
senza nominarlo mai:
Sulla Fisica e sulla Natura sono state dette cose molto
importanti e anch’io, in verità, avrei voluto dire la mia. Poi venni a
sapere che persone, alle quali mi inchino, avevano disapprovato le
opinioni pubblicate da un altro studioso, sulle quali io, peraltro, non
trovavo nulla di pregiudizievole nei confronti della Religione e tanto
bastò perché da quel giorno decidessi di non pubblicare su questo
argomento.
Le Meditazioni
Nelle Meditazioni Cartesio ritorna a parlare di Dio e dell’anima.
Questi due concetti sono senza alcun dubbio i più importanti
che si possono avere. E non è detto che ci si arrivi solo attraverso la
Fede. A volte, potrebbe bastare anche la sola Ragione. Ecco perché
prego coloro che desiderano leggere queste Meditazioni di non
formarsi un giudizio preconcetto, ma di leggersi tutte le obiezioni
possibili e anche tutte le risposte possibili.
Ciò detto, mi chiuderò gli occhi e le orecchie. Distrarrò tutti i miei
sensi, cancellerò dalla memoria tutte le immagini che ho
immagazzinato e cercherò di diventare più noto a me stesso.
Io sono un essere che pensa, che dubita, che nega, che
conosce solo poche cose, che ne ignora molte, che odia, che vuole
e che non vuole, che immagina, che ama e che sente. E che pur
sapendo che tutte queste cose potrebbero anche non esistere, sa
invece che esistono tutte dentro il suo cervello.
Conclusioni
Cerchiamo ora di capire che cosa ha rappresentato Cartesio per
la storia del pensiero. Lui fece spostare di qualche centimetro Dio e
la Fede per fare un po’ di posto all’Uomo e alla Ragione, pur
riconoscendo alla Religione tutti i meriti che le dovevano essere
riconosciuti.
A proposito di Cartesio,
molti credono che le coordinate cartesiane siano una sua
invenzione. Niente di più inesatto: le coordinate furono inventate
molti anni prima e vennero usate dagli Egizi, dagli Arabi, dai
Greci e dai Romani. C’è anche chi ne attribuisce l’invenzione a
Ipparco, ad Archimede o ad Apollonio Pergeo. Lui, il nostro
Cartesio, non fece altro che disegnarle in un saggio intitolato per
l’appunto Geometria.
Io personalmente ne ho fatto un largo uso nel mio libro Così
parlò Bellavista. Le adoperai per dividere gli esseri umani in due
categorie: quelli amanti della Libertà, che misi sull’asse
verticale, e quelli amanti dell’Amore, che misi sull’asse
orizzontale. A metà strada, nel quadrante limitato dai due assi,
tutti gli altri.
Thomas Hobbes (1588-1679)
*
La seconda parte si intitolava L’Uomo.
II
Thomas Hobbes
Se Cartesio era un razionalista, Hobbes lo era molto di più,
seppure a modo tutto suo. Le frasi che lo resero celebre furono:
homo homini lupus («ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri
uomini») e bellum omnium contra omnes (i rapporti sociali altro non
sono che «una guerra di tutti contro tutti»).
La vita
Thomas o Tommaso Hobbes nacque prematuro nel 1588 a
Malmesbury. La madre era al settimo mese quando le dissero che
da Lisbona era partito Filippo II con un’armata costituita da 130 navi,
30.000 uomini e 2400 cannoni. Le dissero anche che gli spagnoli
avrebbero invaso l’Inghilterra e avrebbero violentato tutte le donne
inglesi, che fossero o non fossero incinte, e tanto bastò per farla
partorire con due mesi di anticipo. Alcuni anni dopo il filosofo scrisse
che «lui e la paura erano nati gemelli». A parte la nascita, però, non
ebbe un’infanzia facile. Il padre, un prete anglicano, era un
incazzoso terribile. Dopo pochi anni abbandonò la moglie e i figli, e
sparì per sempre. Dei ragazzini si prese cura uno zio paterno.
Comunque, a parte l’Invencible Armada, quelli erano tempi
difficili. Hobbes nel corso della vita ebbe modo di «assistere di
persona» alla guerra dei Trent’anni (1618-48), alle lotte tra anglicani
e presbiteriani, a un paio di guerre civili, alla decapitazione di Carlo I
nel 1649 e alla salita al potere delle Teste rotonde di Cromwell.
Nessuno di questi eventi, però, lo coinvolse più di tanto. Lui, da
bravo filosofo qual era, si fece sempre i fatti suoi, e, ogniqualvolta la
situazione diventava un tantinello preoccupante, faceva le valigie e
se ne andava.
Studiò a Oxford dove conseguì il titolo di baccelliere delle arti.
Quindi s’impiegò come precettore presso la famiglia dei Cavendish,
per poi rimanerci, con tanto di vitto e alloggio, per più di trent’anni.
Ebbe a tal punto successo come insegnante privato che insieme al
suo unico allievo (il quasi coetaneo baroncino Cavendish) si recò in
Francia, in Germania e in Italia. In Francia conobbe Pierre Gassendi
e padre Marin Mersenne, che a sua volta gli presentò Cartesio. In
Italia, infine, prese casa a Pisa, dove strinse una sincera quanto
affettuosa amicizia con Galileo Galilei.
Conosceva il greco e il latino in pratica come l’inglese. Tradusse
gli Elementi di geometria di Euclide, la Guerra del Peloponneso di
Tucidide e tutte le opere di Omero, ma si rifiutò sempre di
pubblicarne le traduzioni, probabilmente per disprezzo verso i
contemporanei. Come carattere era quanto di peggio si possa
immaginare. Era solito dire: «La vita mi fa schifo. Non penso ad altro
che al suicidio». E difatti morì di morte naturale, nel proprio letto, a
novantuno anni.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :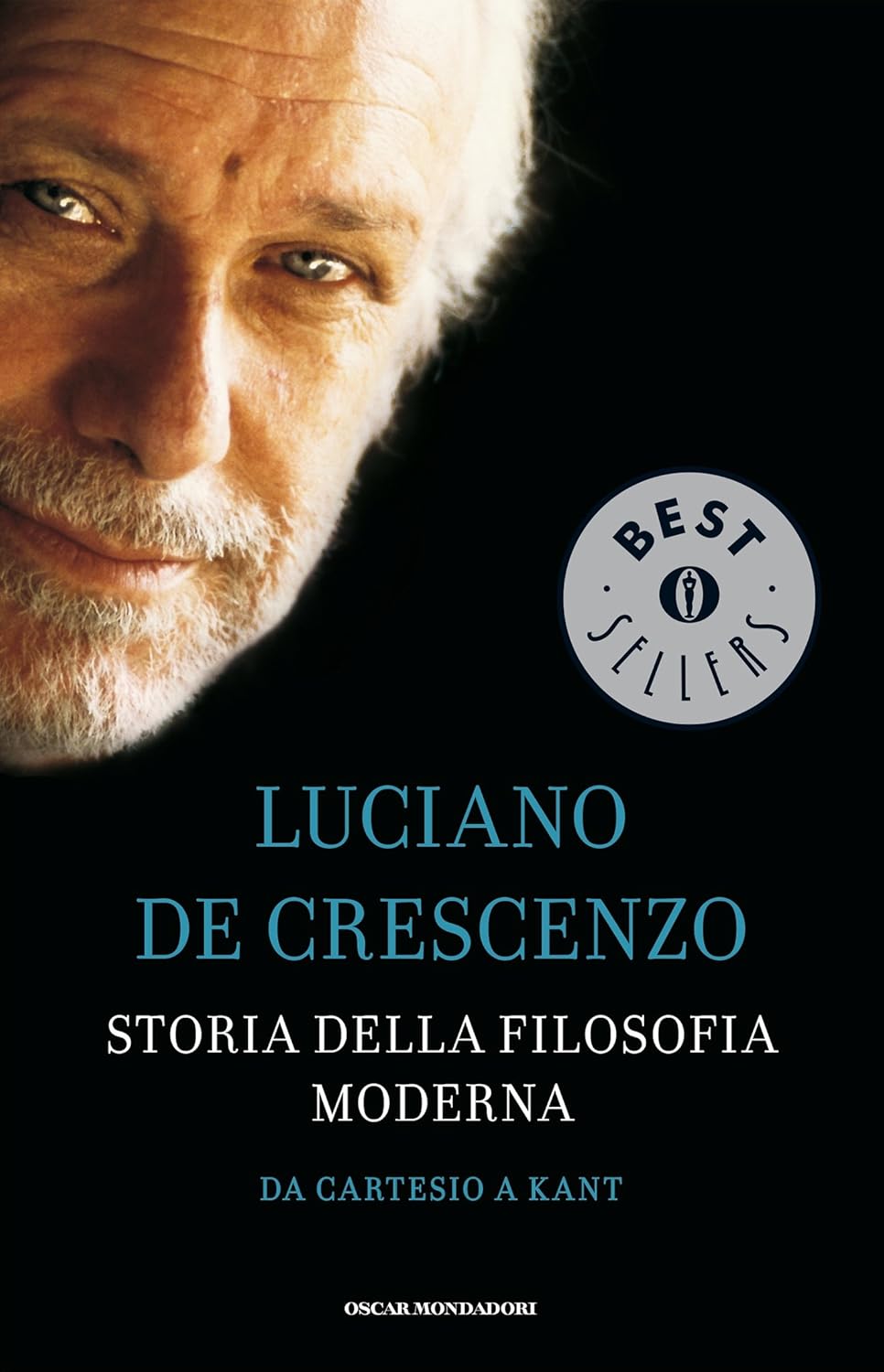






Commento all'articolo