Storia del Mediterraneo in 20 oggetti – Amedeo Feniello & Alessandro Vanoli
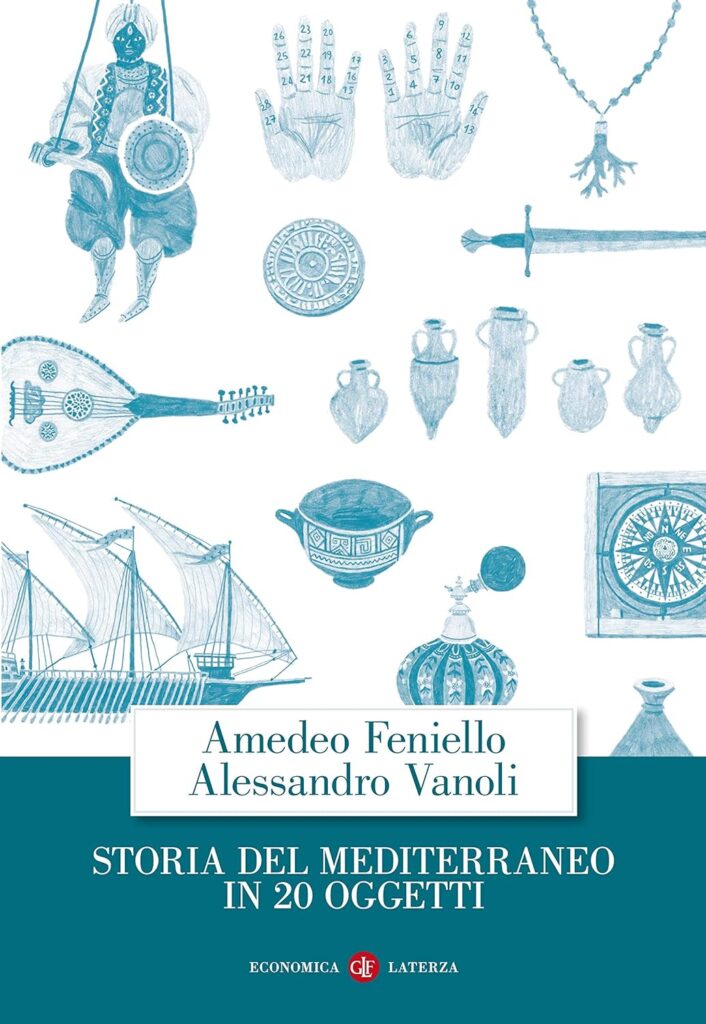
SINTESI DEL LIBRO:
«Viator Pompeis panem gustas, Nuceriae bibes» («Viandante
mangia il pane di Pompei ma bevi il vino di Nocera»), aveva scritto
qualcuno a grandi lettere davanti alla taverna. E aveva ragione: il
pane di Pompei era ottimo: tondo e segnato a spicchi, come una
rosetta, fatto con una farina raffinata, pregiata, di grano tenero. Più
di trenta i panifici in giro per la città: macine fatte di pietra lavica,
forni a volta in mattoni e laboratori dove si lavorava il pane prima di
infornarlo. «Hic habitat felicitas», qualcuno aveva scritto sulla parete
del panificio Popidius Priscus: «Qui abita la felicità»... Era il 79 d.C.
Il pane nero così come lo potete vedere oggi l’hanno ricostruito
briciola dopo briciola. L’eruzione del Vesuvio ha bloccato quel
piccolo mondo nel suo ultimo istante. Pane compreso. Fissando così
uno dei sensi profondi di quella civiltà che da Pompei guardava e
guarda alle coste del Mediterraneo intero.
E il pane, a pensarci bene, ha davvero qualcosa a che fare con le
forze della terra più profonda: il pane è nato nella cenere sulla pietra;
e il mattone servì da modello a colui che doveva cuocere la prima
focaccia: all’inizio terra e pasta forse si trovarono nel medesimo
forno. Diceva Diogene Laerzio che l’universo stesso comincia con il
pane; e a suo modo aveva ragione. Di sicuro è da quella profondità
che bisogna partire per parlarne.
Si comincia dal grano, ovviamente. E il grano viene menzionato
sulle tavolette di argilla ritrovate a Uruk e a Ebla, nei geroglifici di
Menfi e di Tebe. Probabilmente è la Mesopotamia la terra dove è
stato originariamente seminato e mietuto. Il pane seguì il grano, da
subito: i mortai di pietra per sminuzzare i chicchi sono un tesoro di
ogni antica civiltà mediterranea. I grandi libri degli antichi, l’Avesta,
l’Epopea di Gilgamesh, tutti parlano del pane. E i nomi sono vari e
complessi: il sumero ninda, l’accadico akalu: pane in generale, a
quanto sembra, che poi i testi distinguono in base al lievito, al sale,
alla dolcezza e così via. Nell’Antico Egitto il pane è ta, scritto con un
geroglifico disegnato come un semicerchio, che rappresenta una
focaccia lievitata e che serve in generale per scrivere la lettera t. Poi
come sempre si distingue: pane bianco ta hegd e pane verde ta
uagd; e poi focacce, gallette, divise per forme e sapori diversi. Il
pane è varietà, come sempre.
Cercare il grano, uno dei motivi principali per cui i greci si
spostavano lungo il Mediterraneo. A sorvegliarne la crescita era
Demetra, dea della terra e delle messi, che da essa crescevano. E il
grano, anche per i greci, era soprattutto pane: non a caso in Sicilia la
dea la chiamavano Himalis, protettrice delle macine, e nel corso dei
festeggiamenti delle Tesmoforie, a Siracusa, venivano consacrati a
Demetra e sua figlia Persefone dei pani dolci di sesamo e miele a
forma di vagina. E i nomi anche per i greci si sprecavano: artos era
chiamato il pane nell’Odissea; oppure pyrnon, che era una specie di
focaccia di farina non setacciata, oppure ancora maza, che era il
nutrimento dei poveri. E poi escharìtes, un pane cotto sulla brace,
oppure dìpyros, un pane cotto due volte, o ancora il làganon, un
pane che si digeriva facilmente, e via dicendo: nella sua opera
perduta, l’Artopoiikón, la «Poetica del pane», Crisippo di Thiana
sosteneva che in Grecia vi fossero settantadue specie di pane.
E così di porto in porto eccoci finalmente al pane romano e dunque
al pane di Pompei. Di sicuro il culto di Cerere è più recente di quello
di Demetra e altrettanto di sicuro a Roma il pane iniziarono a
cuocerlo relativamente tardi: prima ci fu la polenta di grano, detta
puls, oppure i semplici chicchi abbrustoliti. Forse fu la conquista di
altri popoli, a cominciare dagli etruschi, che fece conoscere il pane ai
romani. Ma di sicuro c’è che nel 79 d.C., ai tempi della devastante
eruzione del Vesuvio, il pane, panem, era ormai una priorità per
Roma: se a Pompei i forni erano più di trenta, sembra che la Città
Eterna ne contasse oltre trecento, con associazioni professionali e
feste dedicate in onore della dea dei forni.
Il grano veniva importato dalla Sicilia e dalla Tunisia e quasi un
terzo del fabbisogno veniva dall’Egitto, con le navi che facevano la
spola tra l’Africa settentrionale e Ostia. Giusto per avere un ordine di
grandezza, si dice che a Roma giungessero in un anno 60.000.000
modii di grano, ovvero 1.200 grosse imbarcazioni contenenti 50.000
modii, circa 350 tonnellate. Togliete i mesi invernali, durante i quali
non si navigava, e la media era di cinque grosse imbarcazioni al
giorno che scaricavano il grano nei grandi porti del Sud per poi farlo
procedere via terra o con imbarcazioni più piccole. Così importante
era la politica dello Stato in materia di cereali da avere un nome,
annona, essendo in rapporto all’anno (annus) e alle stagioni.
Politica, appunto: spesso anche di basso livello, stando almeno a un
autore satirico come Giovenale: «Il popolo due sole cose
ansiosamente desidera: pane e giochi circensi». Panem et
circenses... uno dei grandi, intramontabili segreti della politica.
Ma il pane non è solo cibo, è anche accoglienza, condivisione, rito.
E a pensarci è curioso come nello stesso periodo in cui Roma
celebrava il suo trionfo anche col pane, dall’altro lato del
Mediterraneo, a oriente, quel cibo si preparasse ad assumere un suo
diverso significato universale; e tutto avesse inizio durante una cena,
prima della Pasqua ebraica, alla periferia dell’impero. Era una
questione antica: il pane attraversava la storia ebraica da
protagonista. A cominciare dal racconto dell’Esodo: gli ebrei schiavi
in Egitto e Mosè che preannuncia il loro riscatto; ma bisogna far
presto, prepararsi a partire subito, anche se il pane non è lievitato.
Eccolo il pane al centro della storia sacra, gli azzimi; quel pane che
avrebbe costituito la memoria del patto tra Dio e popolo ebraico per i
secoli a venire:
Mosè disse al popolo: «Ricordati di questo giorno, nel quale siete usciti dall’Egitto, dalla
condizione servile, perché con mano potente il Signore vi ha fatti uscire di là: non si mangi
ciò che è lievitato. Oggi voi uscite nel mese di Abib. Per sette giorni mangerai azzimi. [...]
Nel settimo vi sarà una festa in onore del Signore. Nei sette giorni si mangeranno azzimi e
non ci sarà presso di te ciò che è lievitato; non ci sarà presso di te il lievito, entro tutti i tuoi
confini. In quel giorno tu istruirai tuo figlio: È a causa di quanto ha fatto il Signore per me,
quando sono uscito dall’Egitto. Sarà per te segno sulla tua mano e ricordo fra i tuoi occhi,
perché la legge del Signore sia sulla tua bocca. Con mano potente infatti il Signore ti ha
fatto uscire dall’Egitto. Osserverai questo rito alla sua ricorrenza ogni anno». (Es 13,3-10)
La Pasqua ebraica sarebbe stata celebrata per sempre così. Ma
nel resto della storia di quel popolo il pane sarebbe stato
inevitabilmente una presenza costante. Non solo azzimi,
naturalmente: il pane della tavola, quello della condivisione e
dell’ospitalità, ebbe anche qui molti nomi. Il più importante è lehem,
ma anche pat e ugah. Come il pane che si poteva mangiare in
Galilea ancora ai tempi dei romani; come il pane che i Vangeli
dicono che Gesù abbia moltiplicato sul lago di Tiberiade.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :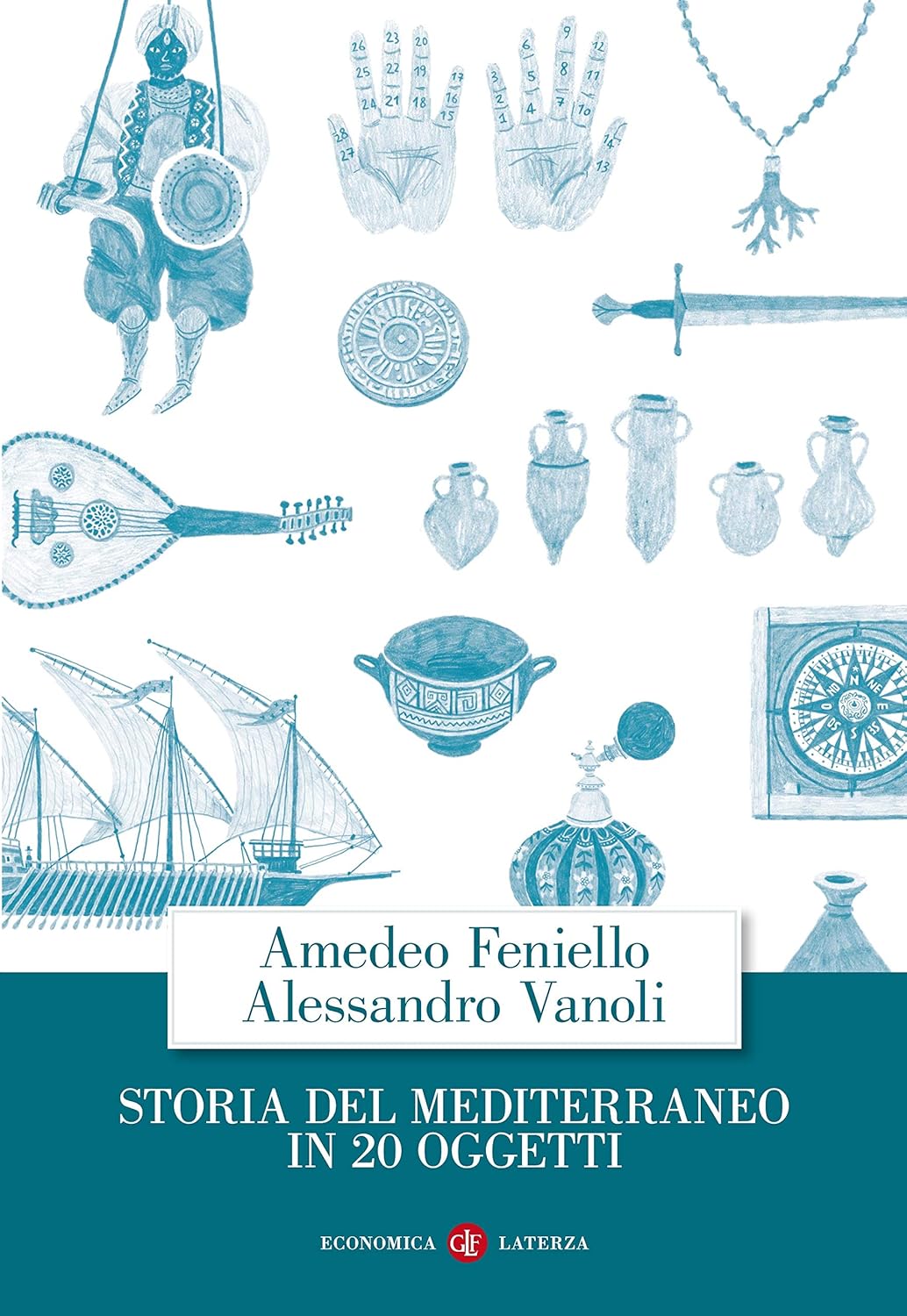






Commento all'articolo