L’affaire Moro – Leonardo Sciascia
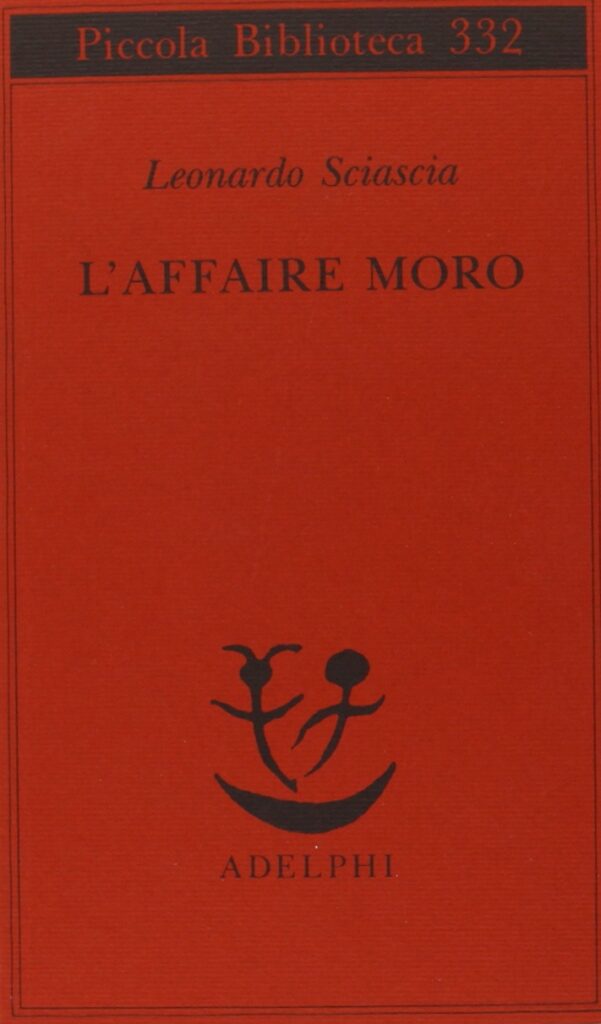
SINTESI DEL LIBRO:
Ieri sera, uscendo per una passeggiata, ho visto nella crepa di un muro
una lucciola. Non ne vedevo, in questa campagna, da almeno quarant’anni:
e perciò credetti dapprima si trattasse di uno schisto del gesso con cui erano
state murate le pietre o di una scaglia di specchio; e che la luce della luna,
ricamandosi tra le fronde, ne traesse quei riflessi verdastri. Non potevo
subito pensare a un ritorno delle lucciole, dopo tanti anni che erano
scomparse. Erano ormai un ricordo: dell’infanzia allora attenta alle piccole
cose della natura, che di quelle cose sapeva fare giuoco e gioia. Le lucciole le
chiamavamo cannileddi di picuraru, così i contadini le chiamavano. Tanto
consideravano greve la vita del pecoraio, le notti passate a guardia della
mandria, che gli largivano le lucciole come reliquia o memoria di luce nella
paurosa oscurità. Paurosa per gli abigeati frequenti. Paurosa perché bambini
erano di solito quelli che si lasciavano a guardia delle pecore. Le candeline
del pecoraio, dunque. E ogni tanto ne prendevamo qualcuna, la tenevamo
delicatamente chiusa nel pugno per poi aprirne a sorpresa, tra i più piccoli
di noi, quella fosforescenza smeraldina.
Era proprio una lucciola, nella crepa del muro. Ne ebbi una gioia intensa.
E come doppia. E come sdoppiata. La gioia di un tempo ritrovato –
l’infanzia, i ricordi, questo stesso luogo ora silenzioso pieno di voci e di
giuochi – e di un tempo da trovare, da inventare. Con Pasolini. Per Pasolini.
Pasolini ormai fuori del tempo ma non ancora, in questo terribile paese che
l’Italia è diventato, mutato in se stesso («Tel qu’en Lui-même enfin
l’éternité le change»). Fraterno e lontano, Pasolini per me. Di una fraternità
senza confidenza, schermata di pudori e, credo, di reciproche insofferenze.
Per mia parte, sentivo come un muro che ci separasse una parola a lui cara,
una parola-chiave della sua vita: la parola «adorabile». Può darsi che questa
parola io l’abbia qualche volta scritta, e sicuramente più volte l’ho pensata:
ma per una sola donna e per un solo scrittore. E lo scrittore – forse è inutile
dirlo – è Stendhal. Pasolini trovava invece «adorabile» quel che per me
dell’Italia era già straziante (ma anche per lui, ricordando un «adorabili
perché strazianti» delle Lettere luterane: e come si può adorare ciò che
strazia?) e sarebbe diventato terribile. Trovava «adorabili» quelli che
inevitabilmente sarebbero stati strumenti della sua morte. E attraverso i suoi
scritti si può compilare come un piccolo dizionario delle cose per lui
«adorabili» e per me soltanto strazianti e oggi terribili.
Le lucciole, dunque. Ed ecco che – pietà e speranza – qui scrivo per
Pasolini, come riprendendo dopo più che vent’anni una corrispondenza: «Le
lucciole che credevi scomparse, cominciano a tornare. Ne ho vista una ieri
sera, dopo tanti anni. Ed è stato così anche con i grilli: per quattro o cinque
anni non li ho sentiti, ora le notti sono sterminatamente gremite del loro
frinire».
Le lucciole. Il Palazzo. Pasolini voleva processare il Palazzo quasi in nome
delle lucciole. Per le lucciole scomparse. «Poiché sono uno scrittore, e scrivo
in polemica, o almeno discuto, con altri scrittori, mi si lasci dare una
definizione di carattere poetico-letterario di quel fenomeno che è successo
in Italia una diecina di anni fa. Ciò servirà a semplificare e ad abbreviare il
nostro discorso (e probabilmente a capirlo anche meglio). Nei primi anni
sessanta, a causa dell’inquinamento dell’aria, e, soprattutto, in campagna, a
causa dell’inquinamento dell’acqua (gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti)
sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e
folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c’erano più. (Sono ora un
ricordo, abbastanza straziante, del passato: e un uomo anziano che abbia un
tale ricordo, non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane, e
dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta).
«Quel “qualcosa” che è accaduto una diecina di anni fa lo chiamerò
dunque “scomparsa delle lucciole”.
«Il regime democristiano ha avuto due fasi assolutamente distinte, che
non solo non si possono confrontare tra loro, implicandone una certa
continuità, ma sono diventate addirittura storicamente incommensurabili.
«La prima fase di tale regime (come giustamente hanno sempre insistito a
chiamarlo i radicali) è quella che va dalla fine della guerra alla scomparsa
delle lucciole, la seconda fase è quella che va dalla scomparsa delle lucciole a
oggi».
E ancora: «Nella fase di transizione – ossia “durante la scomparsa delle
lucciole” – gli uomini di potere democristiani hanno quasi bruscamente
cambiato il loro modo di esprimersi, adottando un linguaggio
completamente nuovo (del resto incomprensibile come il latino):
specialmente Aldo Moro: cioè (per una enigmatica correlazione) colui che
appare come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state
organizzate dal ’69 a oggi, nel tentativo, finora formalmente riuscito, di
conservare comunque il potere».
Le lucciole. Il Palazzo. Il processo al Palazzo. E come se, dentro al Palazzo,
tre anni dopo la pubblicazione sul Corriere della sera di questo articolo di
Pasolini, soltanto Aldo Moro continuasse ad aggirarsi: in quelle stanze
vuote, in quelle stanze già sgomberate. Già sgomberate per occuparne altre
ritenute più sicure: in un nuovo e più vasto Palazzo. E più sicure, s’intende,
per i peggiori. «Il meno implicato di tutti», dunque. In ritardo e solo: e
aveva creduto di essere una guida. In ritardo e solo appunto perché «il
meno implicato di tutti». E appunto perché «il meno implicato di tutti»
destinato a più enigmatiche e tragiche correlazioni.
Prima che in questo articolo – pubblicato sul Corriere il 1° febbraio 1975
col titolo Il vuoto del potere in Italia e poi raccolto negli Scritti corsari col
titolo che la memoria di coloro che l’avevano letto ormai gli dava: L’articolo
delle lucciole – Pasolini aveva parlato del linguaggio di Moro in articoli e
note di linguistica (e si veda il libro Empirismo eretico). Ma qui, nell’articolo
delle lucciole, la sua attenzione a Moro, al linguaggio di Moro, affiora in un
contesto più avvertito e preciso, dentro una più vasta e disperata visione
delle cose italiane.
«Come sempre – dice Pasolini – solo nella lingua si sono avuti dei
sintomi». I sintomi del correre verso il vuoto di quel potere democristiano
che era stato, fino a dieci anni prima, «la pura e semplice continuazione del
regime fascista». Nella lingua di Moro, nel suo linguaggio completamente
nuovo e però, nell’incomprensibilità, disponibile a riempire quello spazio da
cui la Chiesa cattolica ritraeva il suo latino proprio in quegli anni. E non
poteva dirsi uno scambio, una sostituzione? E poi, lapalissianamente: il
latino è incomprensibile per chi non sa il latino. Pasolini non sa decifrare il
latino di Moro, quel «linguaggio completamente nuovo»: ma intuisce che in
quella incomprensibilità, dentro quel vuoto in cui viene pronunciata e
risuona, si è stabilita una «enigmatica correlazione» tra Moro e gli altri; tra
colui che meno avrebbe dovuto cercare e sperimentare un nuovo latino (che
è ancora il «latinorum» che fa scattare d’impazienza Renzo Tramaglino) e
coloro che invece necessariamente, per sopravvivere sia pure come automi,
come maschere, dovevano avvolgervisi. In questo breve inciso di Pasolini –
«per una enigmatica correlazione» – c’è come il presentimento, come la
prefigurazione dell’affaire Moro. Ora sappiamo che la «correlazione» era
una «contraddizione»: e Moro l’ha pagata con la vita. Ma prima che lo
assassinassero, è stato costretto, si è costretto, a vivere per circa due mesi un
atroce contrappasso: sul suo «linguaggio completamente nuovo», sul suo
nuovo latino incomprensibile quanto l’antico. Un contrappasso diretto: ha
dovuto tentare di dire col linguaggio del nondire, di farsi capire adoperando
gli stessi strumenti che aveva adottato e sperimentato per non farsi capire.
Doveva comunicare usando il linguaggio dell’incomunicabilità. Per
necessità: e cioè per censura e per autocensura. Da prigioniero. Da spia in
territorio nemico e dal nemico vigilata.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :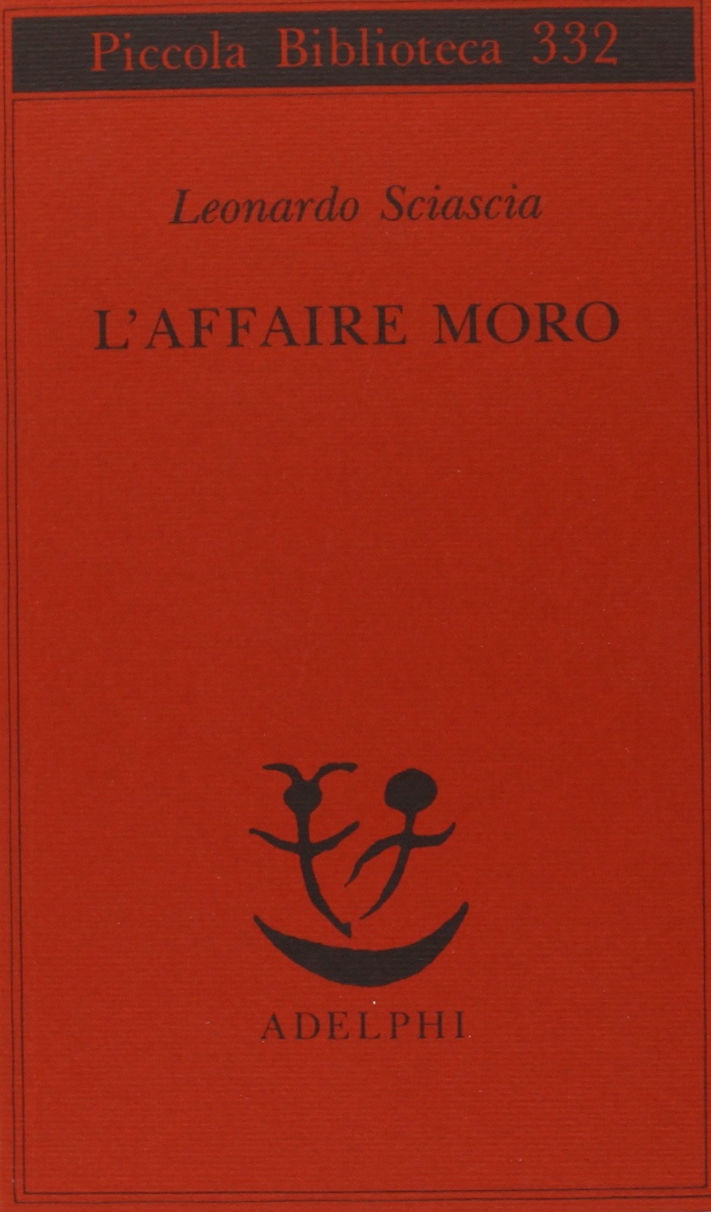



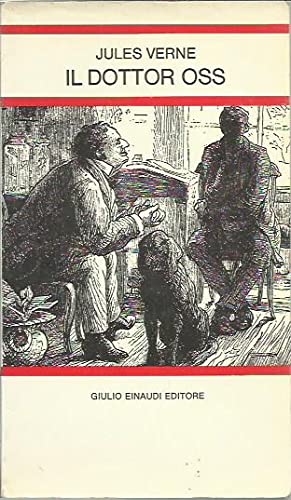
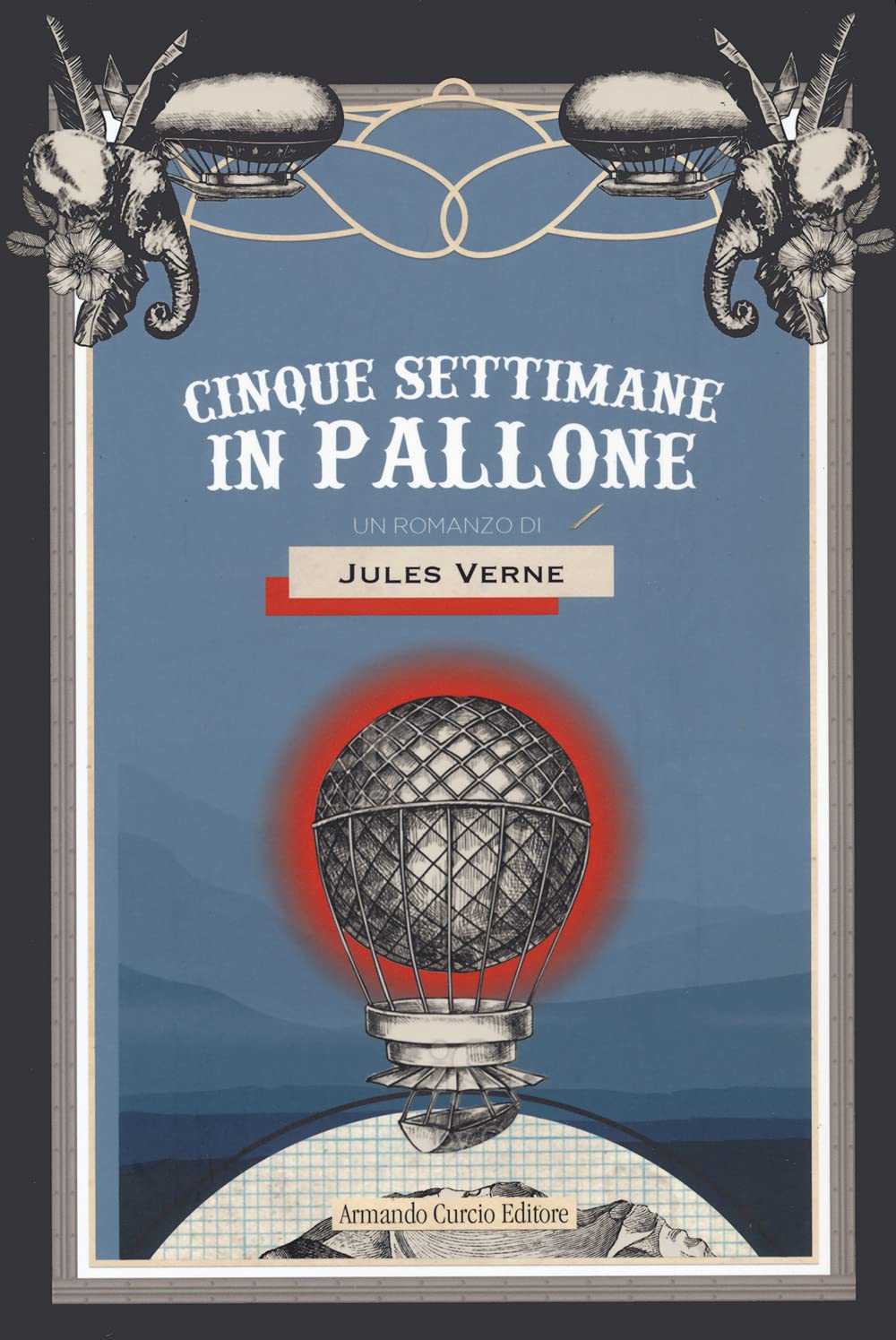
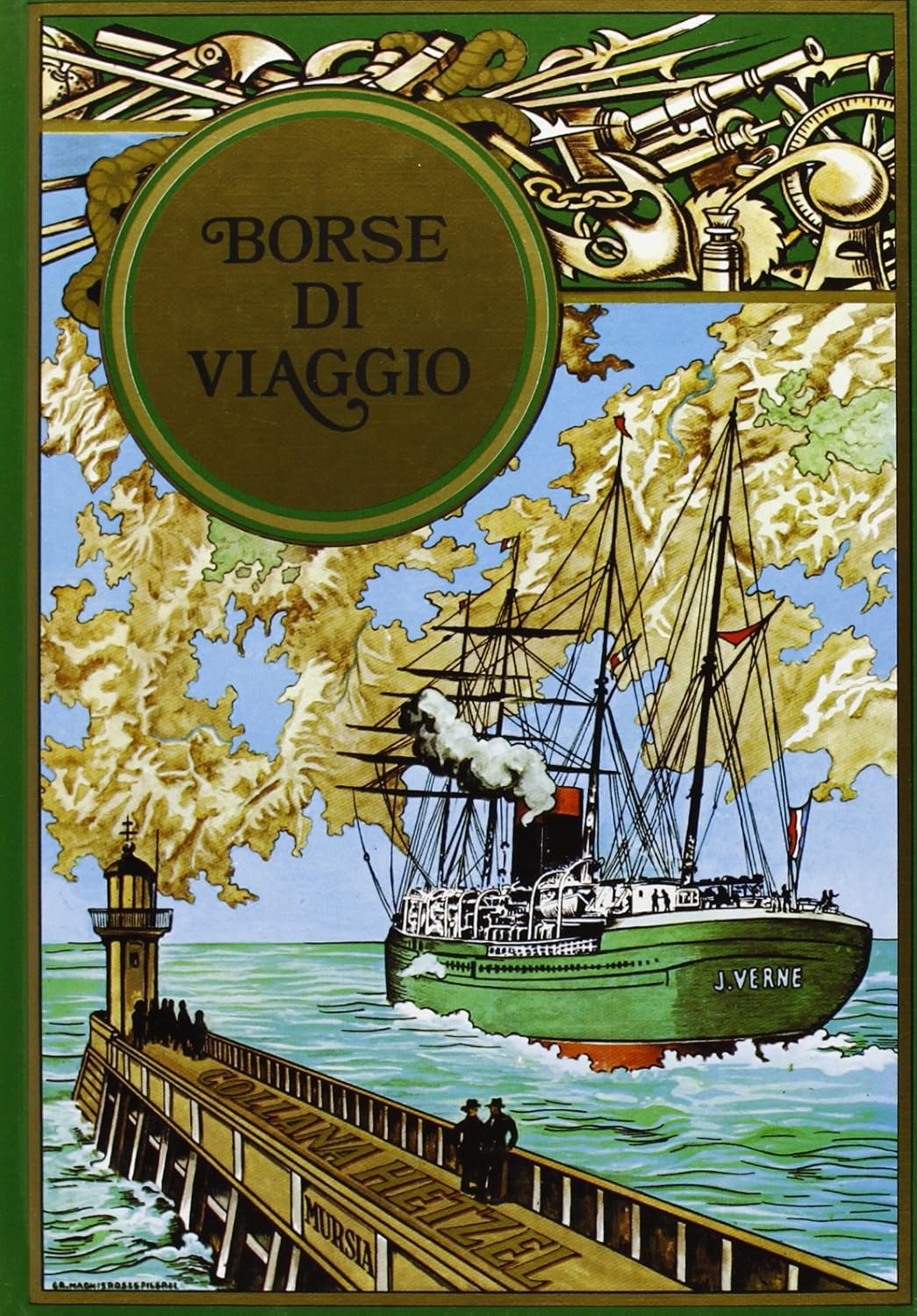
Commento all'articolo