Il libro del buio – Tahar Ben Jelloun
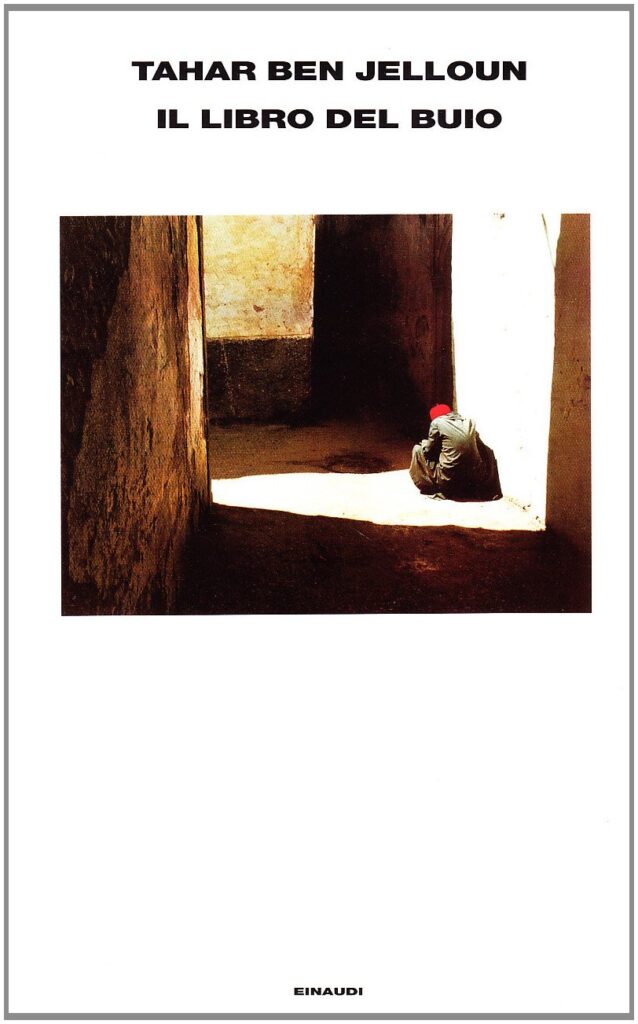
SINTESI DEL LIBRO:
A lungo ho cercato la pietra nera che purifica l'anima dalla morte.
Quando dico a lungo, penso a un pozzo senza fondo, a un tunnel
scavato con le dita, con i denti, nella tenace speranza d'intravedere,
anche solo per un minuto, per un lungo ed eterno minuto, un raggio di
luce, una scintilla che mi si imprimerebbe nell'occhio, che le mie
viscere custodirebbero, protetta come un segreto. Sarebbe qui,
vivrebbe nel mio petto e nutrirebbe l'infinito delle mie notti, qui, in
questa tomba, dentro la terra umida, nell'odore dell'uomo svuotato
della propria umanità a colpi di vanga che gli strappano la pelle, gli
tolgono lo sguardo, la voce e la ragione.
Ma che fare della ragione, qui dove ci hanno sotterrati, intendo dire
messi sotto terra, lasciandoci un buco per respirare, per vivere
abbastanza a lungo, tutte le notti necessarie per espiare la colpa,
dando alla morte una lentezza sottile; la morte doveva prendersela
comoda, prendere tutto il tempo degli uomini, quelli che noi non
eravamo più, e quelli che ci ricordavano ancora, e quelli che ci avevano
completamente dimenticati. Ah, la lentezza! il principale nemico,
quello che avvolgeva la nostra pelle martoriata, lasciando molto tempo
alla ferita aperta prima che cominciasse a cicatrizzarsi; la lentezza che
ci faceva battere il cuore al ritmo quieto di una piccola morte, come se
dovessimo spegnerci, una candela accesa lontano da noi che si
consumava con la dolcezza della felicità.
Pensavo spesso a quella candela, fatta non di cera ma di una
materia sconosciuta che dà l'illusione della fiamma eterna, emblema
della nostra sopravvivenza. Pensavo anche a una clessidra gigante, in
cui ogni granello di sabbia era un granello della nostra pelle, una
goccia del nostro sangue, un pugno di ossigeno che perdevamo via via
che il tempo scendeva verso l'abisso in cui eravamo.
Ma dove eravamo? Eravamo arrivati lì senza il nostro sguardo. Era
notte? Forse. La notte sarà la nostra compagna, il nostro territorio, il
nostro mondo e il nostro cimitero. Fu la prima informazione che
ricevetti. La mia sopravvivenza, le mie torture, la mia agonia erano
scritte sul velo della notte. Lo capii subito. Come se l'avessi sempre
saputo. La notte, ah! la mia coperta di polvere gelata, la mia distesa di
alberi neri che un vento gelido scuoteva solo per farmi male alle
gambe, alle dita schiacciate dal calcio di una pistola mitragliatrice. La
notte non scendeva, come si usa dire, era lì, sempre; regina delle
nostre sofferenze, le imponeva alla nostra sensibilità, casomai fossimo
riusciti a non sentire più nulla, come accadeva a quei torturati che
arrivavano a liberarsi del proprio corpo con uno sforzo di
concentrazione potentissimo, fino a non soffrire più. Lasciavano il
corpo ai torturatori e se ne andavano a dimenticare tutto in una
preghiera o in un ripiegamento interiore.
La notte ci vestiva. In un altro mondo, si sarebbe detto che era
piena di attenzioni per noi. Nessunissima luce. Mai il benché minimo
filo di luce. Ma i nostri occhi, pur avendo perso lo sguardo, si erano
adattati. Vedevamo nelle tenebre, o credevamo di vedere. Le nostre
immagini erano ombre che si muovevano nel buio, spintonando gli uni
e gli altri, arrivando fino a rovesciare la brocca dell'acqua, o a spostare
il pezzo di pane raffermo che alcuni conservavano per fronteggiare i
crampi allo stomaco.
La notte non era più la notte, poiché non aveva più giorno, più
stelle, più luna, più cielo. Noi eravamo la notte. Definitivamente
notturni, i nostri corpi, il nostro respiro, i battiti del cuore, i
brancolamenti delle nostre mani che andavano senza fatica da una
parete all'altra, poiché lo spazio era ridotto alle dimensioni di una
tomba per un vivo - ogni volta che pronuncio questa parola, dovrei
sostituirla con sopravvissuto, ma in verità ero vivo, un vivo che
sopportava la vita nell'estrema indigenza, nella prova che poteva finire
solo con la morte, ma tutto ciò assomiglia stranamente alla vita.
Non eravamo in una notte qualsiasi. La nostra era umida, molto
umida, appiccicosa, sporca, bagnaticcia, puzzava dell'urina degli
uomini e dei topi, una notte venuta a noi su un cavallo grigio seguito
da una muta di cani rabbiosi. Aveva gettato il suo pesante mantello sui
nostri volti che più nulla stupiva, un mantello dove non c'era neppure
qualche forellino lasciato dalle tarme, no, era un mantello di sabbia
bagnata. Terra mischiata a escrementi di ogni sorta di animali si posò
sulla nostra pelle, come se la nostra sepoltura fosse compiuta. No, il
vento che soffiava nel mantello ci dava un po' d'aria per non morire
subito, quel tanto per mantenerci lontani dalla vita e vicinissimi alla
morte. Quel mantello pesava tonnellate. Invisibile eppure palpabile. Le
mie dita si spellavano quando lo toccavo. Nascondevo le mani dietro la
schiena per non essere più in contatto con la notte. Così le proteggevo,
ma quante volte il freddo del cemento bagnato mi ha costretto a
cambiare posizione, a mettermi a pancia in giù, con la testa schiacciata
contro il suolo, preferendo aver male alla fronte piuttosto che alle
mani. Così vi erano preferenze tra un dolore e l'altro. Non proprio.
Tutto il corpo doveva soffrire, ogni parte, senza eccezione. La
tomba è stata predisposta (ancora una parola della vita, ma bisogna
pur continuare a prendere a prestito piccole cose dalla vita) in modo
che il corpo subisca tutte le sofferenze immaginabili, che le patisca con
la più lenta delle lentezze, e che si mantenga in vita per subire altri
dolori.
Di fatto la tomba era una cella lunga tre metri e larga uno e mezzo.
Era soprattutto bassa, tra il metro e cinquanta e il metro e sessanta.
Non potevo stare in piedi. Un buco per pisciare e per cagare. Un buco
di dieci centimetri di diametro. Il buco faceva parte del nostro corpo.
Bisognava dimenticarne subito l'esistenza, non sentire più gli odori di
merda e di urina, non sentire affatto.
Neanche a parlarne di turarsi il naso, no, bisognava tenere il naso
aperto e non sentire più niente. All'inizio era difficile. Era qualcosa che
bisognava imparare, una follia necessaria, una prova da superare a
ogni costo. Esserci senza esserci. Chiudere i sensi, indirizzarli altrove,
dare loro un'altra vita, come se mi avessero gettato in quella fossa
senza i miei cinque sensi. Ecco: fare come se li avessi lasciati al
deposito bagagli di una stazione, chiusi in una valigetta, ben avvolti nel
cotone o nella seta, e poi messi da parte all'insaputa dei torturatori,
all'insaputa di tutti. Una scommessa sull'avvenire.
Caddi nella fossa come un sacco di sabbia, come un pacco
dall'aspetto umano, caddi e non provavo nulla, non sentivo nulla e non
avevo male da nessuna parte. No, questa condizione la raggiunsi solo
dopo anni di sofferenze. Credo addirittura che il dolore mi avesse
aiutato. A forza di aver male, a forza di torture, ero riuscito pian piano
a staccarmi dal corpo e a vedermi lottare contro gli scorpioni nella
fossa. Ero al di sopra. Ero dall'altra parte della notte. Ma prima di
arrivarci, ho dovuto camminare per secoli nella notte del tunnel
infinito.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :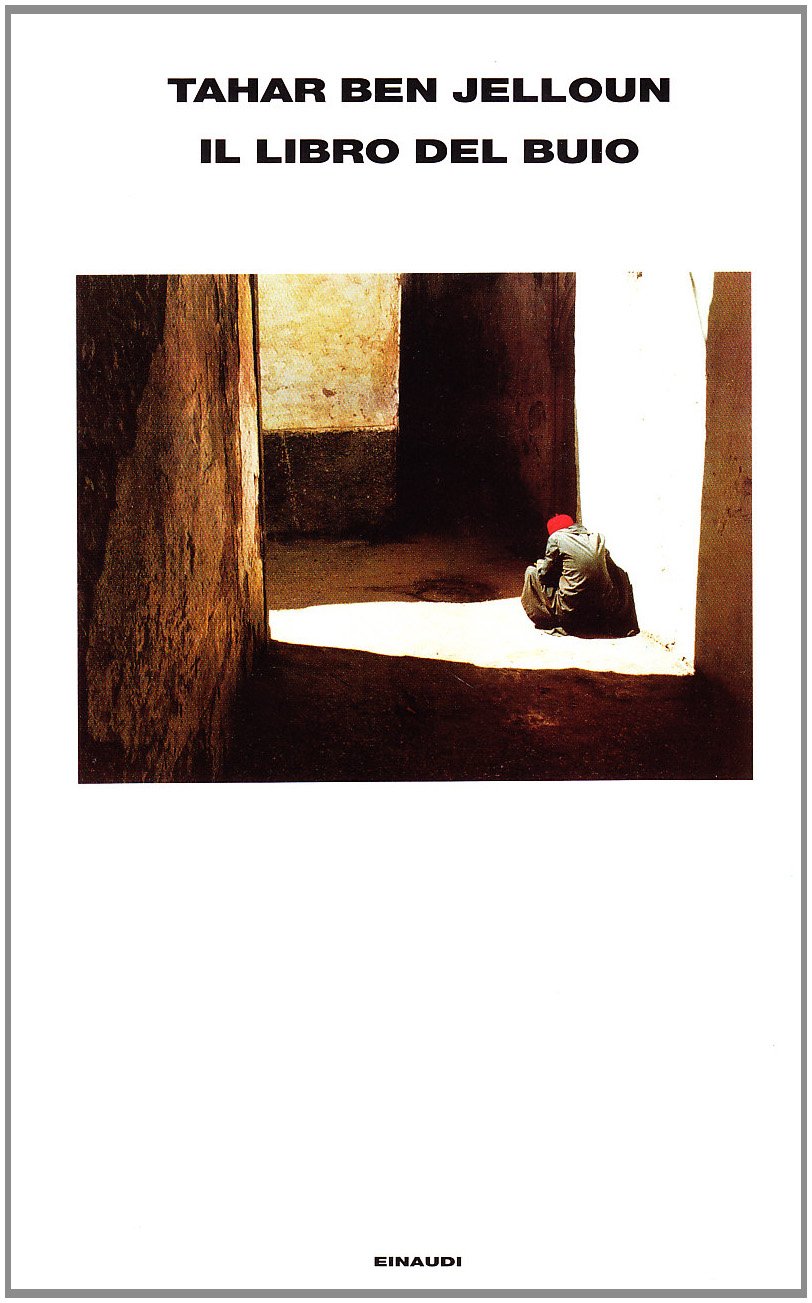






Commento all'articolo