Guardarsi dentro rende ciechi- Paul Watzlawick

SINTESI DEL LIBRO:
PARTE 1
I PRIMI SCRITTI SULLA PRAGMATICA DELLA
COMUNICAZIONE UMANA
In questa sezione sono raccolti articoli seminariali relativi allo studio degli
effetti della comunicazione nella eziologia dei disturbi mentali e alle analisi
delle ambivalenze logiche sottese alle relazioni interpersonali patologiche. Le
ambivalenze logiche e comunicative vengono analizzate con la lente della
pragmatica, in modo da individuarne non solo la struttura ma anche gli effetti
sulle percezioni ed il comportamento di chi ne è sia la vittima sia l’artefice. In
tale prospettiva gli autori, che rappresentano i fondatori della terapia
interazionale, sistemica e strategica, formulano su base empirica tecniche di
intervento terapeutico capaci di orientare i modelli patologici della
comunicazione in direzione del cambiamento terapeutico. In altri termini,
presentano ciò che potremmo definire il fondamento teorico-applicativo della
Scuola di Palo Alto e perciò la base della Terapia della Famiglia e
dell’Approccio Sistemico.
1. Sulla comunicazione umana (1964)
1
Paul Watzlawick e Don D. Jackson
Mi piace immaginare uno strumento che ci permetta di
scomporre gli schemi del comportamento suicida nel modo in
cui il fisico scompone un raggio di luce. Attraverso un tale
spettroscopio sociologico potremmo vedere spandersi lo
spettro multicolore di tutti i possibili atteggiamenti verso la
vita. Tutta l’angosciosa confusione diventerebbe nitida, chiara
e comprensibile.
(Arthur Koestler, Lo Yogi e il commissario, Liberal 2002).
Come ogni altra disciplina, la psichiatria dipende dalle proprie premesse di
base; le convinzioni dello psichiatra circa la natura della mente umana
determineranno e limiteranno lo scopo, la direzione e il risultato dei suoi
sforzi. Più di ogni altra disciplina, però, la psichiatria è, in ultima analisi,
autoriflessiva: soggetto e oggetto sono identici, la mente studia se stessa e
ogni assunto ha un’inevitabile tendenza all’autovalidazione. Da qui deriva la
ricerca costante di un «punto di Archimede» che ha condotto al tentativo di
individuare un’analogia soddisfacente tra la mente e altri settori della
conoscenza.
Il modello epistemologico (origine, natura, metodi e limiti della
conoscenza) dominante di ogni periodo storico è stato applicato anche
all’anima: abbiamo visto il modello teologico del Medio Evo essere
rimpiazzato da una deificazione della Ragione; tale divinità è stata poi
detronizzata dalle teorie romantiche e sentimentali dei filosofi della natura e
della loro tutt’ora indimenticata scoperta dell’inconscio. Nel diciannovesimo
secolo il modello medico è stato l’approccio indiscusso e all’inizio del
ventesimo secolo la psichiatria ha ricevuto il suo più grande impulso
dall’applicazione del primo principio della termodinamica al funzionamento
della mente.
Questi fenomeni sono poi stati considerati come il risultato di un’ipotetica
interazione di forze che sembrava seguire rigorosamente le leggi fisiche della
conservazione e della trasformazione dell’energia, dove, per citare Norbert
Wiener, «il materialismo ha dato apparentemente ordine alla propria
grammatica e tale grammatica è dominata dal concetto di energia».
2
In considerazione di questa dipendenza storica del pensiero psichiatrico
dall’epistemologia dominante dell’epoca, non sorprende che la psichiatria e le
scienze sociali in genere siano state profondamente influenzate dalla rapida
evoluzione delle conoscenze avvenuta dopo la fine della Seconda guerra
mondiale. Tra le molte nuove dimensioni, una ha avuto un particolare impatto
sulla conoscenza dell’uomo: quella dell’informazione, che si aggiunge ai
concetti classici di materia ed energia. La scoperta che l’informazione su un
effetto, se si verifica un adeguato feedback verso l’effettore, garantisce una
stabilità interna di quest’ultimo e il suo adattamento al cambiamento
ambientale, non solo ha aperto la porta alla costruzione di macchinari di più
alto livello (che controllano gli errori, o ricercano l’obiettivo) e ha condotto
agli assunti della cibernetica (i metodi di controllo e comunicazione sono
identici negli esseri viventi e nelle macchine) come si trattasse di una nuova
epistemologia, ma ha anche fornito intuizioni completamente nuove riguardo
al funzionamento dei sistemi biologici e sociologici.
La transizione dalla psicodinamica come principio esplicativo all’analisi
della comunicazione rispecchia l’evoluzione dalla meccanica tradizionale alla
cibernetica. In entrambi i casi il nuovo modello aggiunge una dimensione
completamente nuova al vecchio. Come è noto, il modello psicoanalitico
della mente postula che l’Io sia il mediatore tra le forze dell’Es, le pretese del
Super Io e le contingenze dell’ambiente. I primi scritti di Freud e dei suoi
seguaci erano centrati quasi esclusivamente sull’Es e le sue dinamiche;
l’esplorazione del Super Io venne in un secondo momento, mentre la
psicologia dell’Io è un’evoluzione relativamente recente della ricerca
psicoanalitica. Questi sviluppi vanno di pari passo con la transizione dalla
patologia (origine, natura, causa della malattia) di Virchwian (antropologo
tedesco, leader politico, 1821-1902), attraverso la fisiologia, fino
all’epidemiologia. È piuttosto interessante, comunque, che l’interdipendenza
tra organismo e ambiente – sebbene fondamentalmente riconosciuta –
rimanga un settore di studio curiosamente trascurato, ed è precisamente qui
che il concetto di scambio di informazioni, ovvero la comunicazione, diviene
indispensabile.
Un eminente psichiatra, Thomas Hora, ha affermato: «Per comprendere se
stesso, l’uomo ha bisogno di essere capito dall’altro». Questa convincente
affermazione presuppone che gli individui coinvolti siano capaci di
comunicare tra loro, e implica inoltre che senza altre persone con le quali
comunicare, un individuo si troverebbe solo e anche confuso. Lo stesso detto
di Cartesio – «Cogito, ergo sum: Penso, dunque sono» –, anche se inteso
come assiomatico, in ultima analisi equivale all’autoconsapevolezza in
termini di relazione. Non può infatti esserci un pensiero senza un contenuto o
senza un oggetto o fuori da un contesto; il pensiero in sé e per sé non è
pensabile. Di conseguenza, senza «qualcosa» a cui pensare neanche Cartesio
sarebbe stato consapevole di se stesso. A questa, si potrebbe aggiungere
un’altra considerazione molto importante tratta dalla semantica generale: la
parola non è la cosa e «cogito», «ergo» e «sum» sono astrazioni di relazioni
strutturate in modo complesso.
L’approccio comunicazionale al fenomeno del comportamento umano –
normale e anormale – è basato sulle manifestazioni osservabili della relazione
nel senso più ampio e non su entità ipotetiche all’interno della mente, come
viene postulato dalla psicodinamica. Questo orientamento porta a inserire lo
studio della comunicazione umana nell’ambito molto rispettabile delle
scienze matematiche che, dopo tutto, sono le scienze più immediatamente
inerenti alla misurazione delle relazioni tra le cose, piuttosto che alla natura
delle cose. Purtroppo dobbiamo affrettarci ad aggiungere che l’affinità del
nostro settore di studio con la matematica si conclude qui: siamo ancora
molto lontani da un modello matematico della comunicazione umana o, come
dice Warren S. McCulloch: .
Ancora non abbiamo una logica realistica né un calcolo utile
delle relazioni tra più di due elementi. A ha dato B a C, A
sembra B a C, A pensa, spera, sogna che B sia C: sono tutte
relazioni al di là della nostra comprensione. Se e quando noi
psichiatri diciamo cose senza senso di queste relazioni – e lo
facciamo – possiamo tutti sostenere che sia perché non esiste
ancora un calcolo adeguato.
Il lettore non dovrebbe sorprendersi, quindi, se le argomentazioni che
seguono saranno di natura inevitabilmente molto frammentaria. Lo studio
della comunicazione umana, come definito da noi stessi altrove, è l’indagine
di come le persone si influenzano tra loro tramite messaggi veicolati dal
comportamento, di come approvano o disapprovano, di come reciprocamente
siano fonte d’ispirazione o riescano a far impazzire.
Più in generale, potremmo dire che si tratta dello studio dell’interazione tra
gli organismi umani e il loro ambiente, percepito come realtà e, dunque, lo
studio dei loro specifici modelli e delle loro esperienze in quanto esseri
viventi nel mondo. Da ciò consegue che la teoria della comunicazione deve
riconoscere la propria affinità con un altro campo, ovvero la filosofia
esistenziale che studia l’uomo nel qui e ora del suo essere e, a differenza di
altre filosofie, considera che esistono cose come i disturbi emotivi. Tracciata
in questo modo la definizione del nostro campo di studio, possiamo ora
continuare con un approccio più concreto e sempliceSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
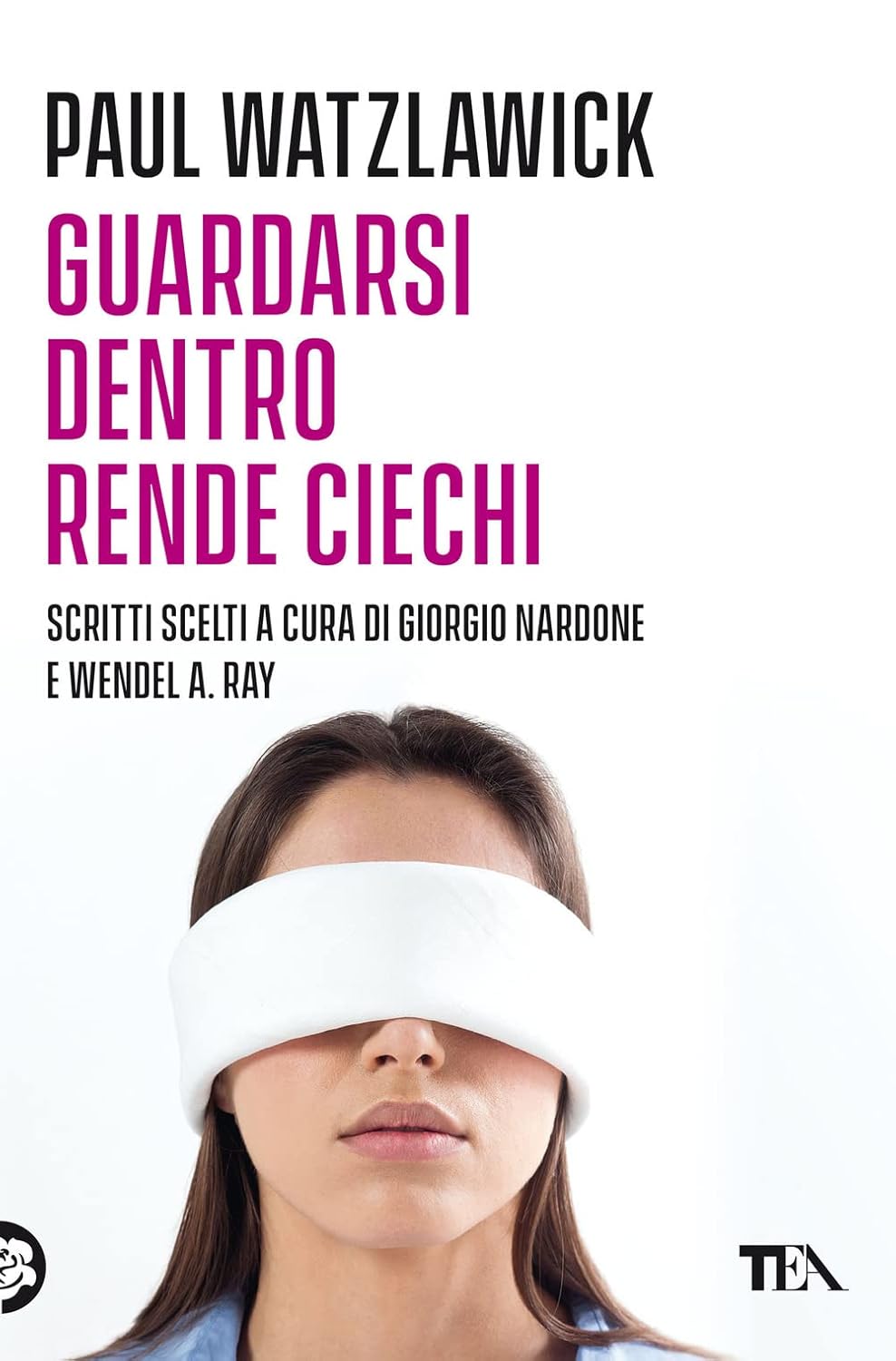






Commento all'articolo