Storia dell’Italia partigiana – Giorgio Bocca
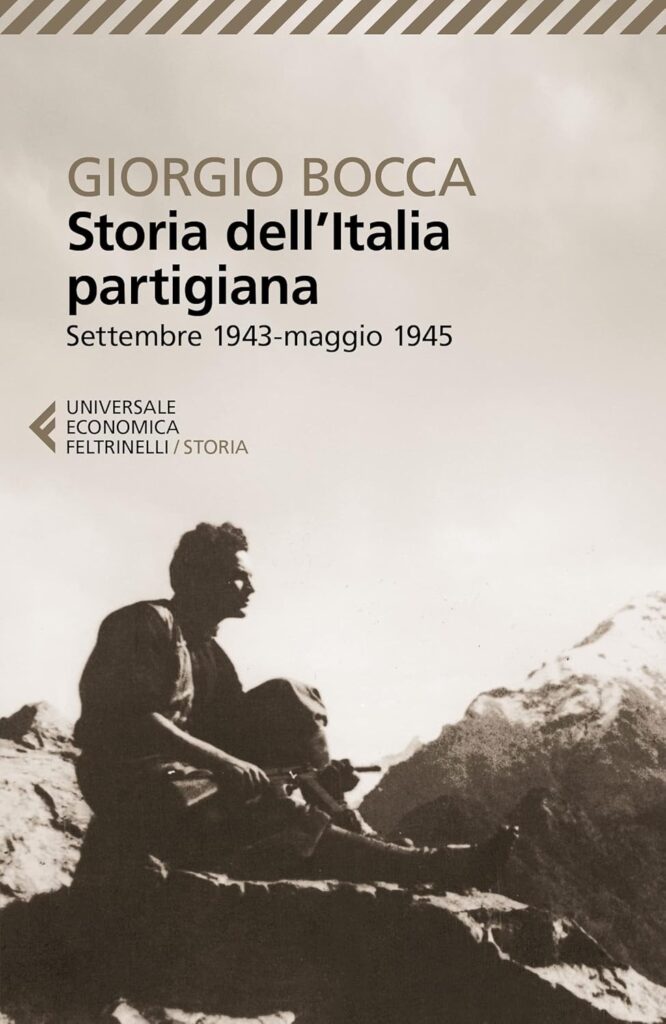
SINTESI DEL LIBRO:
La guerra dell'Italia partigiana incomincia quando finisce
la guerra del regime, l'armata partigiana si forma dopo la
disfatta di quella regia e fascista. Nessun comparto
organico, sia pure un semplice plotone, passa compatto ai
ribelli.
1
L'esercito regolare muore per dissanguamento e per
abbandono: schiacciato da una guerra più grande di lui, ma
anche lasciato a sé, nelle ore dell'agonia, dal re e dal
comando supremo. Il cinismo del re e della corte è mediocre
ma implacabile: dopo il colpo di stato del 25 luglio 1943, con
cui si sono dissociati, a guerra persa, dal fascismo, essi
sanno che l'esercito non può rendergli altri servigi e ne
traggono le conseguenze, lo abbandonano, confidano
unicamente nella diplomazia tradizionale delle monarchie
sconfitte: il ricatto del legittimismo, l'appello alle alleanze
permanenti del sistema e della classe, da noi una monarchia
che si offre ai vincitori come unica diga contro la sovversione
comunista. Il re e la corte preparano il rovesciamento delle
alleanze promettendo agli anglo-americani l'intervento
armato delle divisioni superstiti, ma già decisi a non
servirsene. Non è facile nella storia in rapido movimento
fissare il tempo esatto di un abbandono che si compie giorno
per giorno, le paure della corte sommandosi ai pudori
inconfessabili, i pregiudizi all'inettitudine. Perché il ripudio
dell'esercito è anche mancanza di intelligenza e di fantasia, è
anche il ricorso alla soluzione più facile: si sciolgano le
armate, avvenga quello che avvenga ai reduci delle
sfortunate, spesso gloriose battaglie, purché si salvi il
gruppo di potere che sta attorno al re, questa corte la quale
crede o finge di credere che la sua salvezza coincida con
quella del paese. La ricostruzione dell'esercito
“instrumentum regni” avverrà dopo, a Italia liberata dagli
anglo-americani, sotto la loro protezione, evitando l'insidia
delle milizie popolari. È la soluzione più facile, non la più
dignitosa e lungimirante.
Il sacrificio dell'esercito alla segretezza dei negoziati
armistiziali è ampiamente documentato. Gli ordini che il
comando supremo invia alle grandi unità, ambigui come i
suoi silenzi, sono dettati da quell'unica preoccupazione: che
nulla trapeli, che l'alleato tedesco resti incerto
nell'incertezza dei nostri soldati. L'annuncio dell'armistizio
con gli anglo-americani dato da Badoglio l'8 settembre è il
degno suggello, neppure nell'ora della decisione il capo del
governo regio osa dire chiaro e netto ciò che l'avvocato
Duccio Galimberti ha gridato su una piazza il 25 luglio:
guerra al tedesco.
Abbandonato dai suoi capi supremi l'esercito non sa
darsene di nuovi, non sa decidere da solo. Ormai è un
grande corpo inerte, paralizzato da sentimenti confusi di
vergogna e di paura. Nei gradi superiori anche la paura di
pregiudicare una eventuale santa alleanza antibolscevica: il
tedesco come possibile alleato in una futura crociata. Gli
ufficiali di professione aspettano gli ordini che non vengono,
i soldati sono stanchi, il destino comune è la disfatta. Il
giorno dell'armistizio tutto va come deve andare: il tedesco,
che lo ha previsto nei particolari, attacca. Il feldmaresciallo
Erwin Rommel liquida le nostre armate al Nord, il
feldmaresciallo Albert Kesselring quelle del Sud mentre si
oppone agli Alleati, sbarcati a Salerno e a Taranto.
La resa di Roma è rapida, vergognosa. Più vergognosa
ancora è la fuga del re verso Brindisi. Si salvano la flotta,
pochi aerei, poche divisioni.
L'esercito regio e fascista si è disfatto rifiutando fino
all'ultimo di aiutare la formazione di quello popolare.
Documentiamo questo rifiuto.
Esercito e ribellione
I promotori della Resistenza hanno chiesto l'aiuto
dell'esercito dall'agosto. Il 30 di quel mese Luigi Longo, a
nome dei partiti antifascisti, ha ricordato per iscritto a
Badoglio «la necessità di stabilire in tutte le località dei
contatti e degli accordi, tra i comandanti militari e i
rappresentanti del Fronte nazionale, per far fronte a tutte le
esigenze della lotta». Ora, all'annuncio dell'armistizio, gli
antifascisti domandano all'esercito ordini e armi, a Roma una
delegazione composta da Luigi Longo (comunista), Riccardo
Bauer (azionista), Sandro Pertini (socialista) va dal generale
Giacomo Carboni, cui è affidata la difesa della capitale, per
proporgli la formazione di una guardia nazionale. Il generale
fa qualche promessa, dà qualche arma, ma non è autorizzato
ad accettare l'offerta.
2 L'esercito non vuole l'aiuto del popolo
perché non vuole le sue milizie. Il divorzio fra esercito e
popolo è antico come l'unità del paese, come la questione
garibaldina; lo ha pronunciato nel 1860 il generale Manfredo
Fanti: «I volontari sono elemento prezioso in date
circostanze e condizioni, ma in altre allarmante, molesto…»;
3
e la chiusura verso il popolo permane, dalle accademie
continuano a uscire ufficiali educati al disprezzo per i civili e
all'odio per i «sovversivi», convinti di servire la patria
servendo la casta e la classe, forniti di una cultura politica
provinciale e reazionaria. La ragione profonda di tutti i no
dell'esercito alla Resistenza che nasce la dice con parole
semplici un ufficiale: «Ma come potevamo capire la
Resistenza in Italia se non l'avevamo capita né in Francia, né
in Grecia, né in Jugoslavia? Per noi i partigiani di quei paesi
erano dei banditi, dei sovversivi, una mala erba da estirpare
e basta». Ignoranza, presunzione.
Nei giorni dell'armistizio l'ufficialità pensa e dice ai civili
che le chiedono armi per combattere: «Se non lo facciamo
noi che siamo militari, perché dovreste farlo voi borghesi?».
4
Tullio Giordana scriva pure sulla «Gazzetta del Popolo»: «Se
saremo aggrediti in casa possiamo difenderci, e questa volta
dietro i soldati ci sarà tutto il popolo italiano come sul
Piave».
5 Intanto i generali dicono no. A cominciare da quello
che comanda la piazza di Torino.
La serie dei no
Il suo nome è Enrico Adami Rossi. Salgono il 9 settembre
al comando i rappresentanti del fronte interpartitico: Livio
Pivano, Franco Antonicelli, Aurelio Peccei, Luigi Capriolo e
Filippo Burzio. Ma il generale non li riceve.
6 I tentativi degli
operai di organizzare una guardia nazionale e un fronte
italiano della Resistenza falliscono: mancano le armi,
l'esercito rifiuta di fornirle. Il 10 settembre la delegazione
antifascista torna dal generale. Adami Rossi li accoglie in
piedi, il petto fregiato da una decorazione tedesca. Promette
di difendere la città, non accetta le offerte di collaborazione,
chiede ai delegati di «mantenere l'ordine fra la popolazione».
Come lo ha mantenuto l'ufficiale a cui ha fatto avere il suo
alto elogio pochi giorni prima: «Con rapido intuito e piena
comprensione del suo dovere, in relazione alle direttive
ricevute, lanciava una bomba a mano contro un gruppo di
operai che, riottoso, faceva opera di sobillazione alla ripresa
del lavoro».
7
Uscendo dall'ufficio gli antifascisti incontrano il generale
Bernardo Cetroni; assicura che l'ordine di resistere è stato
dato ai reparti, autorizza una piccola consegna di armi. Nel
pomeriggio gli operai si riuniscono davanti alla camera del
lavoro per ascoltare i rappresentanti dei diversi partiti. Ma
Adami Rossi non fa distinzioni, lui ha fatto piazzare una
mitragliatrice alle spalle degli oratori. Forse perché ha già
inviato un ufficiale a trattare la resa con i tedeschi, le cui
avanguardie sono a Chivasso. I tedeschi entrano in città
verso sera alla loro maniera spavalda e minacciosa: pochi
carri armati che percorrono le strade brandeggiando i
cannoni. Adami Rossi è andato al loro comando per dare il
benvenuto.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
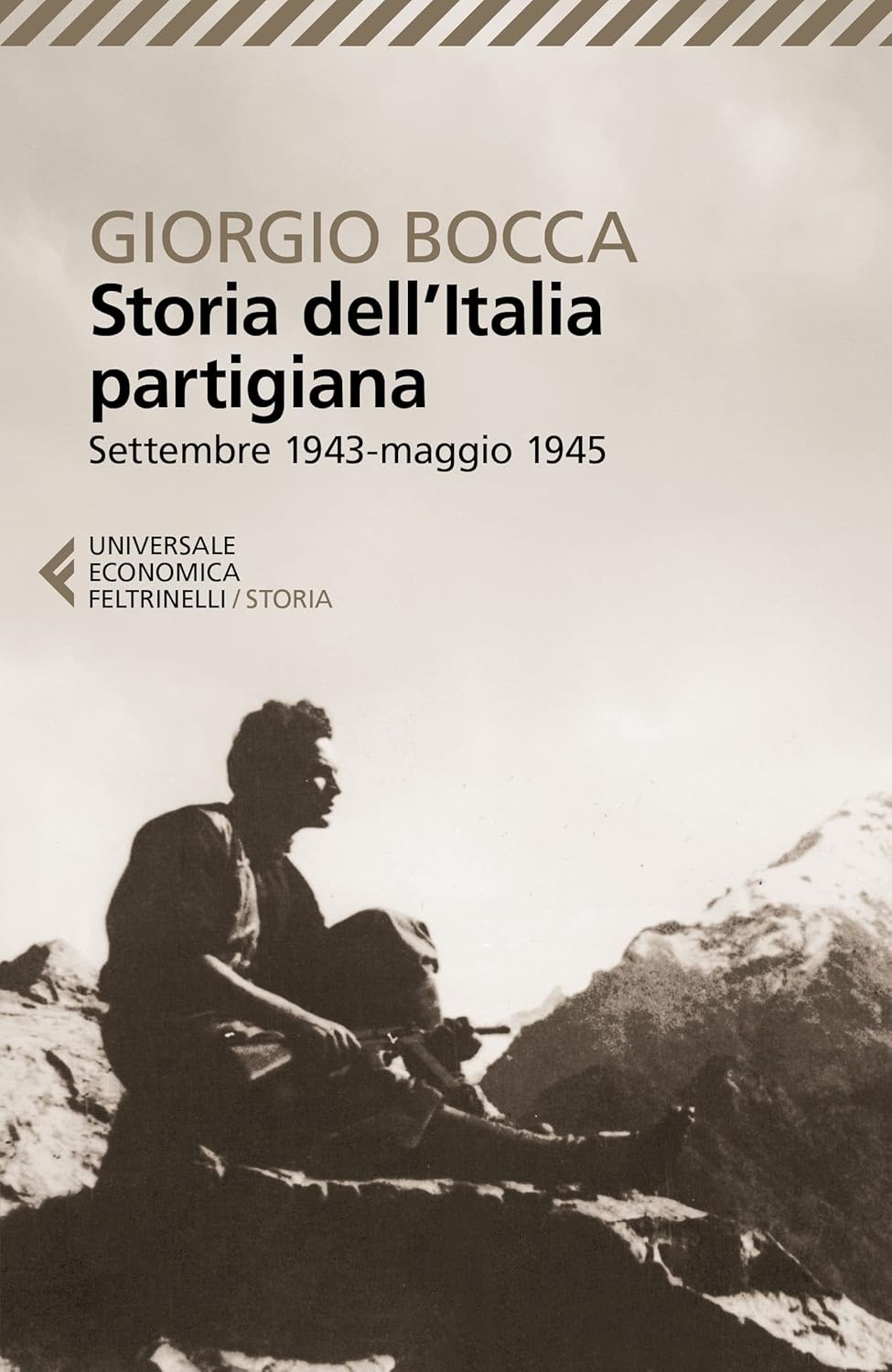






Commento all'articolo