L’incontinenza del vuoto: Pennacchi economico-filosofici- Slavoj Žižek
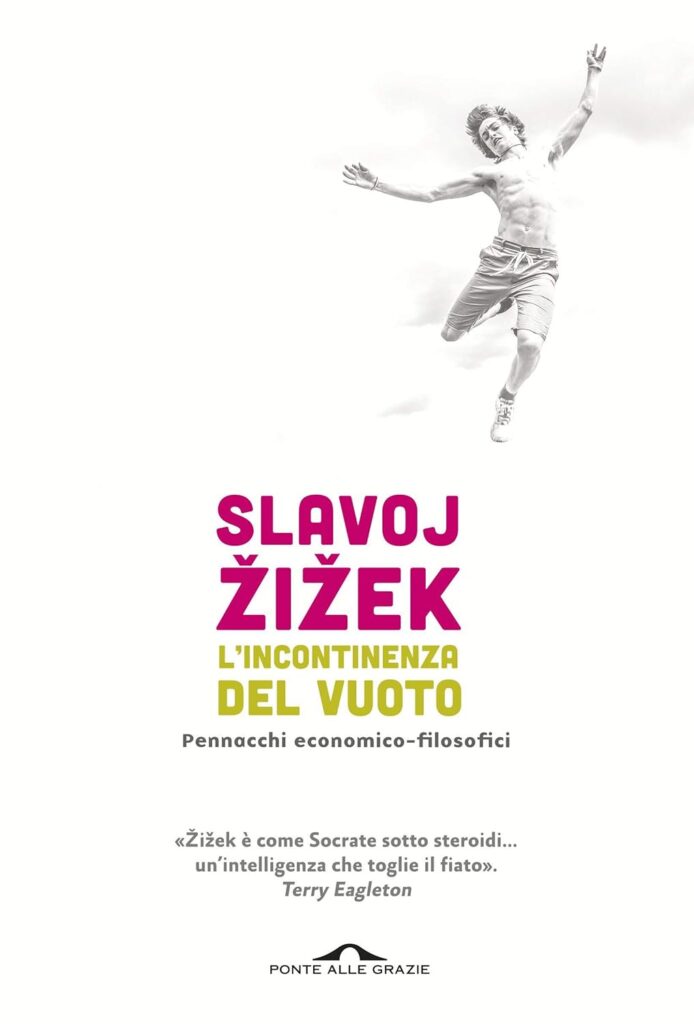
SINTESI DEL LIBRO:
SOS: sessualità, ontologia, soggettività
La sigla «UPS» ha, nel nostro linguaggio quotidiano, due significati
principali: United Parcel Service
1 e gruppo statico di continuità
(Uninterruptible Power Supply), ovvero un’apparecchiatura dotata di una
batteria che garantisce la corrente elettrica nel caso di un’interruzione; ad
esempio, un UPS permette a un computer di rimanere in funzione alcuni
minuti dopo un’interruzione di corrente in modo da poter salvare i dati. In
ogni caso, l’oggetto di questo libro è un altro UPS: la buona vecchia triade
filosofica di Universale, Particolare e Singolare, e in un senso molto preciso.
Universale sta per ontologia, Particolare per sessualità e Singolare per
soggettività: una triade di SOS. 2 Perché? C’è qualcosa di più importante di
un banale gioco di parole in questo SOS? Il lettore attento si sarà accorto che
SOS inverte l’ordine dei termini rispetto a UPS: con SOS abbiamo PUS
(particolare) sessualità, (universale) ontologia, (singolare) soggettività.
Perché questa precedenza data alla sessualità rispetto all’ontologia, e perché
questo innesca un SOS, un segnale di emergenza? La risposta è semplice:
perché evidenzia il definitivo fallimento e il limite di qualunque ontologia.
Dal punto di vista lacaniano, dire che «non c’è relazione sessuale» non è solo
l’assioma sotteso alla sessualità umana, e che la determina come
fondamentalmente antagonistica, ma un assioma con implicazioni
ontologiche radicali, che pone il carattere antagonista (incompleto,
«imperfetto») della realtà stessa, l’impossibilità di coglierla come un Tutto; e
la soggettività può darsi solo in una realtà che è ontologicamente incompleta,
attraversata da un’impossibilità.
Il che significa anche che il soggetto è immanentemente, costitutivamente
sessuato: non basta dire che il soggetto emerge quando la sostanza è nontutto, antagonista, inconsistente; il termine di mediazione qui è sessualità,
ovvero, per avere un soggetto, l’antagonismo (l’impossibilità) che taglia la
realtà deve acquisire una forma di sessualità, dell’impossibilità della
relazione sessuale. E viceversa, ovviamente: se combiniamo solo ontologia e
sessualità (la differenza sessuale) senza soggettività, otteniamo la visione
cosmologica tradizionale della realtà caratterizzata dall’eterna lotta dei due
«principi», il maschile e il femminile (yin e yang, luce e ombra, forma e
materia, ecc.). Poi la terza variazione: se combiniamo solo la differenza
sessuale e la soggettività, tralasciando le implicazioni ontologiche, non
otteniamo propriamente la soggettività ma semplicemente degli agenti umani
sessualizzati che si adattano perfettamente a un’ontologia realista come alla
propria sfera speciale, ovvero dalla rottura kantiana regrediamo all’ontologia
tradizionale. È stato Kant che, nello spiegare le antinomie della ragion pura,
ha fatto il primo passo verso il triangolo costituito da fallita ontologia,
soggettività e implicazioni ontologiche della differenza sessuale: una volta
che prendiamo in considerazione la concettualizzazione lacaniana della
differenza sessuale, l’omologia strettamente formale fra la dualità kantiana di
antinomie matematiche e dinamiche e le formule della sessuazione lacaniane
è evidente. Inoltre, Kant interpreta le antinomie della ragion pura come una
limitazione a priori rispetto a qualunque tentativo di costruire un’ontologia
coerente.
Perché, dunque, tutta questa enfasi sull’impossibilità dell’ontologia? Al
giorno d’oggi l’analisi decostruzionista del discorso sta perdendo terreno a
favore del proliferare di nuove ontologie: dall’ipercritica e trascendente
problematizzazione di ogni affermazione ontologica (Quali sono le
condizioni della sua possibilità? Su quali presupposti nascosti si deve basare?
ecc.) stiamo passando a una molteplicità di nuove ontologie che sostituiscono
la posizione critica con una (talvolta finta) ingenuità realista (nuovo
materialismo, realismo speculativo, ontologia orientata all’oggetto…). Il
progetto di SOS è quello di indicare una terza via: rompere con l’approccio
critico-trascendentale senza allo stesso tempo regredire a un’ontologia
realista precritica. Molte delle critiche che sono state mosse al mio lavoro
sono dovute al fraintendimento, da parte dei critici, di questo aspetto centrale.
Nella sua acuta lettura del saggio Repeating Žižek, Jamil Khader osserva
come alcuni degli autori si interroghino
sulle qualifiche di Žižek in quanto filosofo, in particolare in relazione alla critica
fatta da Badiou alla posizione anti-filosofica di Lacan. Hamza sottolinea, infatti,
che ai filosofi di area žižekiana viene sempre ricordato che, rispetto a Žižek, «non è
poi difficile essere seguaci di Badiou, o essere badiouiani in filosofia, grazie al suo
sistema così ben strutturato». In questo senso, Noys cautamente ripete
l’affermazione di Badiou secondo la quale Žižek «non si trova esattamente nel
campo della filosofia», ma solo per proporre di considerare Žižek come un «lettore
della filosofia», che offre dunque non una filosofia ma un metodo.
Bruno Bosteels si schiera ancora più nettamente contro l’idea di una filosofia
žižekiana. Sostiene che, dopo il decollo della sua carriera internazionale, Žižek
abbia lottato strenuamente per dissociarsi dal campo dei Cultural studies,
all’interno dei quali il suo lavoro era stato inizialmente recepito e «frainteso», per
affermarsi ufficialmente come filosofo. Scrive Bosteels: «Così, mentre Badiou
dopo aver completato L’essere e l’evento parla dall’interno della roccaforte di una
filosofia di stampo classico o neoclassico, sventolando la bandiera del platonismo
con una sicurezza sufficiente da accettare la sfida di un anti-filosofo come Lacan,
Žižek è ancora lì che si sforza di sminuire le ultime provocazioni anti-filosofiche di
Lacan per potersi guadagnare la rispettabilità di un filosofo». Per Bosteels, questo
sembra dare una spiegazione abbastanza chiara del «proverbiale nervosismo» di
Žižek. I suoi tic tradiscono semplicemente l’ansia di essere escluso dai prestigiosi
circuiti istituzionali e dai dipartimenti di filosofia, che siano in Slovenia, in Gran
Bretagna o in Francia. Come tale, interpreta il ruolo dell’isterico rispetto al
«discorso del padrone di uno stoicamente imperterrito Badiou». 3
Ritengo queste critiche al mio lavoro problematiche sotto vari aspetti,
anche volendo ignorare, per mantenere un tono civile, l’attribuzione, in modo
decisamente «problematico», dei miei tic (fra parentesi, le conseguenze di
una malattia per cui mi sto curando) all’ansia di essere escluso dal mondo
accademico e di non essere riconosciuto come filosofo «serio» (possiamo
anche solo immaginare la levata di scudi in nome del politicamente corretto
se in questo stesso modo fosse stato «analizzato» un altro pensatore,
mettiamo, ad esempio, una lesbica femminista?). Primo, io propongo davvero
una sorta di «ontologia»: il mio lavoro non è solo una riflessione
decostruzionista sulle contraddizioni delle altre filosofie, ma definisce un
certa «struttura di realtà». O, per dirla in termini kantiani estremamente
semplificati: l’ultimo orizzonte del mio lavoro non è la narrazione multipla
dei fallimenti cognitivi rispetto al fondale inaccessibile del Reale. Il
movimento «al di là del trascendente» viene definito nella prima parte di
Contraccolpo assoluto, in cui analizzo minuziosamente il movimento
dialettico di base, quello del rovesciamento dell’ostacolo epistemologico
nell’impossibilità ontologica che caratterizza la Cosa in sé: proprio il
fallimento del mio sforzo di afferrare la Cosa deve essere (ri)concepito come
una caratteristica della Cosa, come un’impossibilità iscritta proprio al cuore
del Reale. (Un altro passo in questa direzione è il modo in cui ho elaborato la
quasi-ontologia del «meno di niente» nella mia lettura delle implicazioni
ontologiche della fisica quantistica).
Ma il cuore del problema sta altrove: nell’applicare alla filosofia la
contrapposizione fra Padrone e Isterica. Per riassumere una lunga storia: se
identifichiamo la vera filosofia con un discorso stoicamente imperterrito o
con quello del Padrone, allora filosofi come Kant e Hegel non sono più
filosofi. Dopo Kant, una «filosofia di stampo classico o neoclassico», ovvero
una filosofia come «visione del mondo», come una grande interpretazione
della struttura di base della realtà nella sua interezza, semplicemente non è
più possibile. Con la svolta critica di Kant, il pensare «non si trova
esattamente nel campo della filosofia», e offre «non una filosofia ma un
metodo»: la filosofia diventa auto-riflessiva, un discorso che analizza le sue
stesse condizioni di possibilità – o, più precisamente, di impossibilità. In
breve, Kant è generalmente impegnato nei prolegomeni alla metafisica vera e
propria, una danza preparatoria che rimanda continuamente il salto nell’acqua
fredda della cosa in sé. La metafisica (la descrizione della struttura razionale
e gerarchica dell’universo) si trova necessariamente intrappolata nelle
antinomie, e le illusioni sono inevitabilmente necessarie per riempire i vuoti
insiti nella struttura; in breve, con Kant la filosofia non è più un discorso del
Padrone, tutto il suo edificio è attraversato dalla barra dell’impossibilità
immanente, del fallimento, dell’incongruenza. Con Hegel, le cose vanno
ancora oltre: ben lungi dal tornare a una metafisica precritica razionale
(secondo le accuse dei kantiani), tutta la dialettica hegeliana è una sorta di
isterico indebolimento del Padrone (il motivo per cui Lacan chiama Hegel «il
più sublime di tutti gli isterici»), l’immanente auto-distruzione e autosuperamento di qualunque affermazione metafisica. In breve, il «sistema» di
Hegel non è altro che un percorso sistematico attraverso i fallimenti dei
progetti filosofici. In questo senso, tutto l’idealismo tedesco non è altro che
un esercizio di «anti-filosofia»: il pensiero critico di Kant non è direttamente
filosofia ma il prolegomeno a una futura filosofia, un interrogarsi sulle
condizioni della
(im)possibilità della filosofia; Fichte definisce il proprio pensiero non più
filosofia ma Wissenschaftslehre («dottrina della scienza»); e Hegel afferma
che il suo pensiero non è più soltanto una filo-sofia («amore della sapienza»),
ma la vera sapienza (conoscenza) in sé. È il motivo per cui Hegel è «il più
sublime di tutti gli isterici»: dovremmo inoltre tenere presente che, per Lacan,
solo l’isteria produce nuova conoscenza (al contrario di quanto fa il discorso
dell’Università, che la riproduce soltanto).
Fintanto che la filosofia (l’ontologia tradizionale) rimane un esempio di
discorso del Padrone, la psicoanalisi agisce come l’agente della sua
immanente isterizzazione. Si può affrontare adeguatamente il tema «Lacan e
la filosofia» solo evitando la trappola di una linea di demarcazione netta fra i
due: la psicoanalisi come pratica clinica specifica da una parte, la riflessione
filosofica dall’altra. Quando Lacan afferma, enfaticamente, je m’insurge
contre la philosophie, sta, evidentemente, identificando la filosofia con una
«visione del mondo», una visione dell’universo come Intero che abbraccia
tutte le divisioni e le contraddizioni. Quando invece un filosofo ignora la
portata filosofica della psicoanalisi sta, evidentemente, riducendola a una
pratica clinica specifica inerente a un particolare fenomeno ontico (quello
delle patologie psicologiche). Hanno torto entrambi: ciò che a entrambi
sfugge è (non qualche forma superiore di unità sintetica delle due ma) la loro
intersezione; la relazione che intercorre fra di loro è la stessa dei due lati del
nastro di Möbius, dove cercando di arrivare al cuore di uno di essi ci
ritroviamo nel suo opposto. Nel corso di tutto il suo insegnamento, Lacan
portò avanti un intenso dibattito con la filosofia e con i filosofi, dai
materialisti dell’antica Grecia a Platone, dagli stoici a Tommaso d’Aquino, da
Descartes a Spinoza, da Kant a Hegel, da Marx a Kierkegaard, da Heidegger
a Kripke. È facendo riferimento ai filosofi che Lacan spiega i suoi concetti
fondamentali: il transfert attraverso Platone, il soggetto freudiano attraverso il
cogito di Descartes, l’objet a come un plus-godimento attraverso il plusvalore
di Marx, l’angoscia e la ripetizione attraverso Kierkegaard, l’etica della
psicoanalisi attraverso Kant, e così via. In questo suo continuo confronto,
Lacan prende ovviamente le distanze dalla filosofia (basti ricordare la sua –
piuttosto infelice – continua derisione dell’Aufhebung hegeliano, o la sua
autocoscienza in opposizione al soggetto diviso/barrato di Freud); in ogni
caso, tutto questo sforzo disperato di tracciare continuamente una linea di
demarcazione non fa altro che riaffermare la sua dedizione alla filosofia,
come se, per Lacan, l’unico modo per definire le basi della psicoanalisi fosse
attraverso un detour filosofico. Anche se la psicoanalisi non è filosofia, tutta
la sua portata sovversiva ha origine dal fatto che non si tratta semplicemente
di una scienza o pratica qualsiasi ma comporta delle conseguenze radicali per
la filosofia: la psicoanalisi è un «no» alla filosofia che si trova al suo interno,
ovvero la teoria psicoanalitica fa riferimento a una lacuna/antagonismo che la
filosofia offusca ma che, allo stesso tempo, ne costituisce il fondamento
(Heidegger ha chiamato questa lacuna «differenza ontologica»). Senza questo
collegamento con la filosofia – più precisamente, con il punto cieco della
filosofia, con ciò che è «originariamente rimosso» in filosofia – la
psicoanalisi perde la sua dimensione sovversiva e diventa solamente una
pratica ontica fra le tante. Il Reale con cui la psicoanalisi si confronta non è
solo la realtà della sofferenza psicologica del soggetto ma, in modo molto più
radicale, le implicazioni (anti)filosofiche della lettura fatta da Freud di questa
sofferenza.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :







Commento all'articolo