La cripta dei cappuccini – Joseph Roth
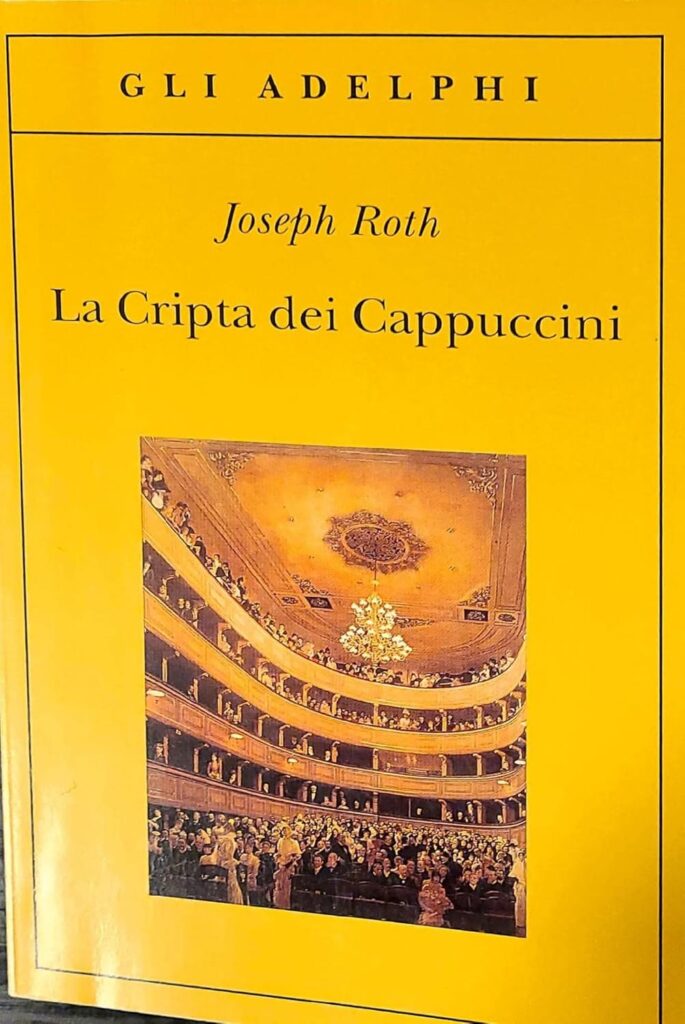
SINTESI DEL LIBRO:
«Il nostro nome è Trotta. La nostra casata è originaria di Sipolje, in Slovenia.
Casata, dico; perché noi non siamo una famiglia. Sipolje non esiste più, da
tempo ormai. Oggi, insieme con parecchi comuni limitrofi, forma un centro più
grosso. Si sa, è la volontà dei tempi. Gli uomini non sanno stare soli. Si uniscono
in assurdi aggruppamenti, e soli non sanno stare neanche i villaggi. Nascono così
entità assurde. I contadini sono attratti dalla città e gli stessi villaggi aspirano per
l'appunto a diventare città.
Tuttavia ho conosciuto Sipolje, quand'ero ragazzo. Una volta mio padre mi
ci portò, un diciassette agosto, la vigilia di quel giorno in cui in tutta la
monarchia, anche nei paesi più piccoli, si festeggiava il compleanno
dell'imperatore Francesco Giuseppe I. Nell'odierna Austria e negli ex territori
della Corona saranno ormai poche le persone nelle quali il nome della nostra
casata risvegli una qualche memoria. Però è registrato negli annali ormai
dimenticati del vecchio esercito austro-ungarico, e confesso che ne sono
orgoglioso, proprio perché quegli annali sono dimenticati. Io non sono un figlio
del mio tempo, anzi, mi riesce difficile non definirmi addirittura suo nemico.
Non che io non lo capisca, come tante volte sostengo. Questa è solo una scusa
di comodo. Per indolenza, semplicemente, non voglio essere aggressivo o
astioso, e perciò dico che una cosa non la capisco quando dovrei dire che la odio
o la disprezzo. Ho l'orecchio fine, ma faccio il sordo. Mi pare più elegante
fingere un difetto che ammettere di aver sentito rumori volgari.
Il fratello di mio nonno era quel semplice Sottotenente di fanteria che nella
battaglia di Solferino salvò la vita all'imperatore Francesco Giuseppe. Al
sottotenente fu conferito un titolo nobiliare. Per lungo tempo nell'esercito e nei
libri di lettura della imperial-regia monarchia egli fu chiamato l'eroe di Solferino,
finché, com'era suo stesso desiderio, calò su di lui l'ombra dell'oblio. Dette le
dimissioni. È sepolto a Hietzing. Sulla sua lapide sono incise le semplici e fiere
parole: «Qui riposa l'eroe di Solferino».
La grazia dell'imperatore si estese anche al figlio, che diventò sottoprefetto, e
al nipote, sottotenente dei cacciatori caduto nell'autunno del 1914 nella battaglia
di Krasne-Busk. Io non ho mai visto né lui, né nessun altro del ramo nobile della
nostra casata. I Trotta nobili erano diventati devoti servi umilissimi di Francesco
Giuseppe. Mio padre invece era un ribelle.
Era ribelle e patriota, mio padre: una specie che è esistita solo nella vecchia
Austria-Ungheria. Voleva riformare l'impero e salvare gli Asburgo. Aveva inteso
troppo bene il senso della monarchia austriaca. Si rese dunque sospetto e
dovette fuggire. Andò, in gioventù, in America. Era chimico di professione. A
quell'epoca c'era bisogno di gente come lui nei colorifici, in grande sviluppo, di
New York e Chicago. Finché era stato povero aveva avuto solo nostalgia
dell'acquavite di grano. Ma quando infine si arricchì, cominciò ad avere nostalgia
dell'Austria. Ritornò sui suoi passi. Si stabilì a Vienna. Aveva denaro, e alla
polizia austriaca piacevano le persone che hanno denaro. Non solo non ebbe
fastidi, ma dette addirittura l'avvio a un nuovo partito sloveno e comprò due
giornali di Zagabria.
Si procurò amicizie influenti nella cerchia più intima dell'arciduca, erede al
trono, Francesco Ferdinando. Mio padre sognava un regno slavo sotto il
dominio degli Asburgo. Sognava una monarchia degli austriaci, degli ungheresi e
degli slavi. E a me, che sono suo figlio, sia concesso dire a questo punto che, se
mio padre fosse vissuto più a lungo, m'immagino che avrebbe potuto forse
cambiare il corso della storia. Invece morì, circa un anno e mezzo prima
dell'assassinio di Francesco Ferdinando. Io sono il suo unico figlio. Nel
testamento mi aveva nominato erede delle sue idee. Non per nulla mi aveva
fatto battezzare col nome di Francesco Ferdinando. Allora, però, io ero giovane
e sciocco, per non dire: sconsiderato. Frivolo, in ogni caso. Vivevo allora per
così dire alla giornata. No! Non è esatto: io vivevo alla nottata; di giorno
dormivo.
II
Una mattina però - fu nell'aprile del 1913 -, rincasato da appena due ore e
ancora intontito dal sonno, mi fu annunciata la visita di un cugino, di un signor
Trotta.
In vestaglia e pantofole andai nell'anticamera. Le finestre erano spalancate,
in giardino i merli mattinieri fischiavano con zelo e il primo sole inondava
allegramente la stanza. La nostra cameriera, che fino a quel momento non avevo
mai visto così di buon'ora, nel suo grembiule blu mi parve una estranea - io la
conoscevo solo come un essere giovane, fatto di biondo, nero e bianco,
qualcosa di simile a una bandiera. Per la prima volta la vedevo in una veste blu
scuro, simile a quella che portavano i meccanici e i gassisti, con uno spolverino
vermiglio in mano - e la sola sua vista sarebbe bastata a darmi una nuova,
inusitata immagine della vita. Per la prima volta, dopo anni, vidi il mattino in
casa mia e mi accorsi che era bello. La cameriera mi piaceva. Mi piacevano le
finestre aperte. Mi piaceva il sole. Mi piaceva il canto dei merli. Era dorato come
il sole di primo mattino. Perfino la ragazza in blu era dorata, come il sole.
Abbagliato da tutto questo oro, sul momento non notai affatto l'ospite che mi
attendeva. Mi accorsi di lui solo dopo un paio di secondi - o forse furono
minuti? Smilzo, nero, silenzioso, se ne stava seduto sull'unica sedia che si
trovava nella nostra anticamera - e come entrai neanche si smosse. Per quanto i
suoi capelli e suoi baffi fossero così neri e la sua carnagione così bruna, aveva
però, in mezzo all'oro mattutino dell'anticamera, qualcosa di solare, forse
qualcosa di un lontano sole meridionale. Alla prima occhiata mi ricordò mio
padre buon'anima. Anche lui era così smilzo e nero, così bruno di pelle e ossuto,
scuro, un autentico figlio del sole, non come noi, i biondi, che del sole siamo
solo i figliastri. Io parlo sloveno, me lo ha insegnato mio padre. E salutai mio
cugino Trotta in sloveno. Sembrò non meravigliarsene affatto. Era cosa ovvia.
Non si alzò, restò seduto, e mi porse la mano, sorridendo. Sotto il nero bluastro
dei baffi scintillava il bianco candido dei grandi denti forti. Mi dette subito del
tu. Sentii che era un fratello, non un cugino! Il mio indirizzo l'aveva avuto dal
notaio. «Tuo padre» cominciò «mi ha lasciato per testamento 2000 fiorini e io
sono qui per ritirarli. Sono venuto da te per ringraziarti. Domani tornerò a casa.
Ho anche una sorella, ora la voglio maritareSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
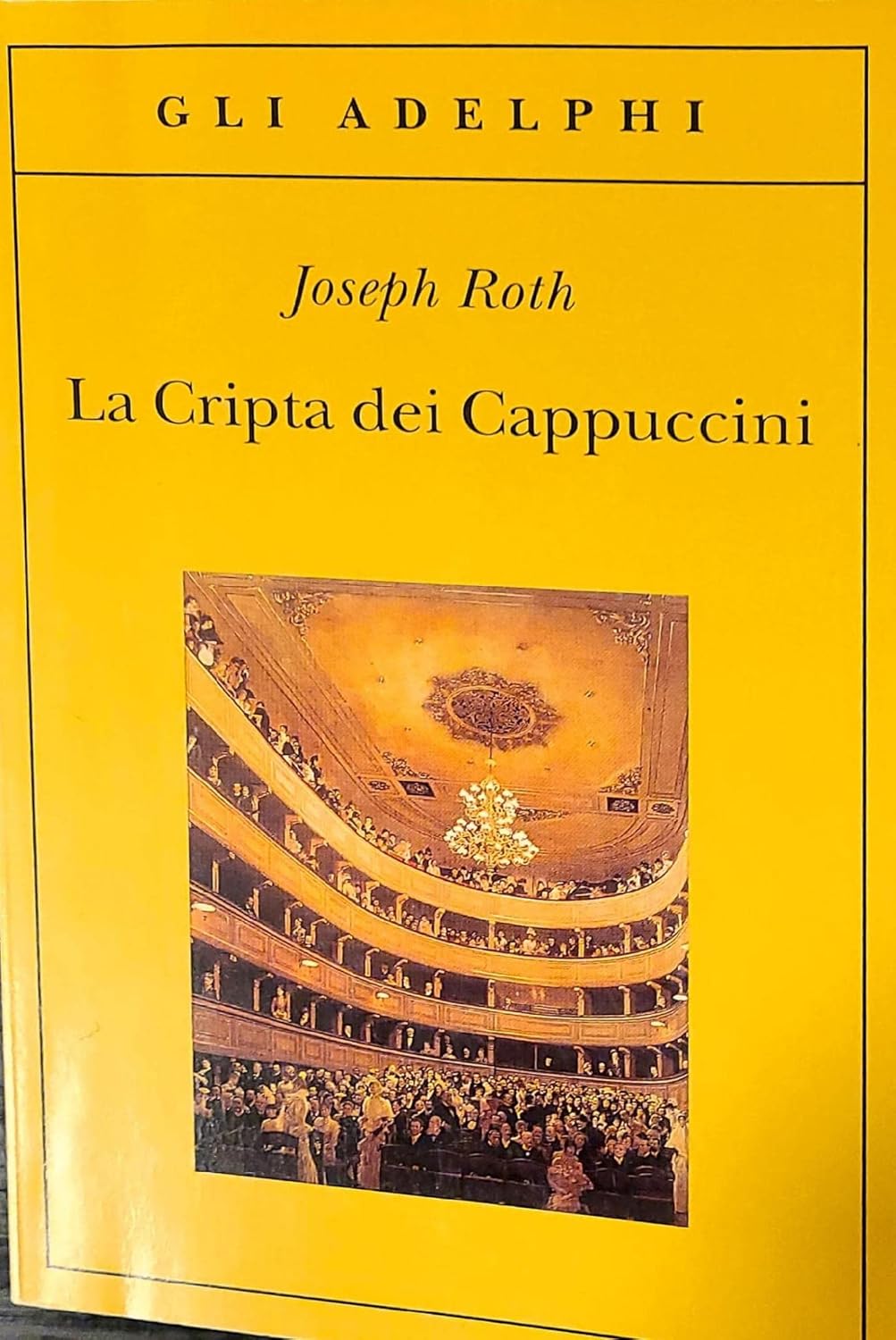



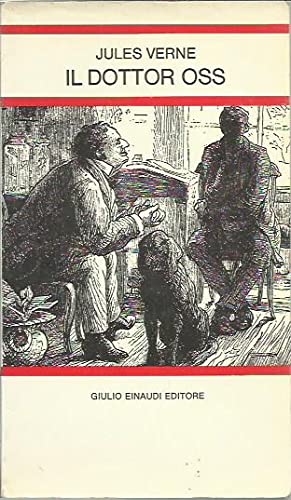
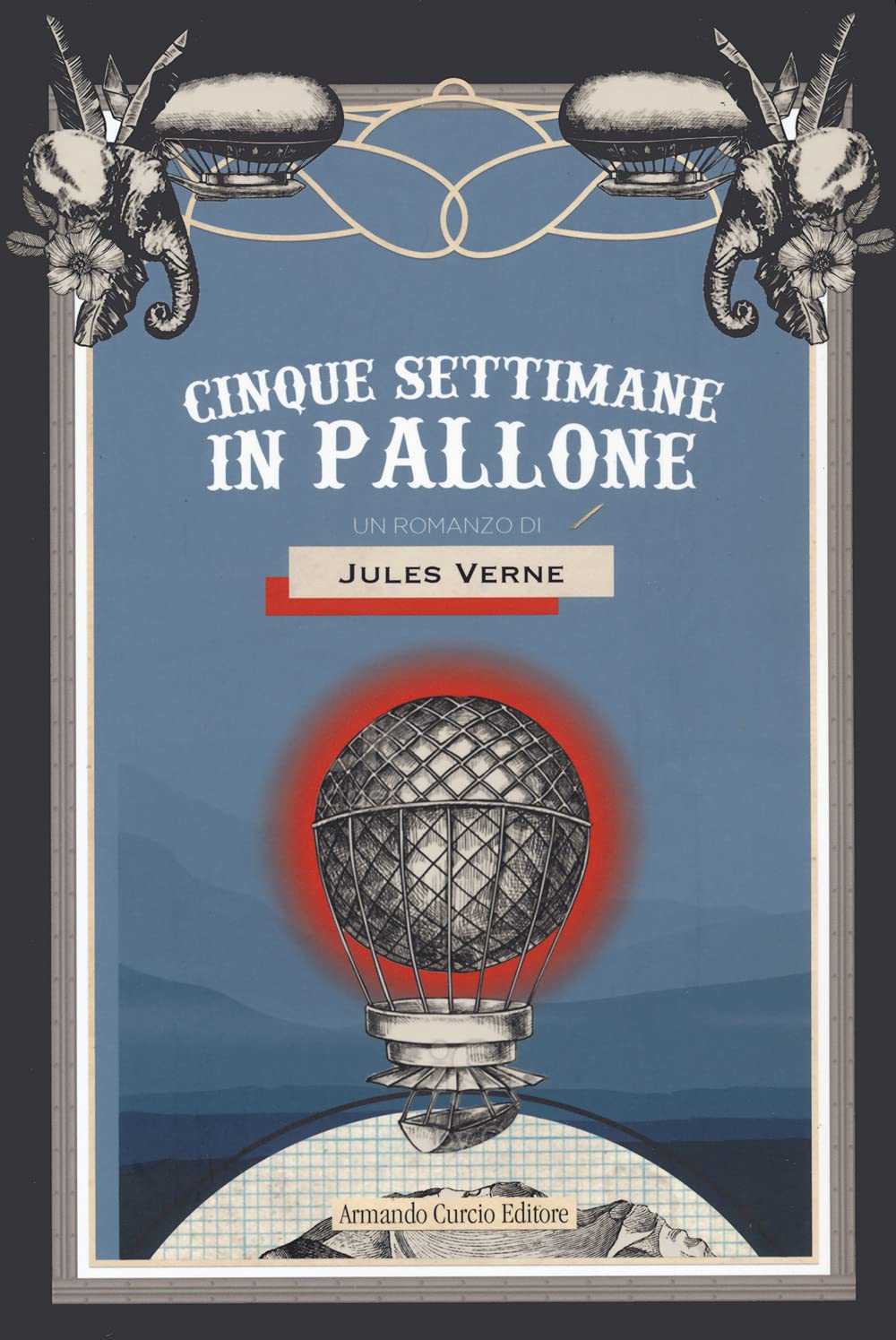
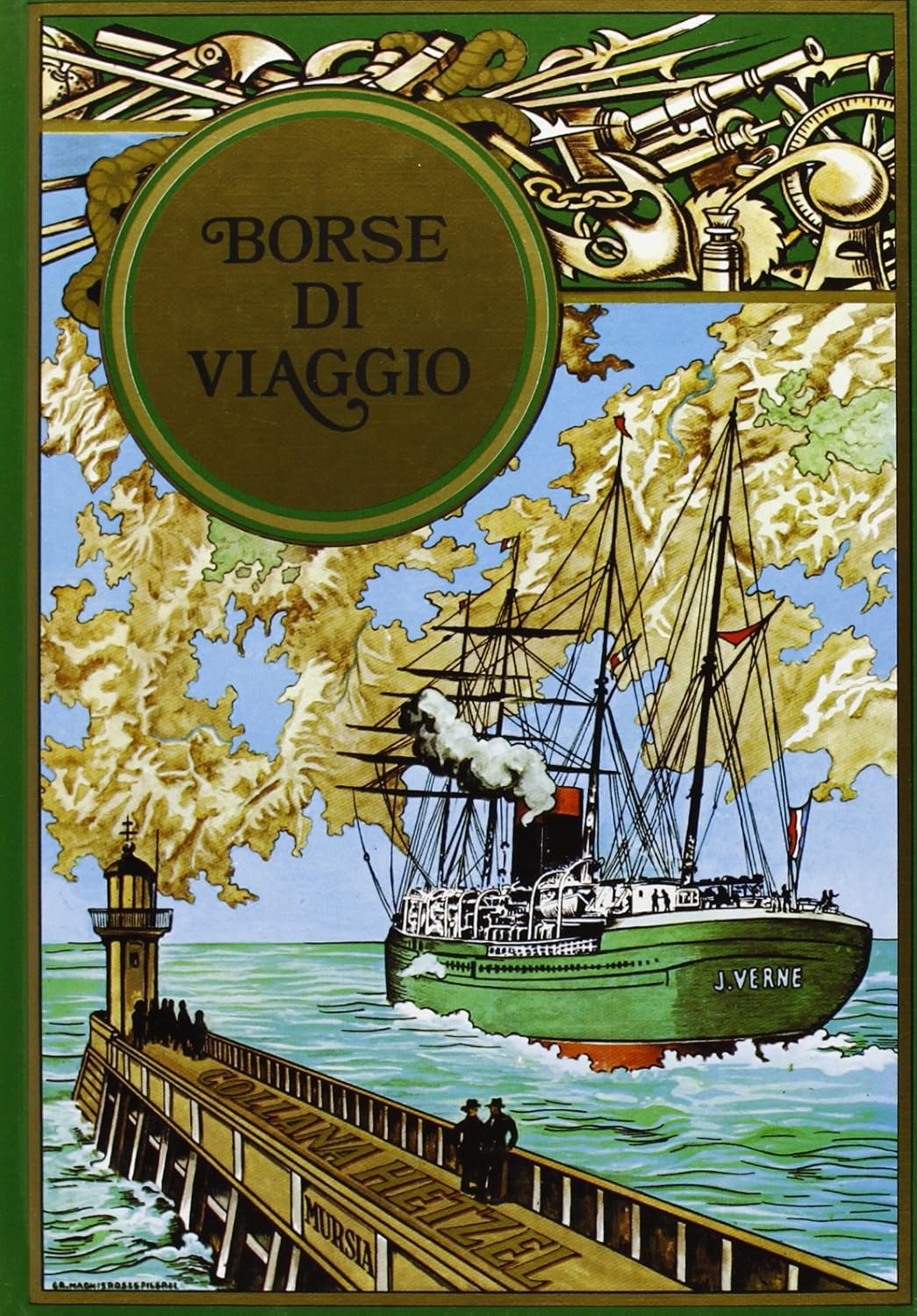
Commento all'articolo