Psicotropici – La febbre dell’ayahuasca nella foresta amazzonica – Jean-Loup Amselle
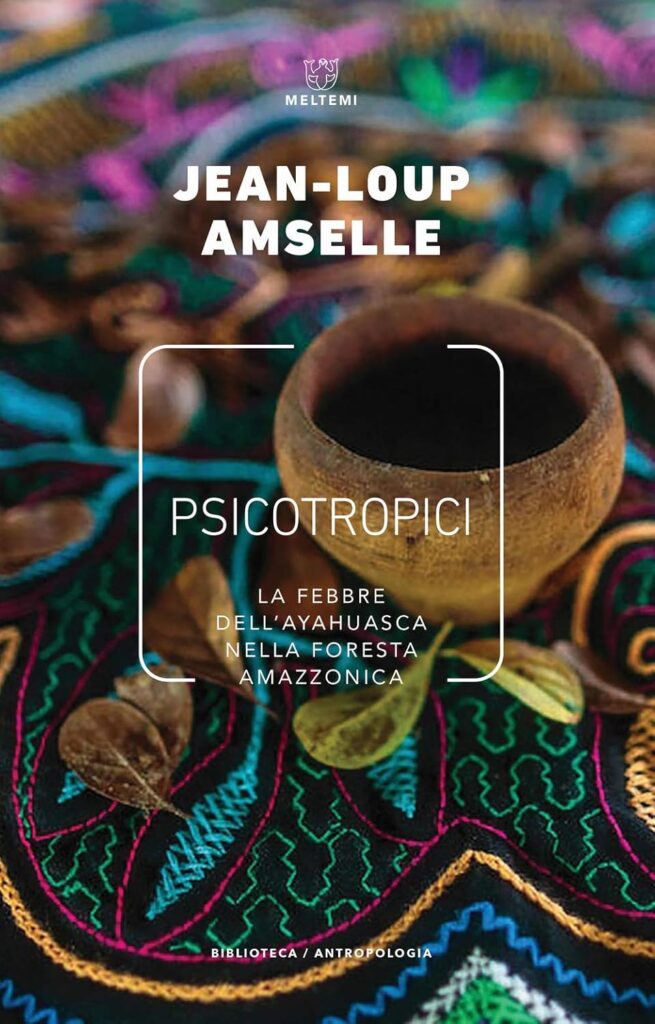
SINTESI DEL LIBRO:
Senza tracciare la genealogia del romanticismo, procedendo a ritroso a
partire dai nostri contemporanei, cioè senza risalire la signi cativa catena
che unisce le teorie e le rappresentazioni attuali agli schemi di pensiero del
XIX secolo, è sorprendente osservare la permanenza di posizioni che
assumono in maniera molto evidente una colorazione particolare
attraverso la riformulazione delle questioni attuali
14. Si è già avuto modo
di dimostrare come il declino del razionalismo sia legato all’impulso del
postmodernismo, dei
cultural studies
e del postcolonialismo
15.
Queste nuove correnti di pensiero, emerse al termine del secolo scorso,
hanno segnato la ne delle grandi narrazioni alle quali hanno sostituito
altri paradigmi che ruotano attorno alle nozioni di cultura e di frammento.
Ma non si tratta qui di dilungarsi sui danni provocati dall’uso
generalizzato del relativismo culturale e dall’abbandono di ogni idea di
unità dell’umanità alla quale conduce. In Lévi-Strauss regnava certamente
l’idea del relativismo culturale, in particolare nei testi redatti su invito
dell’Unesco come
Razza e storia
o
Razza e cultura
1
6
. Ma si poteva trovare
nell’autore delle
Strutture elementari della parentela
un’altra linea di
pensiero, universalistica stavolta, organizzata attorno a categorie
“kantiane” di atomo di parentela, di opposizione tra natura e cultura o di
universalità del divieto dell’incesto
17. A prevalere presso i suoi discepoli
non è stato questo apporto, ma piuttosto un’altra posizione legata
maggiormente alla ricerca di un “pensiero selvaggio” che si potrebbe
individuare sia in seno a qualsiasi “cultura primitiva” sia nel “bricolage”
delle nostre società sviluppate. I suoi successori hanno conservato questo
primitivismo che ogni essere umano porterebbe in sé e che, unito
all’“ecologismo” anticartesiano del maestro, farebbe fondamentalmente
dell’uomo una sorta di “disturbatore” che inquina una natura altrimenti
mantenuta nella sua verginità primigenia.
La speci cità dell’uomo, o meglio dell’umano, è contestata con tenacia
dai suoi seguaci che ri utano di accordare una qualsiasi legittimità alla
distinzione tra “natura” e “cultura” e stimano al contrario che ogni
cultura conceda proprio un trattamento particolare a tale opposizione,
all’occorrenza non attribuendole alcuna rilevanza. Il post-lévi-straussismo,
piuttosto che il post-strutturalismo, è quindi un iperrelativismo. Esige
parità di trattamento, una “carità epistemica” nei confronti di tutte le
culture, ciascuna portatrice di un’“epistemologia” o di un’“ontologia”: ciò
è proprio del relativismo culturale, ma si spinge molto oltre sulla via di un
iperrelativismo generalizzato, accordando un’identità di statuto
epistemico a tutti i “regni”, che si tratti del vegetale, dell’animale o
dell’umano.
All’interno di tale scenario si può così concepire che le piante
amazzoniche “insegnino” o “guidino”, o che gli animali della foresta siano
dotati di forme di pensiero come gli esseri umani che li cacciano. L’uguale
dignità morale o legittimità intellettuale che caratterizza questo
“specismo”, questo animalismo o questo vegetalismo, è al centro di buona
parte della loso a e dell’antropologia contemporanee, perlomeno di
quella in evidenza sul piano istituzionale e mediatico. Si riscontrava già in
Jacques Derrida o Élisabeth de Fontenay, ma in Francia e in una certa
misura negli Stati Uniti è Bruno Latour il vero ispiratore di questa
antropologia “prospettivista”, incarnata tra gli altri dagli antropologi
Marshall Sahlins, Eduardo Viveiros de Castro e Philippe Descola
18.
All’interno di quella che abbiamo chiamato liera sciamanica, non si
può non essere colpiti dalla coerenza intellettuale che unisce questo
discorso anticartesiano, dotto, istituzionalizzato, volto a sottrarre all’uomo
il controllo e il possesso della natura, a quello del piano inferiore,
occupato dai promotori dell’ayahuasca come Jan Kounen, Jeremy Narby o
Vincent Ravalec. Benché questi due ambienti si ignorino e gli antropologi
professionisti non attribuiscano grande rilevanza a questi “declassati”, o
autodidatti, resta il fatto che in una forma meno so sticata o accademica si
difendono le stesse idee, in una sorta di misticismo new age che è comune
al mondo dotto e all’ambiente dei propagatori della fede sciamanica.
Nessuna cesura esiste quindi tra lo studente, o l’ex studente, di
antropologia che non ha trovato lavoro nella professione, lo scrittore o il
cineasta “convertito” all’ayahuasca e allo sciamanesimo e il ricercatore
universitario amazzonista seguace di un’antropologia del
dark side, della
forza oscura emanata dalle piante e dagli animali della foresta. Ed è lungo
tutta la liera sciamanica che si ritroveranno questi schemi di pensiero,
presso coloro che io chiamo gli “imprenditori sciamanici”, presso i
guaritori di ogni genere, come pure presso le diverse categorie di turisti.
Di fronte a questo ritorno in forza di una certa forma di “irrazionalismo”,
a questo ri uto di ogni approccio storicizzante delle culture esotiche, ci si
può chiedere se sia opportuno operare una distinzione tra un’antropologia
del turismo e un turismo antropologico, o se l’insieme degli attori della
liera sciamanica non rientri in questo stesso universo romantico.
Da
altri mondi
È alla luce del prospettivismo contemporaneo che possiamo “rileggere”
o dare una nuova giovinezza alle idee romantiche del XVIII e del XIX
secolo, nonché alla loro variazione all’interno del discorso
new age dei
turisti sciamanici.
Alla base del romanticismo c’è l’idea che all’uomo il mondo stia stretto e
debba perciò volgersi verso altri universi
19.
Deve sbarazzarsi, in
particolare, della zavorra scienti ca e tecnica di cui è gravato da quando
ha raggiunto lo stato civilizzato ed essere più sensibile alle inuenze
spirituali e cosmiche e anche alle proprietà nascoste dei minerali, delle
piante e degli animali
20. Entrare in contatto con il cosmo, captare l’energia
spirituale che si sposta dall’India verso le Indie Occidentali, o entrare in
relazione con la parte femminile dell’essere, questo sembra essere
l’ordinario dello sciamanesimo e del turismo new age, che riproduce così
la gura romantica della distruzione del mondo materiale come mezzo di
accesso all’universo spirituale
21.
La veggenza appare anche nel XIX secolo come il mezzo privilegiato per
comunicare con il “pluri-” o il “multiverso”
22 e, a questo proposito, il caso
della “veggente di Prevorst” osservato da Justinus Kerner (1786-1862) è
certamente paradigmatico. Questo medico registra infatti le visioni di una
ragazza della foresta soggetta a sonnambulismo, che accoglie in casa dal
1826 al 1829. Kerner consulta vari dotti e medici dell’epoca che si
sforzano di integrare questa esperienza nell’enciclopedia romantica del
sapere. La veggente di Prevorst diventa così l’esempio stesso della
personalità cosmica accordata a tutte le risonanze dell’universo e il
simbolo della comunicazione possibile con altri mondi, in particolare
quello dei morti. Schelling (1775-1854), il cantore della
Naturphilosophie,
che vanta le simpatie cosmiche di cui bene cerebbero le prime comunità
umane vicine alla natura, è anche lui un seguace della veggenza. Egli cerca
così, dopo la morte della sua amata moglie, di mantenere il contatto con
lei. Da parte sua, Victor Hugo, profondamente sconvolto dalla scomparsa
di sua glia Léopoldine nel 1843, si converte allo spiritismo e tenta grazie
alla pratica delle tavole Ouija, messa in opera durante il suo esilio nel
Jersey, di riallacciare il legame con lei.
Come non ritrovare un’eco di quest’atteggiamento romantico nel
racconto di Corine Sombrun sul dolore provato a seguito della morte
della sua compagna e della sua volontà di ritrovarla grazie a un soggiorno
nell’Amazzonia peruviana? Durante tale soggiorno, assume dell’ayahuasca
sotto la guida di un guaritore-sciamano e riesce così a ristabilire il contatto
con la sua amica scomparsa
23.
Allo stesso modo, Amélie Nothomb, che sente delle “voci” n
dall’infanzia, dopo aver sperimentato i funghi allucinogeni, si reca in Perù
per assumere l’ayahuasca. Durante le “cerimonie” alle quali partecipa,
comunica con lo spirito della pianta e può così conversare con esseri
scomparsi
24.
Lo stesso Jan Kounen, noto cineasta e promotore dell’ayahuasca, ritorna
in Amazzonia dal suo amico sciamano Guillermo Arévalo per riavvicinarsi
al padre recentemente scomparso: “A un certo punto, durante una
cerimonia, ci sono nito dentro. Non ho avuto un contatto esoterico; ho
raggiunto il sentimento che mi lega a mio padre, immediatamente”
25.
Altro caso della stessa natura è quello di Élodie (trentotto anni) che
soggiorna anch’essa al centro Espíritu de Anaconda
26,
diretto da
Guillermo Arévalo, per curare un trauma infantile riaf orato alcuni anni
prima
27. Secondo lei, questo trauma è legato alla perdita, avvenuta all’età
di quattro anni, di una sorellina deceduta in incubatrice dopo una nascita
prematura. Élodie aveva iniziato a disegnare le partecipazioni di nascita
della sorella e si era recata alla clinica per vederla, ma non aveva potuto
toccarla perché era protetta dall’incubatrice. La sorellina morì poco dopo
ed Élodie continuò a vivere normalmente, convinta di non essere stata
turbata da quella scomparsa, nché nel 2005 entrò in una fase depressiva
e si rifugiò in campagna. È allora che sfogliando un dizionario cade sul
termine “abreazione”. Non essendo soddisfatta dalla scoperta di questa
parola che esprime imperfettamente il suo desiderio di connettersi con
tutti gli esseri viventi o morti, ha avviato una ricerca spirituale e loso ca
che l’ha condotta a Lao Tse, Spinoza e Deleuze e da lì ha scoperto,
attraverso
D’autres mondes, il lm di Jan Kounen sullo sciamanesimo
amazzonico, l’esistenza di Guillermo Arévalo e del centro Espíritu de
Anaconda.
Alan Shoemaker, cittadino americano sposato con una peruviana e
residente a Iquitos, è una gura centrale della scena sciamanica
amazzonica. Organizzatore di un seminario annuale a pagamento
sull’ayahuasca e associato a sciamani-guaritori peruviani “meticci”, ha
pubblicato sul suo sito web un racconto della sua iniziazione allo
sciamanesimo amazzonico che evoca in modo immagini co la sua rimessa
in discussione della razionalità occidentale e la sua scoperta dell’accesso
ad “altri mondi” attraverso l’arte dei guaritori
28.
In una scena degna di
Star Wars, narra il modo in cui è riuscito, dopo
aver assunto dell’ayahuasca sotto il controllo del suo maestro Don Ramon,
a “visualizzare” la moglie di quest’ultimo, al ne di identi care il
trattamento richiesto dalla malattia misteriosa di cui soffre.
L’intero racconto è un’ode a questo “mondo che abbiamo perduto”,
quello della spiritualità e della magia, annientato più di cinquecento anni
fa dalla colonizzazione europea e che ci fa dubitare dell’esistenza di un
universo nascosto e inaccessibile ai nostri poveri sensi di occidentali
positivisti. Secondo lui, agli scienziati ci sono voluti centinaia di anni per
scoprire il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg, secondo il
quale l’osservatore agisce sull’oggetto osservato, mentre gli sciamani
conoscono questo principio da sempre. E Alan Shoemaker ha enunciato
la profezia secondo la quale, nei prossimi cinquecento anni, assisteremo al
ritorno dello sciamanesimo dei nostri antenati: ciò ci permetterà di
ripristinare un trattamento “olistico” di tutti i nostri mali, unendo, in uno
stesso movimento, la cura dell’anima, della mente e del corpo delle nostre
persone.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :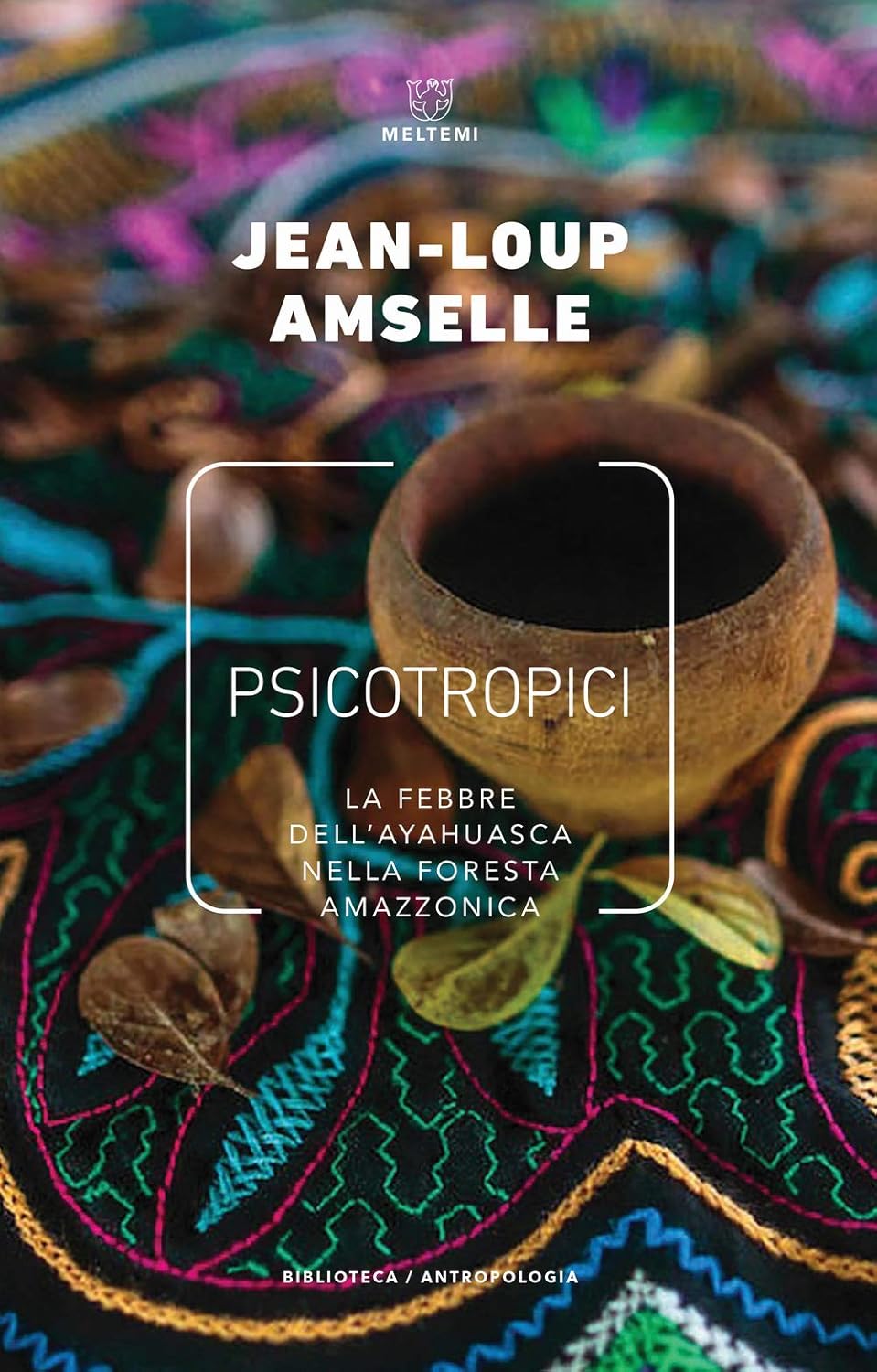





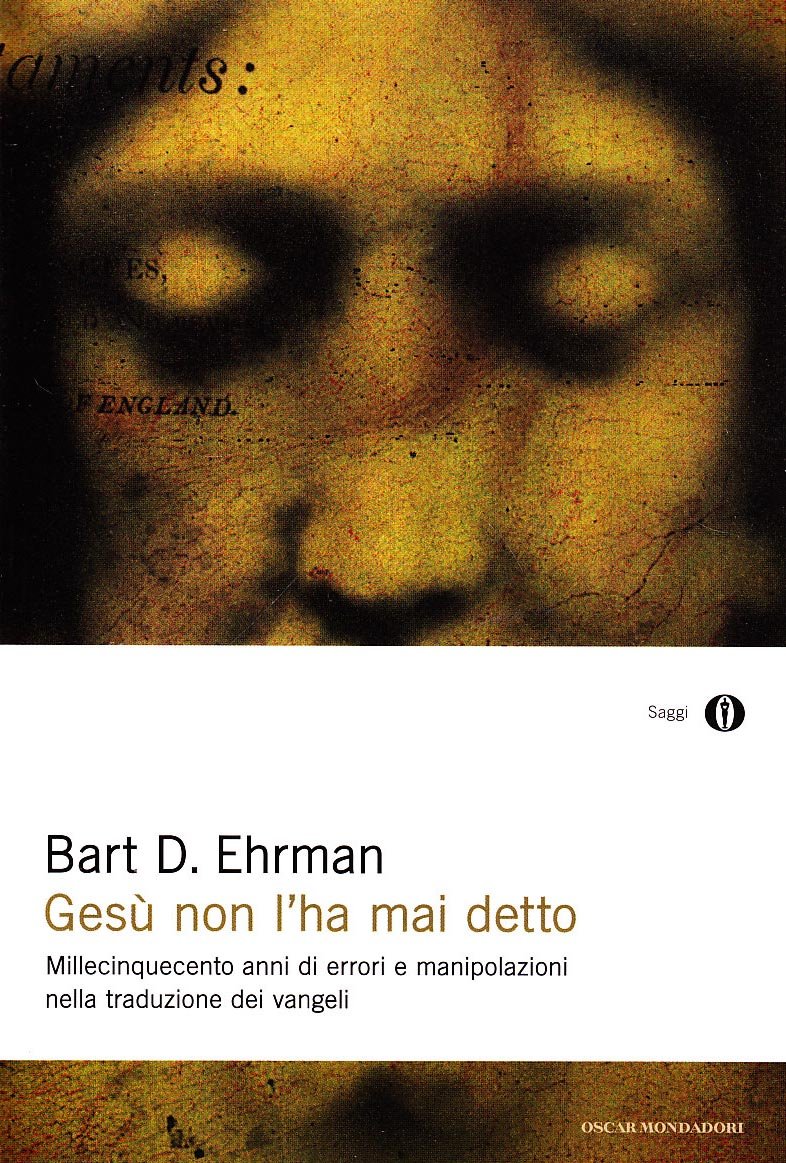
Commento all'articolo