Imparare a parlare con le piante – Marta Orriols

SINTESI DEL LIBRO:
Eravamo vivi.
Gli attentati, gli incidenti, le guerre e le epidemie non ci
riguardavano. Potevamo vedere film che banalizzavano l’atto della
morte, altri che lo presentavano come un atto d’amore, ma noi
eravamo fuori dalla zona che conteneva il significato specifico di
perdere la vita.
Alcune sere, a letto, avvolti dal comfort di enormi e soffici cuscini,
e nell’arroganza della nostra gioventù tardiva, guardavamo il
telegiornale nella penombra, con i piedi intrecciati, ed era in quei
momenti che la morte, senza che noi lo sapessimo, si accomodava
azzurrognola sulle lenti degli occhiali di Mauro. Centotrentasette
persone
muoiono
a
Parigi
negli
attacchi
rivendicati
dall’organizzazione terroristica dello Stato Islamico, sei morti sulle
strade in meno di ventiquattr’ore in tre diversi scontri frontali,
l’esondazione di un fiume causa quattro morti in un piccolo paese
nel Sud della Spagna, almeno settanta morti in una catena di
attentati in Siria. E noi, che ci sconvolgevamo per un momento, forse
dicevamo qualcosa del tipo ‘Accidenti, come va il mondo’, o
‘Poveraccio, che sfortuna’, e la notizia, se non aveva una forza
particolare, svaniva quella sera stessa tra le pareti della camera da
letto di una coppia che, anch’essa, si stava pian piano estinguendo.
Cambiavamo canale e guardavamo la fine di un film, e nel frattempo
io gli comunicavo a che ora sarei arrivata il giorno dopo o gli
ricordavo di passare in tintoria a prendere il cappotto nero; se era
giornata, negli ultimi mesi, forse cercavamo di fare l’amore, ma di
malavoglia. Se la notizia era più eclatante, gli effetti su di noi
duravano un po’ di più, ne parlavamo al lavoro durante la pausa
caffè o al mercato, in fila al banco del pesce.
Ma noi eravamo vivi, la morte era degli altri.
Usavamo espressioni come sono morto per esprimere la
stanchezza dopo una giornata di lavoro molto dura senza che
l’aggettivo ci ferisse l’anima. Quando ci eravamo appena messi
insieme, eravamo capaci di galleggiare in mezzo al mare, nella
nostra cala preferita, e scherzare, con le labbra piene di sale e di
sole, su un ipotetico annegamento che finiva con un bocca a bocca
impetuoso accompagnato da risate. La morte non ci apparteneva.
Quella che avevo vissuto da piccola – mia madre si era ammalata
ed era morta pochi mesi dopo – era diventata un ricordo confuso che
non faceva più male. Mio padre era venuto a prendermi a scuola
quando era trascorsa appena un’ora dalla ripresa delle lezioni dopo
pranzo. A centinaia, bambini e bambine, eravamo saliti lungo le
scale a chiocciola per tornare nelle aule dalla mensa comune, in
mezzo alla sfrenatezza propria della vita che passa mentre da
qualche parte tutto si ferma. Mio padre arrivò in classe
accompagnato dalla direttrice, che bussò alla porta proprio nel
momento in cui il maestro di Scienze naturali aveva finito di spiegarci
la differenza tra gli animali vertebrati e quelli invertebrati. Il ricordo
della morte di mia madre è rimasto per sempre legato alla scritta
bianca di gesso, sul verde della lavagna, che divideva in due il regno
animale. C’erano anche tutti quegli sguardi nuovi di quelli che fino ad
allora erano stati miei pari, e io, immobile, sentivo che mi stavo
ritirando in un terzo regno, quello degli animali feriti a cui mancherà
sempre una madre.
Quella morte ci aveva avvisati, anche se non per questo era stata
meno terribile, e in quell’avviso c’era il margine di tempo che la
precedeva, lo spazio per il commiato e le volontà, la prostrazione e
l’opportunità di esprimere tutto l’amore. C’erano, soprattutto,
l’ingenuità di credere al Cielo, in cui me la disegnavano, e
l’innocenza dei miei sette anni, che mi salvava dal comprendere la
categoricità della sua dipartita.
Io e Mauro siamo stati insieme per tanti anni. Poi, e solo per poche
ore, non ci siamo più stati. È morto di colpo qualche mese fa, senza
preavviso. Quando la macchina l’ha investito, ha portato via lui e
tante altre cose.
Senza Cielo né conforto, con tutto il pesante dolore proprio dell’età
adulta, per evitare di parlare di Mauro al passato, spesso penso e
parlo usando gli avverbi prima e dopo. C’è una barriera fisica. Era
vivo quel giorno a pranzo con me, ha bevuto del vino e ha chiesto al
cameriere di cuocergli un po’ di più il filetto, ha risposto a un paio di
telefonate della casa editrice mentre giocherellava con il
portatovagliolo, mi ha scritto, dietro al bigliettino del ristorante, il titolo
del
libro
di
un’autrice
francese
che
mi
consigliava
appassionatamente, si è grattato il lobo dell’orecchio sinistro, con
imbarazzo, o forse con vergogna, e poi me l’ha detto. Balbettava,
quasi. Poche ore dopo era morto.
Il
ristorante aveva nel logotipo un pezzo di corallo. Lo guardo
spesso. Conservo il bigliettino su cui, con quella scrittura
immacolata, ha scritto il titolo del libro che gli era piaciuto così tanto.
Forse perché ognuno è libero di abbellire la propria disgrazia con
tutto il fucsia, il giallo, il blu e il verde che gli chiede il cuore, dal
giorno dell’incidente penso al prima e al dopo della mia vita come
alla Grande Barriera Corallina, lo scoglio di coralli più grande del
mondo. Ogni volta che penso se una cosa è successa prima o dopo
la morte di Mauro, faccio uno sforzo per immaginare la barriera
corallina, per riempirla di pesci colorati e stelle marine e farne un
equatore della vita.
Quando la morte non appartiene più agli altri, è necessario trovarle
un posto, con cura, dall’altra parte dello scoglio, perché altrimenti
occuperebbe tutto lo spazio con assoluta libertà.
Morire non è mistico. Morire è fisico, è logico, è reale.
1
«Pili, controlla il monitor, veloce! Respira?»
«No».
«Iniziamo ventilazione con pressione positiva».
Ripeto a bassa voce le costanti della bambina, come una litania.
‘Lo so, piccola. Non è questo il modo di riceverti, ma devi respirare a
tutti i costi, mi senti?’
«Trenta secondi». ‘Uno, due, tre… là sdraiata c’è una donna, che
è tua madre e che senza di te non ce la farà, la vedi? Forza, su,
dieci, undici, dodici, tredici… dai, respira, fai uno sforzo, ti assicuro
che se superi questa prova la cosa cambia, ci si sta bene, qui.
Diciassette, diciotto, diciannove, venti. Vale la pena vivere, sai?
Ventitré, ventiquattro… a volte è faticoso, non te lo nascondo,
ventisei, ventisette, su, bella, non mi fare questo. Ti assicuro che ne
vale la pena. Trenta’.
Silenzio. La piccola non si muove.
«Pili, frequenza cardiaca?»
Incrocio lo sguardo vigile dell’infermiera. È la seconda volta che mi
succede nel giro di poco, e conosco quello sguardo di avvertimento.
Ha ragione, non dovrei alzare così tanto la voce con lei, non dovrei
alzarla proprio. Non sto comoda. Ho caldo e lo zoccolo del piede
destro mi struscia su una vescichetta che mi hanno fatto venire i
sandali negli ultimi giorni delle vacanze. Minuti cruciali, subito dopo
la nascita; la vescica e questo caldo non ci vogliono proprio. Per la
neonata, invece, è una priorità assoluta evitare la perdita di calore.
Forse non è stata una buona idea partire all’alba e venire
direttamente in ospedale senza passare per casa a disfare le valigie
e a togliermi di dosso questa strana sensazione di aver passato
quasi due settimane fuori, lontano dal lavoro, dalle cartelle cliniche
dei miei bambini, dalle analisi, dal laboratorio, lontano da tutto ciò
che mi fa andare avanti.
Nuova decisione. Stimolo con movimenti brevi e veloci le piante
dei piedi della bimba e, come al solito, mi trattengo dall’istinto di
colpire più forte, con più urgenza. ‘Non mi puoi fare questo, non
posso iniziare così settembre, dai, forza, respira, bella’.
Riconsiderazione.
Cerco di concentrarmi sulle informazioni del monitor e sulla
piccola, ma ho bisogno di chiudere gli occhi un secondo, perché non
posso tapparmi le orecchie, e le domande che lancia la madre, che
risuonano come un gemito sconsolato nella sala parto, mi
disorientano come non mai. La sofferenza degli altri per me, adesso,
è come la visione di un piatto colmo dopo un pasto abbondante. Non
mi entra più e mi causa repulsione. Tutti i suoni di afflizione si
trasformano in quelli della madre di Mauro il giorno del funerale.
Laceravano l’anima.
‘Respira, piccola, su, dai, per l’amor del cielo, respira!’
Corrugo la fronte e scuoto la testa per ricordarmi che qui non si
evocano questioni difficili da gestire. Qui non si evoca. Qui non si
ricorda. Qui no, Paula. Concentrati. La realtà mi piomba addosso
come un secchio d’acqua fredda e mi fa tornare subito al mio posto:
ho davanti un corpo di soli ottocentocinquanta grammi che non inizia
a respirare, steso sulla culla per la rianimazione, ed è nelle mie
mani. Non ci metto molto a percepire l’attivazione del sesto senso,
che sta diventando sempre più spesso la mia guida, qualcosa di
simile all’equilibrio tra l’oggettività più estrema in cui trattengo
protocolli e ragionamento e l’astuzia intellegibile dell’intuizione,
senza la quale, ne sono certa, non potrei accompagnare l’arrivo al
mondo di questi esseri minuscoli. ‘Ascolta, piccola, una delle cose
per cui vale la pena vivere è il mare’.
«Pili, arresto la ventilazione. Provo con la stimolazione tattile sulla
schiena».
Inspiro profondamente ed espiro come se mi preparassi a saltare
nel vuoto. La mascherina fa da muro e trattiene un’esalazione,
miscuglio del fluoro del dentifricio che ho trovato stamattina in bagno
a casa di mio padre e del caffè veloce e amaro che ho bevuto in
un’area di servizio in autostrada. Mi mancano le mie cose, la mia
normalità. Mi mancano il caffè e la mia caffettiera. L’odore di casa, i
miei ritmi, il non dover dare spiegazioni e il poter fare quello che
voglio.
Le sfrego la schiena minuscola nel modo più delicato di cui sono
capace.
‘Il mare ha un ritmo, lo senti? Fa così: va e viene, va e viene. Senti
le mie mani? Le onde vanno e vengono, così. Dai, bellissima, il mare
è proprio da vedere, ci sono anche altre cose, ma adesso
concentrati sul mare, così, piano, lo senti?’
«Respira».
Il primo urlo è stato come un miagolio, ma nella sala l’abbiamo
accolto con la gioia con cui si accoglie un temporale estivo.
«Benvenuta…» Non so bene se lo dico alla bambina o a me
stessa, ma devo fare uno sforzo per trattenere l’emozione.
La pulisco con movimenti veloci, eseguiti centinaia di volte. Mi
tranquillizza vedere che il colore migliora, che quella pelle
trasparente prende un tono roseo pieno di speranza.
«Frequenza cardiaca?»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




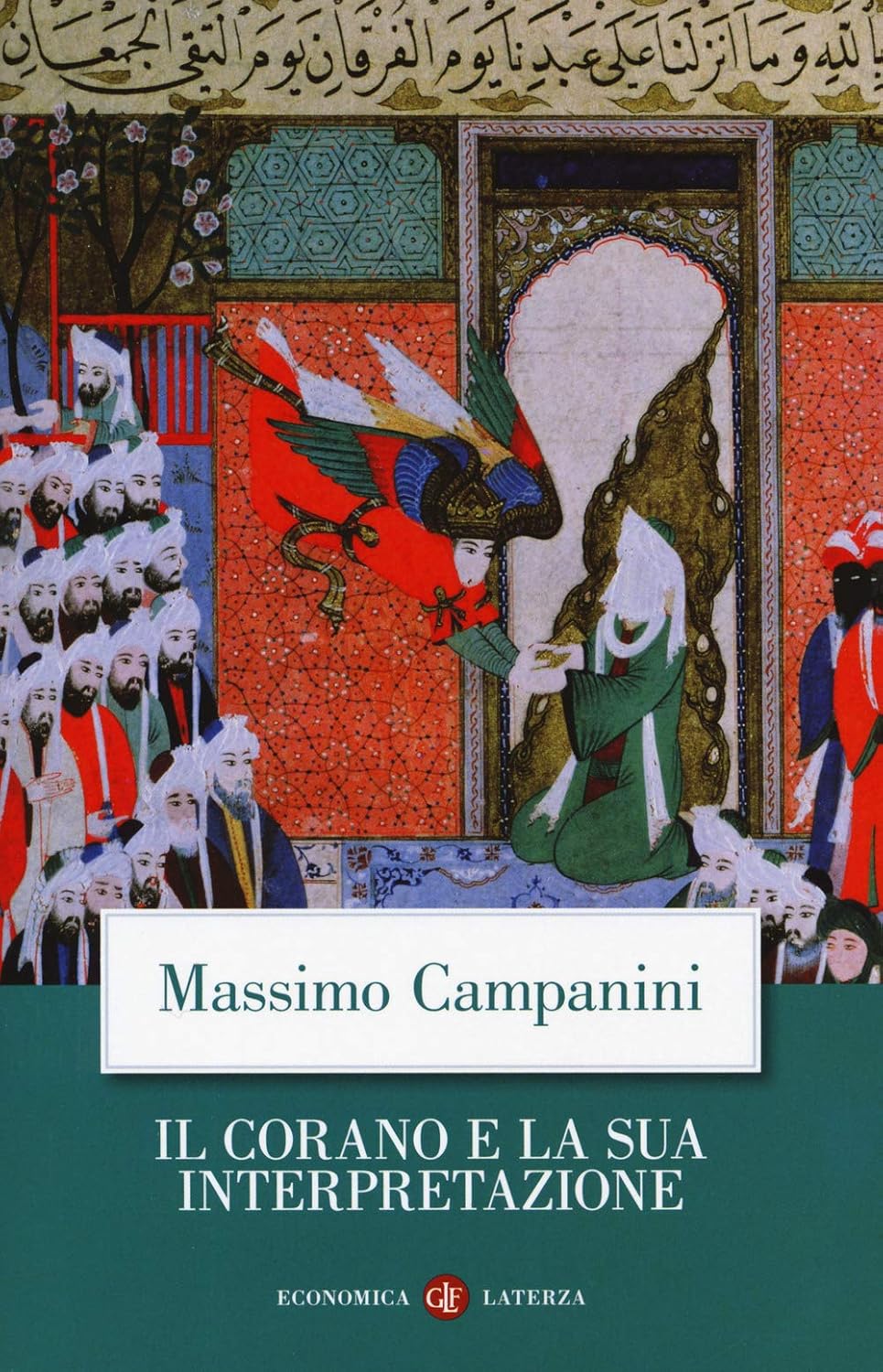
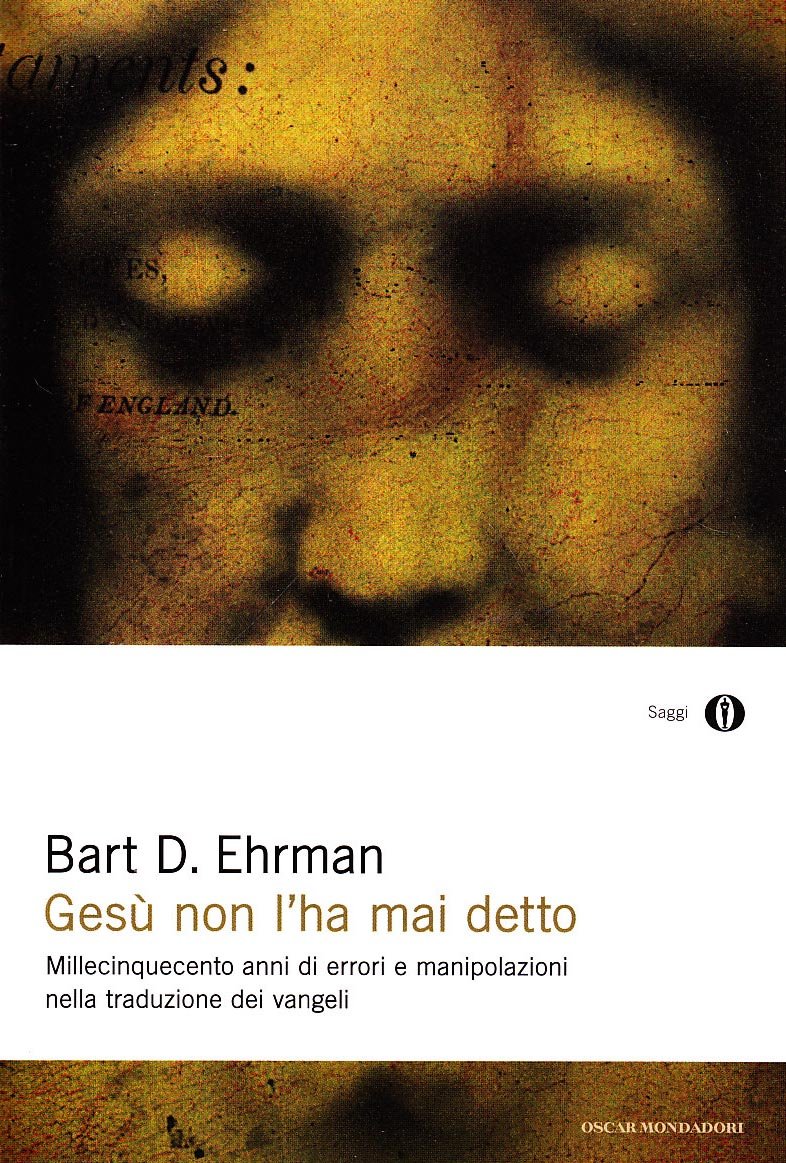
Commento all'articolo