Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia – Eric Gobetti

SINTESI DEL LIBRO:
Un Crollo in sette giorni [Jeri 1941.]
«Tutto fu risolto nella stretta di sette giorni: 6 aprile le Palme, 13 aprile
Pasqua»
11
. Così la propaganda italiana descrive la guerra contro la
Jugoslavia, vinta senza nemmeno combattere: una «marcia per le dinariche
che resterà nella storia dei fatti di guerra come un capolavoro di rapidità e
di precisione»
12
. In realtà per una settimana l’esercito italiano assume uno
schieramento difensivo, sia nell’Albania settentrionale, nel timore –
fondato – di un tentativo jugoslavo di prendere alle spalle le truppe
impegnate a sud contro la Grecia, sia sul fronte Giulio, dove la II armata
esita ad avanzare nonostante l’evidente superiorità di mezzi. Nel frattempo
i tedeschi, dopo aver bombardato Belgrado all’alba del 6 aprile 1941,
avanzano rapidamente su diverse direttrici e puntano verso la Grecia. Il 10
occupano Zagabria, il 12 Belgrado. Quello stesso giorno una colonna
motorizzata italiana raggiunge Lubiana. Solo il 17 aprile, giorno in cui
l’esercito jugoslavo firma la resa, le truppe italiane arrivano a Mostar,
Dubrovnik e Cetinje. Il Kosovo viene occupato alla fine delle ostilità. Le
principali località sono state raggiunte a tappe forzate, talvolta dopo il
passaggio delle colonne tedesche, incontrando come unico ostacolo masse
di soldati sbandati, «intere compagnie e gruppi isolati, che col fucile a
tracolla ed un grosso zaino sulle spalle»
13
ritornano alle proprie case. La II
armata conta appena una trentina di caduti
14
.
Alla vigilia dell’invasione, nella primavera del 1941, lo Stato jugoslavo ha
poco più di vent’anni. Nato nel 1918 col nome di Regno dei Serbi, Croati
e Sloveni (Shs), ha assunto la denominazione di Jugoslavia nel 1929. Essa
include realtà territoriali molto diverse fra loro, attraversate da complesse
fratture linguistiche, religiose, nazionali, geografiche, economiche e
storico-culturali, spesso intrecciate fra loro. Tutto ciò in una fase storica
nella quale si vanno consolidando, contrapponendosi, le diverse
appartenenze nazionali. In questo complesso scenario vanno segnalati
alcuni elementi rilevanti: la presenza di due gruppi nazionali maggioritari,
serbi e croati; la peculiare condizione della comunità slavo-musulmana,
residuo storico del prolungato dominio ottomano nell’area, residente
soprattutto nelle aree centrali del paese (Bosnia e Sangiaccato); la
significativa presenza di vere e proprie minoranze nazionali non assimilabili
agli slavi del Sud. Fra queste ultime, alcune sono stanziate vicino ai confini
di possibili «madrepatrie», come gli ungheresi, i rumeni e gli albanesi; altre,
come le comunità volksdeutsche (germanofona) ed ebraica, sono presenti un
po’ su tutto il territorio, ma soprattutto nel Nord e nelle grandi città
15
.
A causa di questa complessità antropologica la Jugoslavia viene spesso
dipinta dalla propaganda fascista come una «ibrida creazione di
Versaglia»
16
, per sottolinearne il carattere artificiale. Ancora oggi prevale la
sensazione che tale entità statale, prima e dopo la Seconda guerra
mondiale, sia stata il frutto di (errati) calcoli diplomatici e di complesse
mediazioni fra i diversi interessi nazionali, considerando questi ultimi il
vero e unico motore delle vicende storiche del Novecento. Si dimentica
però che percezioni identitarie localiste, jugoslaviste o panslaviste avevano
e hanno ampia diffusione fra tutti i popoli jugoslavi, e si sono andate
affermando in parallelo e non necessariamente in competizione con quelle
nazionaliste, con un processo che si può definire di «cerchi concentrici
identitari»
17
.
Fra le due guerre il regno dei Karadjordjević rappresenta di fatto un
tentativo di sintesi fra l’ideologia politica jugoslavista e la volontà
espansionista del regno serbo uscito vincente dalla Grande Guerra. La
principale frattura politica esistente fra le leadership serbe e croate
evidenzia proprio una diversa interpretazione dell’idea jugoslavista, intesa
dalla classe dirigente di Belgrado come un escamotage per includere e
assimilare le altre popolazioni slave. La scelta centralista provoca infatti fin
da subito forti tensioni interne, in particolare nei rapporti con gli
indipendentisti montenegrini (nell’immediato primo dopoguerra) e i
separatisti croati e macedoni (nel corso degli anni Venti). A partire dal
1929 viene poi del tutto a mancare ogni volontà di soddisfare le istanze
federaliste delle minoranze nazionali. Mediante una sorta di colpo di Stato
monarchico, re Alessandro I impone uno jugoslavismo integrale ispirato al
principio dello Stato-nazione, imponendo un’impronta prevalentemente
serba al paese.
La Jugoslavia però non si disgrega da sola come preconizzato da molti
osservatori dell’epoca. Anzi, nel 1939, attraverso un accordo bilaterale tra
leadership serba e croata (sporazum) viene costituita un’unica grande
banovina (provincia) croata. Tale entità amministrativa, che include gran
parte dell’Erzegovina, soddisfa in buona misura le istanze nazionaliste
croate, risolvendo così il principale conflitto interno. È tuttavia il contesto
internazionale a trascinare il paese in guerra, nonostante gli enormi sforzi
compiuti dal governo di Belgrado per mantenere il paese nella neutralità
18
.
Sottoposto a pressioni crescenti da parte della Germania nazista, nel marzo
del 1941 il reggente Paolo si risolve a sottoscrivere il patto Tripartito. Un
connubio di manifestazioni di piazza, attività sobillatrice dei servizi segreti
inglesi e colpo di Stato militare provoca la caduta del governo e la
proclamazione della maggiore età del re sedicenne Pietro II
19
. Mentre la
folla sfila per le strade al grido di «meglio la guerra che il patto, meglio la
tomba che la schiavitù», il primo ministro britannico Winston Churchill
dichiara: «Nelle prime ore di stamane il popolo jugoslavo ha ritrovato se
stesso»
20
. Pochi giorni dopo la diplomazia italiana definirà il colpo di Stato
di Belgrado: «La pistola che ha suicidato la Jugoslavia»
21
. È il 27 marzo
1941. Non passano nemmeno due settimane quando, nonostante gli sforzi
del nuovo governo jugoslavo di manovrare fra la diplomazia tedesca,
britannica e sovietica, gli stukas appaiono sul cielo di Belgrado. È la fine
della cosiddetta «prima Jugoslavia».SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
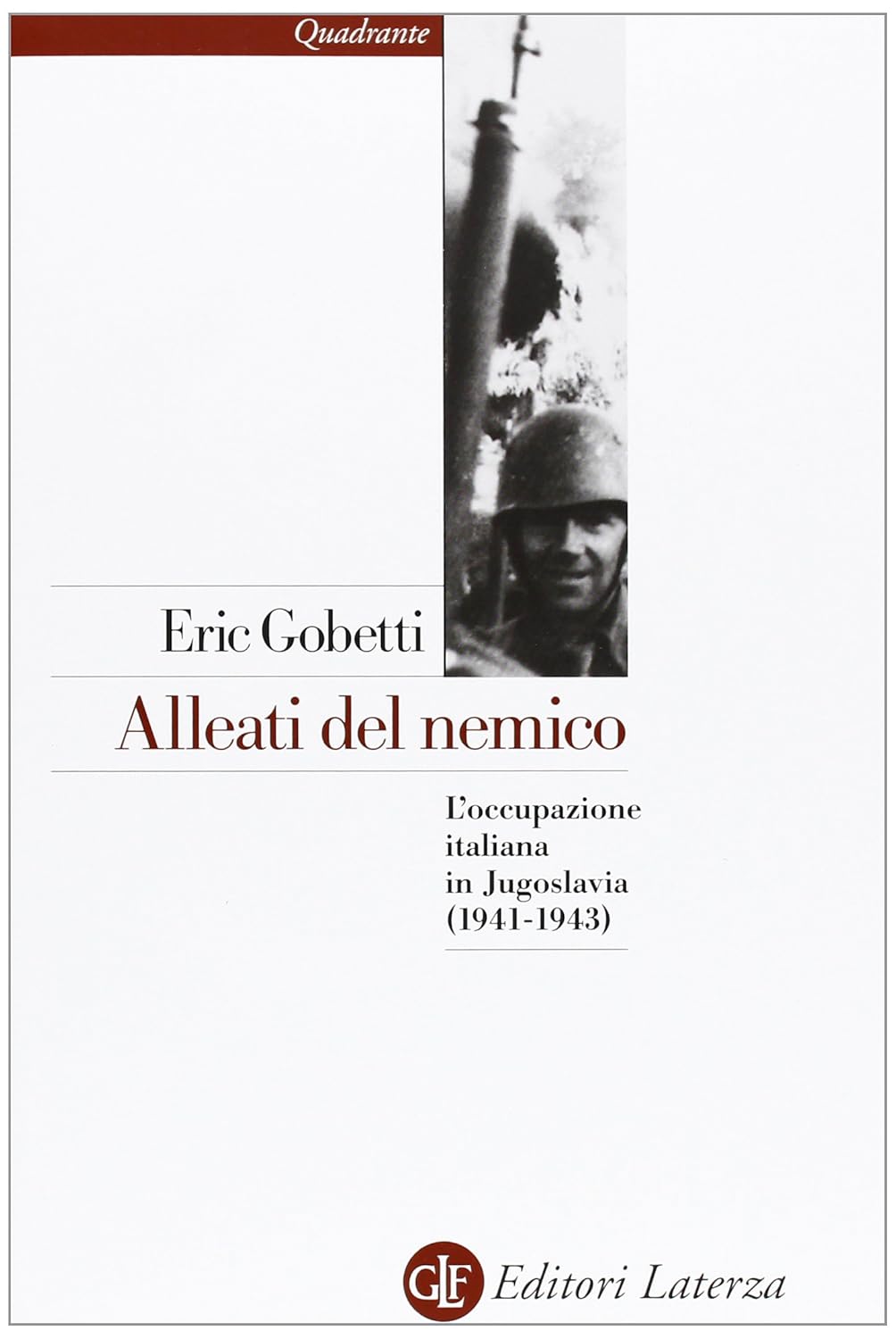






Commento all'articolo